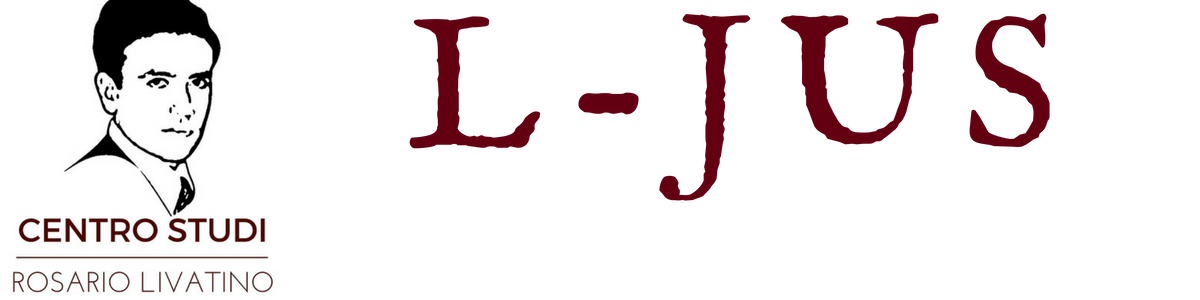Paolo Valiante
Giudice al Tribunale di Salerno
Sommario: 1. La Corte costituzionale sull’art. 580 c.p.: gli incerti delle pronunce manipolative in materia penale ‒ 2. Oltre i “limiti dell’impugnazione” ‒ 2.1. Segue. a) l’ordinanza n. 207 del 2018 ‒ 2.2. Segue. b) la sentenza n. 242 del 2019 ‒ 3. Una sentenza “erga omnes” o “inter partes”? ‒ 4. Dalla uguaglianza dei malati alla disuguaglianza degli agevolatori ‒ 5. Riserva di legge e determinatezza alla prova della manipolazione del precetto penale ‒ 6. Uno strano assorbimento ‒ 7. Conclusioni.
- La Corte costituzionale sull’art. 580 c.p.: gli incerti delle pronunce manipolative in materia penale
È trascorso circa un anno da quando la Corte costituzionale, con la sentenza n. 242 del 25 settembre 2019 (dep. 22 novembre 2019), ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. Non è più tempo, dunque, di commentarne ulteriormente il merito, sul quale, peraltro, numerosi ed autorevoli pareri sono immediatamente intervenuti e si sono susseguiti.
Piuttosto, è il tempo dopo il quale (la c.d. “giusta distanza”) possiamo guardare agli effetti della sentenza non più sotto la lente particolare del caso Cappato, ma nel contesto generale su cui la dichiarazione di incostituzionalità dovrebbe per definizione dispiegare i suoi effetti. Operazione – questa – a maggior ragione necessaria, se si considera, come probabilmente emergerà nel prosieguo, che la pronuncia risente della sua formulazione tutta parametrata sul caso concreto anziché in termini generali.
In questa prospettiva, sembra utile appuntare l’attenzione su alcuni aspetti che forse meno hanno costituito oggetto di riflessione. Essi rimandano agli scenari che, alla luce di questa sentenza, potrebbero non arbitrariamente prefigurarsi in occasione di futuri interventi della Corte nella materia penale e attengono più specificamente alla verifica dell’osservanza, nella vicenda in questione, dei caratteri propri del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.
Il modello di questo tipo di giudizio è noto. Un giudice, nel corso del processo, dubita della conformità a costituzione di una disposizione di legge. Secondo l’art. 23 L. 87/53 solleva “questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza”, indicando: a) le disposizioni della legge viziata di illegittimità costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione che si assumono violate.
E ciò che ha fatto (se fondatamente o meno, era appunto l’oggetto del giudizio della Corte costituzionale) la Corte d’Assise di Milano nel processo Cappato: i giudici hanno denunciato l’incostituzionalità dell’art. 580 c.p. – perché in contrasto con gli art. 3, 13 comma 2 e 117 Cost. – nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicidario e in subordine – perché in contrasto anche con gli art. 25 comma 2 e 27 comma 3 Cost. – nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione al suicidio che non incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la stessa pena prevista per l’istigazione.
E, di conseguenza, ci si aspetterebbe che la Corte, ove accolga la questione come proposta dal giudice a quo, dichiari «nei limiti dell’impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime» e quelle la cui illegittimità derivi dalla decisione adottata (art. 27 L. 87/53). Con l’effetto, pure questo abbastanza semplice, che «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» (art. 30 comma 3 L. 87/53).
In via di prima approssimazione, si può dire che nel caso Cappato il rispetto di questo schema lineare è rimasto non poco sfuggente. A una lettura appena più approfondita, per esempio, non risulta proprio chiaro, in definitiva, quale sia la disposizione illegittima e quale la disposizione che cessa di avere applicazione dal giorno successivo.
I giuristi – beninteso – sono avvezzi da tempo a misurarsi con l’arricchimento della tipologia delle decisioni della Corte costituzionale, la cui vasta gamma non c’è davvero bisogno di ricordare in questa sede. Non raramente, quindi, si trovano a dover ricercare la risposta ai dubbi di costituzionalità nelle complesse pieghe di sentenze manipolative, additive, sostitutive, ecc.
E tuttavia il criterio per valutare le sentenze impostesi nella prassi, che sfuggono alla schematica catalogazione delle sentenze delle Corte – di accoglimento o di rigetto – strettamente desumibile dalla legge, è pur sempre quello di verificare in concreto se i passaggi fondamentali del processo decisorio costituzionale e gli effetti che ne derivano siano riconducibili alle poche e chiare disposizioni della L. n. 87/1953, la quale rimane la legge ordinaria di riferimento per «il funzionamento della Corte costituzionale» (art. 137 comma 2 Cost.).
Si tratta di una verifica da condurre soprattutto nella prospettiva del consociato, che deve osservare la legge, o anche solo del giudice ordinario, che della legge deve fare applicazione. Non degli specialisti o dei maitre à penser, che sembra la Corte abbia scelto (forse inconsapevolmente) come propri principali interlocutori e che hanno monopolizzato il dibattito prima, “durante” e dopo il giudizio di costituzionalità.
- Oltre i “limiti dell’impugnazione”
Questa ricognizione non può che muovere dalla valutazione della coerenza tra la decisione della Corte ed i termini in cui la questione di costituzionalità era stata impostata dal giudice a quo.
Ai giudizi sulle leggi trova applicazione un principio del diritto processuale comune, che si suole esprimere nella formula della “corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, il cui significato consiste, sostanzialmente, nel divieto per il giudice costituzionale di allargare di propria iniziativa il thema decidendum della controversia sottopostagli[1].
L’art. 27 L. 87/53, infatti, stabilisce che la Corte pronuncia «nei limiti dell’impugnazione»[2]. L’ordinanza di rimessione contiene la determinazione del thema decidendum, che è costituito dalla norma sospettata di incostituzionalità rispetto alla norma costituzionale o alle norme costituzionali invocate come parametri. E si ritiene che tale determinazione sia di fondamentale importanza, perché la Corte costituzionale è chiamata a giudicare della questione di legittimità costituzionale così come individuata dal giudice a quo nella sua ordinanza, senza poter modificare i parametri (norma ordinaria e norma costituzionale) in essa richiamati[3].
Oggetto del giudizio della Corte, dunque, sono, in linea di principio, soltanto le norme denunciate nel ricorso o nell’ordinanza; e a parametro del giudizio stesso sono da assumere esclusivamente le norme costituzionali nei confronti delle quali la questione era stata proposta. Pertanto, la Corte giudica della questione di cui è stata investita, nei termini in cui era stata impostata; ove ritenesse che non sussista contrasto con le norme costituzionali invocate, non potrebbe spingersi a ricercare se le disposizioni denunciate non contrastino, invece, con altre norme costituzionali, delle quali non era stata dedotta violazione[4].
È vero che non raramente la Corte giudica norme diverse da quelle denunciate dal giudice a quo, per esempio con il richiamo a norme costituzionali non prese in considerazione dal rimettente oppure mediante l’estensione della questione di legittimità costituzionale a disposizioni di legge non denunciate, e così mostrando di dare al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato un significato quantomeno flessibile[5].
Ma è vero pure che, anche di recente, la Corte ha ripetutamente riaffermato, in diverse pronunce, il principio secondo cui «l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell’ordinanza di rimessione, sicché non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti (…) volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza»[6].
Il fondamento del principio della “corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”, applicato al processo costituzionale, è stato variamente individuato nella «funzione di circoscrivere a quanto strettamente necessario il potere della Corte di provocare la caducazione di leggi o norme di legge»[7]; ovvero di diminuire «il livello di politicità del giudizio»[8]; o ancora di «limitare l’attivismo giudiziario»[9].
Non bisogna dimenticare, infatti, che nel disegno originario, il ruolo della Corte costituzionale è quello di legislatore puramente “negativo”, vincolato alla rigida alternativa tra accoglimento e rigetto della questione. Il compito di attuare e svolgere a livello legislativo i principi costituzionali, così come quelli di conformare ad essi la legislazione preesistente ovvero di intervenire o meno a seguito delle dichiarazioni di incostituzionalità, sono riservati in positivo al Parlamento[10].
2.1 Segue. a) l’ordinanza n. 207 del 2018
Ciò detto, pare abbastanza evidente che nel caso Cappato la Corte abbia proceduto ad una vera e propria rielaborazione della questione di costituzionalità prospettata dal giudice rimettente, fuoriuscendo dai “limiti dell’impugnazione”.
Che non si tratti di una arbitraria osservazione dell’interprete, risulta chiaro a leggere testualmente ciò che la stessa Corte afferma fin dalla ordinanza n. 207 del 23 ottobre 2018. Il provvedimento, infatti, riassume efficacemente in apertura petitum e causa petendi dell’autorità giudiziaria rimettente.
La Corte ricorda che il giudice a quo sollecita una rilettura dell’art. 580 c.p. alla luce del principio personalistico enunciato dell’art. 2 e del principio dell’inviolabilità della libertà personale affermato dall’art. 13: «principi alla luce dei quali la vita – primo fra tutti i diritti inviolabili dell’uomo – non potrebbe essere “concepita in funzione di un fine eteronomo rispetto al suo titolare”. Di qui, dunque, anche la libertà della persona di scegliere quando e come porre termine alla propria esistenza».
Richiamati come parametri anche gli artt. 2 e 8 CEDU, i giudici milanesi – sintetizza la Corte – ritengono che «il bene giuridico protetto dalla norma denunciata andrebbe oggi identificato, non già nel diritto alla vita, ma nella libertà e consapevolezza della decisione del soggetto passivo di porvi fine». Con la conseguenza che «la punizione delle condotte di aiuto al suicidio che non abbiano inciso sul percorso deliberativo della vittima risulterebbe ingiustificata e lesiva degli artt. 2, 13, primo comma e 117 Cost.».
E che il thema decidendum proposto dalla Corte d’Assise di Milano non sia equivocabile (ma soprattutto che non sia stato concretamente equivocato), è evidente in un passaggio di poco successivo dell’ordinanza, quando la Corte costituzionale (§3 del Considerato in diritto), in risposta ad una eccezione dell’Avvocatura generale dello Stato, osserva «che il giudice a quo chiede, in via principale, a questa Corte, di rendere penalmente irrilevante l’agevolazione dell’altrui suicidio (…) invoca, dunque, una pronuncia a carattere meramente ablativo»[11].
Ebbene, a fronte della questione di costituzionalità così formulata, la Corte afferma senza incertezze che «nel merito, la tesi della Corte rimettente, nella sua assolutezza, non può essere condivisa» e che l’assetto legislativo vigente «non può ritenersi contrastante, di per sé, con i parametri evocati». Non con l’art. 2 Cost. da cui, semmai, «discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire». Né – aggiunge la Corte – «è possibile desumere la generale inoffensività dell’aiuto al suicidio da un generico diritto all’autodeterminazione individuale, riferibile anche al bene della vita, che il rimettente fa discendere dagli art. 2 e 13, primo comma, Cost.».
E, dopo avere escluso anche che l’art. 580 c. p. si ponga in contrasto con l’art. 8 CEDU, la Corte conclude, pertanto, che «l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non può essere ritenuta incompatibile con la Costituzione». Dunque, i giudici costituzionali sgombrano ben presto il campo dai termini in cui il giudice rimettente ha impostato la questione.
Lo schema è piuttosto chiaro. Il giudice a quo: a) dubita tout court della legittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio previsto dall’art. 580 c. p. e la Corte ribadisce invece che la norma denunciata sia tuttora «funzionale alla protezione di interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento»; b) indica, inoltre, come parametri del giudizio gli art. 2 e 13 Cost. e la Corte esclude, invece, che da quegli articoli siano desumibili controindicazioni costituzionalmente rilevanti rispetto alla scelta del legislatore di incriminare l’aiuto al suicidio.
Tuttavia[12], la Corte non ritiene, con questo, esaurito il proprio compito.
Prende specificamente in considerazione la situazione oggetto del giudizio a quo e a partire da essa rimodella il thema decidendum, isolandola come ipotesi nella quale «l’assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l’unica via d’uscita per sottrarsi (…) a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all’art. 32, secondo comma, Cost.». Parametro, quest’ultimo, che la stessa Corte riconosce «non evocato nel dispositivo nell’ordinanza di rimessione»[13], benché richiamato più volte in motivazione.
Per quali motivi la Corte abbia ritenuto il vulnus costituzionale autonomamente riscontrato come bisognevole di non differibile rimozione e con quali modalità abbia poi immaginato di indirizzare il successivo svolgersi del processo costituzionale, sono aspetti su cui non è necessario in questo momento soffermarsi.
Il richiamo al merito dell’ordinanza n. 207/18 serve, piuttosto, per rilevare ciò che non sempre i numerosi commenti sulla vicenda costituzionale del c.d. fine-vita hanno sufficientemente rimarcato, e cioè che, per dirla con attenta dottrina, «il Giudice costituzionale riscrive completamente l’ordinanza di rimessione, modifica in modo radicale la richiesta del giudice a quo e la sua valutazione dei principi costituzionali coinvolti»[14].
La Corte, dunque, si spinge oltre il petitum dell’ordinanza di rimessione[15]. Nonostante abbia di fatto valutato come priva di fondamento l’impostazione seguita dalla Corte d’Assise di Milano, riformula la questione di costituzionalità, correggendo il giudice a quo[16].
2.2 Segue. b) la sentenza n. 242 del 2019
Se così ampio spazio si è finora riservato all’ordinanza n. 207/18, ciò dipende dal fatto che, secondo un apprezzamento pressoché unanime, la prospettazione della questione in essa contenuta è stata poi confermata dalla sentenza n. 242 del 2019[17], la quale si pone nel solco tracciato l’anno precedente[18].
Del resto, la stessa Corte, dopo aver riassunto i rilievi già formulati nell’ordinanza n. 207/18 e «una serie di conclusioni» in essa tratte «in ordine al thema decidendum», premette di confermare «gli uni e le altre», sicché «a essi si salda, in consecuzione logica» la definitiva decisione del giudizio di legittimità costituzionale (§ 2.1 del Considerato in diritto). Ma, verosimilmente indotti anche da qualche osservazione perplessa (affiorata a fatica dal profluvio di commenti entusiastici sul merito, eppure un po’ sbrigativi sulla procedura) in ordine alla sostanziale fuoriuscita della precedente ordinanza dai “limiti dell’impugnazione”, i giudici costituzionali si correggono, in sostanza, sulle modalità di individuazione del thema decidendum, affermando di averlo ricavato dall’ordinanza di rimessione del giudice a quo.
Si dice, infatti, che «all’interno del petitum principale del rimettente, questa Corte ha individuato, nondimeno, una circoscritta area di non conformità costituzionale della fattispecie criminosa» (§ 2.3 del Considerato in diritto). In realtà, mai nell’ordinanza n. 207/18 si era presentata la reimpostazione della questione di legittimità costituzionale come il risultato di una delimitazione dell’area del petitum della Corte d’Assise di Milano.
Piuttosto, il discorso era transitato, anche alquanto “bruscamente”, dall’affermazione della non condivisibilità della tesi del giudice rimettente, a quella secondo cui fosse tuttavia necessario «considerare specificamente situazioni come quella oggetto del giudizio a quo»: dunque, una riqualificazione della questione, collegata, non già alle argomentazioni dei giudici milanesi, bensì direttamente alla «vicenda oggetto del giudizio principale» (§ 8 del Considerato in diritto). Sembra, dunque, che la Corte, voglia anticipare possibili rilievi che nell’irrituale lasso di tempo tra l’udienza “motivata” di rinvio e l’udienza di decisione erano stati prospettati e, quindi, “aggiustare il tiro”.
Di fatto, si tratta quasi di un consiglio implicito ai giudici ordinari di “abbondare” nella prospettazione delle questioni (“il più contiene il meno”[19]…), così da dare alla Corte la possibilità di intervenire sulle norme al di là e a prescindere dalla fondatezza della questione concretamente proposta. Viceversa, la sentenza omette di approfondire l’altro argomento fondamentale che la Corte aveva utilizzato sin dall’ordinanza n. 207/18 per giustificare il proprio intervento esuberante dai confini dell’ordinanza di rimessione e, al tempo stesso, invasivo del compito “positivo” – riservato al Parlamento – di fare leggi conformi ai principi costituzionali.
La fissazione di una nuova udienza di trattazione e la sospensione del giudizio a quo, infatti, erano stati giustificati alla luce della considerazione che una eventuale pronuncia di inammissibilità con monito al legislatore avrebbe avuto l’effetto di lasciare in vita la norma, in un modo che non poteva «considerarsi consentito nel caso in esame, per le sue peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei valori in esso coinvolti». Ebbene, questa ultima affermazione apodittica tale rimane nella sentenza n. 242/2019.
La Corte non spiega, al di là della suggestiva petizione di principio, quali siano le caratteristiche peculiari del caso sottoposto al giudizio della Corte d’Assise di Milano e quali i valori rilevanti in gioco, che l’autorizzano per la prima volta a far seguire alla decisione di illegittimità costituzionale la diretta opzione per una nuova disciplina, che pure sarebbe suscettibile – per sua stessa ammissione – «di risposte differenziate da parte del legislatore» (§ 4 del Considerato in diritto).
Ora, il ricorso ai «poteri di gestione del processo costituzionale» è stato espressamente motivato sulla base dell’esigenza di evitare che, nelle more tra una eventuale pronuncia di inammissibilità ed una nuova questione di legittimità, la disciplina viziata di incostituzionalità continuasse ad operare.
Dunque, le “caratteristiche” e i “valori” del caso dovevano essere evidentemente quelli attinenti alla posizione dell’imputato nel processo a quo. Vale a dire che gli unici interessi suscettibili di essere pregiudicati dal ritardo nella declaratoria di illegittimità e nella adozione di una nuova disciplina legislativa erano quelli riguardanti la libertà personale dell’imputato.
Si tratta, tuttavia, degli interessi in gioco in qualsiasi processo penale, che non sono passibili di variazione a seconda del reato contestato (peraltro, quello di aiuto al suicidio, pur essendo un reato di non marginale entità, non è tra quelli puniti più gravemente nel nostro ordinamento, il che significa che la necessità di un intervento “sostitutivo” sarebbe indirettamente giustificata ogni volta che dovessero venire in questione le numerose fattispecie penali più gravi rispetto all’art. 580 c.p.), tanto più in un processo celebrato a carico di imputato libero.
Eppure, la Corte non ha spiegato perché in questo specifico caso non poteva essere consentita una pronuncia di inammissibilità, ma soprattutto non ha indicato quali sarebbero, al contrario, i casi, egualmente coinvolgenti la libertà personale di un imputato di un reato sospettato di incostituzionalità, in cui si possa consentire – a differenza che nel caso Cappato – l’applicazione di una norma di cui si è preventivamente stimata l’illegittimità.
E anche la via alternativa «della nuova questione di legittimità costituzionale» che la Corte aveva problematicamente prefigurato per arrivare alla dichiarazione di incostituzionalità conseguente all’accertamento dell’inerzia legislativa, giudicandola tuttavia troppo defatigante e lunga, era, di fatto, assai meno incerta e complessa di quanto ipotizzato, se si considera che l’imputato – giudicato, si ripete, a piede libero – si era mostrato ben deciso ad andare avanti (tanto da non aver fatto mistero di essersi autodenunciato strumentalmente, anche allo scopo di provocare una declaratoria di incostituzionalità).
Di guisa che, in caso di eventuale condanna per il reato previsto dall’art. 580 c.p. nella sua formulazione originaria, certamente avrebbe impugnato la decisione e il giudice di secondo grado sarebbe stato nella condizione di valutare se sollevare nuovamente la questione (già proposta, del resto, in quello stesso procedimento innanzi al giudice delle indagini preliminari[20], senza che il giudizio di infondatezza di quest’ultimo abbia poi impedito di riproporre la questione durante il primo grado). Insomma, nessun reale periculum in mora poteva derivare da una eventuale pronuncia di inammissibilità.
Merita di essere ricordato, infine, un ultimo aspetto problematico della sentenza, che pure può rubricarsi come una ulteriore conseguenza della violazione del principio di corrispondenza tra “chiesto e pronunciato”. Come lucidamente messo in luce da una parte della dottrina, la pronuncia entra in contraddizione con il principio della riserva di giurisdizione nella parte in cui ha introdotto nel dispositivo «un riferimento anche al passato, quando è noto che spetta ai giudici comuni interpretare le decisioni costituzionali in relazione ai propri giudizi»[21].
Anzi, in motivazione (§7 del Considerato in diritto) la Corte ha in qualche modo obbligato il giudice a quo a verificare la sussistenza dei requisiti procedimentali da essa precedentemente indicati «quali condizioni per la non punibilità dell’aiuto al suicidio». Si tratta di un’altra anomalia strettamente discendente dalla discutibile deviazione della Corte dal percorso tracciato dai “limiti dell’impugnazione”.
Il giudice a quo ha ritenuto rilevante la questione di costituzionalità nei termini in cui l’ha prospettata alla Corte costituzionale. Se quest’ultima – come avvenuto nel caso di specie – modifica la questione, opera un suo autonomo giudizio di rilevanza in termini diversi da quelli proposti dal remittente. Ma il giudice a quo in tanto può disapplicare la norma, come effetto della sentenza della Corte, se la norma è quella la cui questione di costituzionalità aveva lui stesso valutata rilevante. Ove la questione sia un’altra, potrebbe legittimamente ritenere che il giudizio della Corte sia irrilevante per la sua decisione.
Insomma, la Corte d’Assise di Milano non aveva lamentato che l’intervento del medico non scriminasse il reato, ma aveva chiesto la incostituzionalità tout court dell’art. 580 c.p. sul presupposto che chi aiuta a suicidarsi colui che ha deciso per conto proprio e non fornisce un contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicidario non offende il bene tutelato dalla norma in quanto l’individuo ha la libertà di decidere quando e come morire. Viene da chiedersi, allora, come faccia la Corte costituzionale a prescrivere al giudice a quo (“dovrà essere verificata”) di valutare se la sua sentenza abbia influenza sul giudizio in corso, laddove la Corte d’Assise di Milano l’aveva invece compulsata per una diversa questione.
- Una sentenza “erga omnes” o “inter partes”?
Il catalogo delle atipicità riconducibili alla sentenza n. 242/19 è suscettibile di arricchirsi di un ulteriore elemento se si guarda all’aspetto degli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale.
La dichiarazione di incostituzionalità di una norma ha effetti “erga omnes”[22]. Essa riguarda, cioè, sia i rapporti giuridici che vengono a formarsi nel periodo successivo alla pubblicazione della sentenza di accoglimento, sia quelli ad essa precedenti che non siano giuridicamente esauriti, con l’unica eccezione rappresentata dai rapporti giuridici decisi con sentenza di condanna penale irrevocabile[23].
Le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, dunque, producono l’annullamento delle norme di legge dichiarate incostituzionali, con la conseguenza della perdita di efficacia della norma incostituzionale nei confronti dell’intero ordinamento e non soltanto delle parti del processo[24]. La perdita di efficacia con effetti “erga omnes” deriva, in particolare, dall’art. 136 Cost., il quale stabilisce che «quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».
E l’art. 30 co. 3 L. n. 83/1957 precisa che «Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione». Questo dovrebbe significare che una norma dichiarata incostituzionale trova la medesima applicazione, sia prima che dopo la sentenza di accoglimento della Corte: non si applica a chi è imputato prima e non si applica a chi ponga in essere dopo (anche il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione) la medesima condotta dell’imputato del processo a quo[25].
Invece, la sentenza n. 242/19 si applica a tutte le condotte precedenti, ma non anche allo stesso modo a quelle future, nel senso che una condotta uguale a quella di Marco Cappato commessa dopo continua a essere reato (perché non rispondente ai requisiti procedurali fissati dalla sentenza). In genere, si è posto il problema contrario: le sentenze di accoglimento non si limitano a porre termine alla vigenza delle norme dichiarate incostituzionali, ma a partire dal giorno successivo ne impediscono l’applicazione in base ai comuni principi sull’efficacia della legge nel tempo, sicché è fatto divieto ai giudici di applicare da quel momento norme dichiarate incostituzionali anche ai fatti precedenti (ma andrebbe da sé che, a maggior ragione, non possano essere applicate le norme incostituzionali ai fatti successivi).
Nel caso di specie, invece, l’art. 580 c.p., per come interpretato dalla Corte, non è stato ritenuto applicabile a Cappato, ma continua ad essere applicabile a chi ponga in essere una condotta identica a quella di Cappato dopo la sentenza (“le modalità equivalenti” non varranno più). Come efficacemente sintetizzato all’indomani della sentenza, «un nuovo caso Antoniani/Cappato, negli stessi termini fattuali, non sarebbe (più) non punibile»[26].
Dunque, in questo caso la cessazione di efficacia della norma dichiarata illegittima (art. 136 Cost.) opera ex tunc, ma al tempo stesso, se così si può dire, usque ad nunc. Essa, infatti, riguarda solo i «fatti anteriori alla pubblicazione» della sentenza. Viceversa, l’art. 580 c.p., nella medesima formulazione che ha legittimato l’assoluzione di Cappato, continuerà a trovare applicazione (art. 30 co. 3 L. n. 83/1957) in relazione a condotte uguali anche dopo la sentenza, ma per legittimare, con tutta probabilità, sentenze di condanna.
- Dalla uguaglianza dei malati alla disuguaglianza degli agevolatori
Quella che è stata definita la “doppia incostituzionalità dell’art. 580 c.p.”[27] non è affatto ininfluente quando si tratti di valutare la tipicità degli effetti del processo decisorio costituzionale nel caso in questione.
La declaratoria di parziale illegittimità dell’art. 580 c.p. certamente riduce l’area della illiceità dell’agevolazione del suicidio e, pertanto, determina complessivamente un trattamento più favorevole rispetto alla formulazione originaria della norma. Ma, per certi versi, il nuovo art. 580 c.p. risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale è meno favorevole, perché adesso sono necessari, per andare esenti da punibilità, il ricorso alla struttura sanitaria pubblica ed il parere del comitato etico: ciò di cui, invece, Cappato ha potuto fare a meno perché la sua condotta è precedente alla L. n. 219/2017.
Dunque, la sentenza contiene in sé la individuazione di una nuova fattispecie incriminatrice meno grave in assoluto/astratto (perché introduce la c.d. scriminante procedurale e, dunque, la non punibilità di chi d’ora in avanti agevoli il suicidio con le modalità previste dagli art. 1 e 2 L. 219/2017), ma più grave in concreto rispetto alla condotta sub judice di Cappato (perché costui è rimasto scriminato senza “procedura”).
Si può dire, allora, che, nel caso di specie, entrano in crisi almeno due affermazioni che viceversa dovrebbero discendere sicure da una sentenza della Corte in materia penale:
1) quella secondo cui chi ponga in essere la stessa condotta dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale in bonam partem della norma penale incriminatrice fruisce di un trattamento migliore di quello che era applicabile a chi l’avesse commessa sotto la vigenza della norma incostituzionale (salvo, ovviamente, il disposto dell’art. 30 L. n. 87/1953);
2) quella secondo cui coloro che abbiano posto in essere la stessa condotta prima della declaratoria di illegittimità costituzionale debbano essere trattati tutti alla medesima maniera.
Invece, lo schema binario disegnato dalla sentenza n. 242/19, come opportunamente evidenziato, «rischia di creare effetti paradossali, forieri di possibili diseguaglianze trattamentali tra situazioni uguali»[28]. Si faccia l’ipotesi, per esempio, che una persona che versi nelle identiche condizioni del soggetto passivo della vicenda oggetto del giudizio a quo incarichi oggi un terzo (un amico, un conoscente, un tassista, un attivista politico, ecc.) di farsi accompagnare in clinica, spiegandogli o facendogli spiegare il motivo per cui si reca in Svizzera nonché l’origine della sua decisione.
Il terzo che lo assecondasse compirebbe, dal punto di vista materiale, la medesima azione di Cappato e agirebbe, dal punto di vista dell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 580 c.p., con il suo stesso dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice[29] (cioè, la volontà di compiere un atto di aiuto al suicidio, accompagnato dalla rappresentazione dell’obiettivo perseguito dall’aiutato). Ciò nondimeno, egli, a differenza di Cappato, sarebbe punibile.
Effetto ammissibile – questo – se fosse conseguenza di una scelta del legislatore. Non anche, invece, nel caso di una sentenza della Corte, sia pure manipolativa, dalla quale dovrebbe conseguire, per dirla con illustre dottrina, che «nessun comportamento risulta, in definitiva, punibile che già non lo fosse in base alla disposizione originaria»[30].
Ma la stessa sorte toccherebbe anche a chi prima della sentenza avesse accompagnato in una clinica svizzera una persona che versava nelle stesse condizioni del soggetto passivo del giudizio a quo, senza che però tali condizioni fossero state fatte oggetto di verifica in ambito medico e senza che gli fossero state date le dovute informazioni sull’accesso alle cure palliative o, eventualmente, alla sedazione profonda continua.
Anche in questo caso, l’agente, a differenza di Cappato, sarebbe punibile. Non v’è chi non veda, allora, che, in conseguenza della sentenza della Corte, la responsabilità penale dell’agente sia ora legata a troppe variabili, a loro volta di dubbia costituzionalità. Da un lato, infatti, la punibilità dipenderebbe non tanto, o non soltanto, dalla condotta dell’agente in sé, ma dalla più o meno estesa diligenza del suicida o dei suoi familiari, a seconda che abbiano o meno voluto ovvero siano stati o meno nella condizione di contattare un medico specialista, il quale abbia a sua volta verificato la patologia dell’interessato (irreversibile), le sue condizioni (grave sofferenza fisica o psicologica) e la sua volontà (capacità di prendere decisioni libere e consapevoli); oppure, ancora, a seconda che si siano informati o meno circa le cure palliative e la possibilità di accedere alla sedazione profonda; ecc. I problemi di conciliabilità di tale situazione con l’art. 27 co. 1 Cost. paiono evidenti.
Dall’altro, la punibilità dipenderebbe anche dalle “condizioni sociali e personali” dell’agente (art. 3 co. 1 Cost.). Cappato, per esempio, è un propagandista politico, con possibilità socio-politiche e competenze in ambito sanitario che non ha il quisque de populo: dalla sentenza della Corte d’Assise di Milano, risulta, infatti, che egli sia stato contattato dalla famiglia di Antoniani come dirigente di un’associazione di ispirazione politica e che, in questa veste, sia stato messo a parte delle condizioni di salute del malato, prendendo con lui in esame le eventuali alternative al suicidio assistito.
Dunque, Cappato era nelle condizioni di comprendere la gravità e l’irreversibilità della malattia, ma soprattutto aveva potuto per scelta politica dedicare tempo e intelligenza a capire se la volontà di morire fosse autonoma ed a prospettare al malato le possibili alternative. Viceversa, in una situazione analoga un terzo (per esempio, il sopra citato tassista), assai verosimilmente, non sarebbe in grado di apprezzare la sussistenza o meno, anche solo di fatto, dei requisiti procedimentali a cui ha fatto riferimento la sentenza n. 242/19 e, perciò, non sarebbe nella condizione di andare esente da responsabilità.
Con la conseguenza paradossale che chi più si sia speso per assecondare la volontà del suicida (pur senza determinarla) non risponde del reato, mentre ne è colpevole chi abbia prestato solo un aiuto occasionale, benché consapevole. Insomma, chi abbia posto in essere una condotta analoga a quella di Cappato sotto il profilo “naturalistico”, ma in una situazione in cui i requisiti procedimentali non sussistevano oppure non valgono più a scriminare, potrebbe dolersi che la norma così riscritta dalla Corte (sia nella formulazione da far retroagire ai fatti precedenti, sia in quella formale pro futuro) violi il principio di uguaglianza.
- Riserva di legge e determinatezza alla prova della manipolazione del precetto penale
Quello di uguaglianza non è l’unico principio costituzionale con cui la situazione risultante in concreto dalla sentenza n. 242/19 rischia di entrare in contraddizione.
È stato acutamente osservato che, nella vicenda costituzionale dell’art. 580 c.p., è stato messo in crisi lo stesso ruolo del principio di legalità (art. 25 Cost.), a partire dalla ordinanza n. 207/18, la quale ha rappresentato un punto cruciale nel passaggio dal “sistema della legalità”, cioè dal sistema della formulazione legislativa, al “sistema della giurisdizione”, vale a dire della formulazione giudiziaria del diritto[31].
In particolare, sembra evidente che, per effetto del complessivo intervento della Corte costituzionale, siano ravvisabili non marginali profili di attrito con almeno due dei sotto-principi[32] in cui si articola il principio di legalità: la riserva di legge e la determinatezza.
Basti considerare, sotto questo punto di vista, che la pronuncia è, con tutta evidenza, molto complessa, sia nella motivazione che nel dispositivo. Benché si tratti di indirizzo ormai invalso nella giurisprudenza costituzionale (soprattutto per quello che riguarda l’impianto motivazionale delle sentenze), non si è irrispettosi se si afferma che, nel caso di specie, la dilatazione è soprattutto l’esito della laboriosità con cui la Corte, decidendo di sostituirsi al legislatore, ha dovuto trarre da alquanto generiche «coordinate del sistema vigente» quelli che ha definito «i criteri di riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato»[33].
Ne è derivato, appunto, un assetto argomentativo pletorico e, al tempo stesso, impreciso, in cui la “fenditura” della riserva di legge ed i problemi di tassatività si intrecciano strettamente: nel senso che il deficit di determinatezza che ne residua appare esattamente come la conseguenza della inosservanza del principio secondo cui la potestà normativa in materia penale è rimessa alla competenza esclusiva del legislatore ordinario.
Non si vuol dire, con questo, che i nostri legislatori siano necessariamente più capaci dei giudici della Corte, ma piuttosto che questi ultimi non dispongono degli spazi di manovra di cui gode il legislatore in sede di redazione della fattispecie penale e, pertanto, hanno dovuto (ma soprattutto voluto) fare acrobazie per ricavare un precetto dal sistema. Con tutte le conseguenze del caso in termini di descrizione del comportamento penalmente sanzionato.
Ciò potrà, probabilmente, apparire più chiaro ove si rifletta sulla situazione che si verificherà sia nei processi in corso alla data del 22 novembre 2019, sia nei processi di là da venire aventi ad oggetto fatti successivi. Prima della sentenza n. 242/19, una condotta come quella delineata dalla Corte non era possibile – per così dire – “in natura”, nel senso che non si sarebbe potuto richiedere a chi avesse agevolato il suicidio altrui l’adozione delle modalità previste dalla L. n. 219/2017.
Certamente, non prima della entrata in vigore della legge, avvenuta il 31 gennaio 2018. Ma nemmeno nel periodo intercorso tra la sua entrata in vigore e l’emissione della sentenza: lo ha detto, peraltro, la stessa Corte al punto 7§ del Considerato in diritto. Eppure, chi ha commesso il fatto prima della sentenza della Corte, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare di aver agito con (ovvero in presenza di) modalità equivalenti a quelle previste dalla L. 219/2017, benché tali modalità non fossero espressamente comprese nel precetto penale e non concorressero pertanto a tratteggiare il comportamento penalmente sanzionato.
Con due conseguenze, a dir poco discutibili, che confliggono insanabilmente con l’esigenza della tassatività della fattispecie penale[34]. La prima è che la norma penale, al momento della commissione del fatto, non funge da guida del comportamento del cittadino, il quale deve poter discernere tra le zone del lecito e dell’illecito.
La seconda è che, quando si tratta di giudicare dopo la sentenza n. 242/19 il fatto commesso prima, il giudice deve ricercare nella lunga e complessa pronuncia della Corte le «modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione»[35]: vale a dire che il contenuto della norma da applicare è integrato – tanto diffusamente, quanto significativamente – dalla motivazione della Corte!
Ma i medesimi problemi si pongono, con tutta evidenza, anche per i fatti commessi dopo la sentenza n. 242/19. Verrebbe da dire che la Corte contraddice sé stessa, avendo, a partire almeno dalla nota sentenza n. 364/88, affermato testualmente che «nelle prescrizioni tassative del codice il soggetto deve poter trovare, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato» e che «a questo fine sono necessarie leggi precise, chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento» (§8), nonché sottolineato la necessità che il diritto penale «sia costituito da norme (…) chiaramente formulate» (§17), rese conoscibili dai destinatari grazie ad una pubblicità adeguata.
Invece, se il consociato volesse oggi individuare con precisione la versione vigente dell’art. 580 c.p. dovrebbe “muoversi” tra il dispositivo e la motivazione[36] della sentenza della Corte per capire quale rimproverabile comportamento materiale gli possa essere attribuito come reato. Compito nient’affatto facile, se si considera l’ampiezza, in termini quantitativi (1200 parole e 7074 caratteri), del punto 5 della sentenza n. 242/19, che spiega a quali condizioni talune condotte di aiuto al suicidio si sottraggono alla sfera di operatività dell’art. 580 c.p. e che a sua volta rimanda all’ordinanza n. 207/18 nella parte in cui ha già puntualmente individuato ai punti 8 e 9 (1583 parole e 9.269 caratteri) le situazioni di incompatibilità costituzionale della indiscriminata repressione dell’aiuto al suicidio.
E, peraltro, compito nemmeno agevolato dalla lettura del lungo dispositivo (sempre meno riconducibile al concetto tradizionale di enunciazione sintetica della regola che governerà la questione dedotta in giudizio), il quale, dopo aver richiamato espressamente gli art. 1 e 2 L. n. 219/2017, rimanda ad una serie di elementi di tipo tecnico-scientifico alquanto elastici. Dunque, il contenuto della norma, per come costruita nel dispositivo, necessita, per essere determinato, di un rinvio sia a complesse norme extrapenali (L. n. 219/2017) che a parametri extragiuridici non proprio univoci (i concetti di trattamenti di sostegno vitale, di patologia irreversibile, di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, ecc.).
Quella che si ricava dalla sentenza n. 242/19, insomma, è una norma per “iniziati” (e in qualche parte, forse, nemmeno per loro, come quando, per esempio, fa riferimento a strutture – i “comitati etici territorialmente competenti” – sconosciute ai più e di dubbia individuazione[37]). Sembra proprio che la Corte, venendo meno ai doveri costituzionali che essa stessa richiede al legislatore quanto alla chiara formulazione del divieto, abbia pensato essenzialmente, come suoi interlocutori, a medici, uomini di scienza ed esponenti politici, piuttosto che ai cittadini in genere.
Ma quello di cui all’art. 580 c.p. non è un reato c.d. proprio.
- Uno strano assorbimento
La Corte d’Assise di Milano, come detto, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. anche «nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione all’esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione».
Ebbene, nell’ordinanza n. 207/18 la Corte costituzionale aveva condivisibilmente giudicato «evidente che le censure relative alla misura della pena hanno un senso solo in quanto le condotte avute di mira restino penalmente rilevanti: il che presuppone il mancato accoglimento delle questioni intese a ridefinire i confini applicativi della fattispecie criminosa». Il rapporto di subordinazione tra le due questioni, infatti, era stato ritenuto “in re ipsa”, benché il giudice a quo non lo avesse espressamente indicato (§1 del Considerato in diritto).
E nella sentenza n. 242/19 la Corte aveva subito ribadito (§ 2.1 del Considerato in diritto) «come tra le questioni sollevate intercorra un rapporto di subordinazione implicita: interrogarsi sul quantum della pena ha, infatti, un senso solo ove le condotte avute di mira restino penalmente rilevanti»[38]. Se ne può inferire, dunque, che solo l’accoglimento in toto della prima questione posta dai giudici di Milano – ovvero l’illegittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio, a prescindere dal contributo dell’agente alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio – avrebbe reso, per usare la terminologia della Corte, “insensata” la decisione sulla seconda questione attinente il trattamento sanzionatorio del medesimo reato.
Tuttavia, sin dalla ordinanza n. 207/18, «la tesi della Corte rimettente, nella sua assolutezza» non è stata condivisa nel merito (§ 4 del Considerato in diritto), sicché è stato espressamente affermato che «l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non può essere ritenuta incompatibile con la Costituzione» (§8 del Considerato in diritto). La conclusione è stata confermata nella sentenza n. 242/19 (§2.2. del Considerato in diritto).
Non si comprende quindi perché, dopo aver dichiarato la solo parziale illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. in termini non coincidenti con quelli prospettati dai giudici rimettenti, la Corte costituzionale abbia infine ritenuto che «assorbite restano le questioni subordinate, attinenti alla misura della pena» (§8 del Considerato in diritto)[39].
La sentenza, in realtà, non priva affatto di rilevanza penale tutte le condotte di aiuto al suicidio. Tanto è vero che la Corte precisa di avere individuato non più che «una circoscritta area di non conformità costituzionale della fattispecie criminosa»: il che vuol dire che permane una residua area della fattispecie incriminatrice che è conforme a Costituzione e che séguita a ricomprendere condotte penalmente rilevanti. Peraltro, la stessa Corte, rilevando che i requisiti procedimentali individuati quali condizioni per la non punibilità dell’aiuto al suicidio non potevano essere richiesti in rapporto ai fatti commessi prima, aveva aggiunto che la loro sussistenza avrebbe dovuto essere verificata «dal giudice nel caso concreto».
Se, dunque, la Corte d’Assise di Milano – all’esito della valutazione che la sentenza di illegittimità gli aveva rimesso – avesse ritenuto comunque punibile l’imputato per il difetto, nel caso concreto sottoposto al suo giudizio, dei requisiti disegnati dalla sentenza n. 242/19, si sarebbe trovata a decidere sulla dosimetria di una pena di cui pure aveva denunciato la contrarietà a Costituzione, in ciò non contraddetta – ma nemmeno assecondata – dalla Corte costituzionale.
Stante la carenza di una pronuncia su una questione comunque prospettata, seppure in via subordinata, il giudice a quo, allora, non avrebbe avuto altra scelta – del tutto particolare (per non dire altro) – che quella di muoversi dentro gli inalterati limiti edittali che aveva esso stesso già ritenuto irragionevolmente uguali a quelli della istigazione al suicidio[40]. È da escludersi, infatti, che la Corte d’Assise di Milano potesse, nello stesso giudizio, promuovere un nuovo incidente di costituzionalità sulla medesima questione non decisa, perché, ai sensi dell’art. 137 co. 3 Cost., contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione[41]. E la riproposizione della questione sarebbe equivalsa, di fatto, ad una impugnazione[42].
La pur lunga e articolata sentenza n. 242/19, dunque, manca di una risposta ad una parte dei dubbi di legittimità prospettati dal giudice rimettente, senza che ricorra realmente il caso in cui la decisione sul profilo principale di illegittimità abbia reso implicitamente accolta la questione subordinata o comunque abbia reso superfluo il suo esame. Per meglio dire, il rapporto di subordinazione tra le questioni era effettivamente ravvisabile nella questione come originariamente prospettata dal giudice a quo, ma non anche nella questione come successivamente ridefinita ex officio dalla Corte costituzionale.
Come si vede, si tratta della seconda violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che impone al giudice di pronunciarsi su ogni parte in cui è strutturata la domanda e che si pone in potenziale conflitto con la prassi dell’assorbimento dei motivi laddove l’omissione di giudizio sia di fatto elusiva del contenuto della domanda[43]. La Corte, insomma, si è regolata come se avesse inteso la propria pronuncia equivalente, di fatto, ad una estromissione della rilevanza penale dell’agevolazione al suicidio dal nostro ordinamento (con la conseguente superfluità di ogni questione che riguardasse il suo trattamento sanzionatorio).
Conferma implicita, questa, del carattere nient’affatto generale della pronuncia stessa, tutta modulata sulla vicenda Cappato e costruita in modo da propugnare (e da suggerire anche ai giudici rimettenti) una (in nessun modo obbligata) sentenza di assoluzione.
- Conclusioni
Le anomalie della sentenza n. 242/19 che si è fin qui tentato di mettere in luce sono, in ultima analisi, tutte riconducibili alla particolarità della pronuncia.
Sin dall’ordinanza n. 207/18, ci troviamo di fronte ad un provvedimento palesemente modellato sulla vicenda oggetto del giudizio da cui è originata la questione rimessa alla Corte costituzionale[44]. Essa individua un nuovo diritto sulla base del caso giuridico: un diritto che non preesiste al “caso giuridico” e nasce direttamente da esso, tanto che la stessa violazione costituzionale viene ricostruita in base al caso e non alla legge[45]. E questa costruzione, così strettamente legata al caso d’origine, viene portata a compimento con la sentenza dell’anno successivo, la quale – è stato puntualmente osservato – esibisce una «completa “immedesimazione del criterio nell’oggetto del giudizio”, di tal che la pronuncia si caratterizza in modo pressoché esclusivo come un’approvazione o disapprovazione del “fatto”, piuttosto che della norma espressa dalla disposizione legislativa oggetto della pronuncia»[46].
Basti dire che, non a caso, sia l’ordinanza del 2018 che la sentenza del 2019 contengono, in modo non poco irrituale per la giurisprudenza costituzionale, una dettagliata ricostruzione delle risultanze in fatto del processo a quo, «quasi un racconto, una narrazione»[47], con la sostanziale funzione di introdurre il lettore al carattere doloroso e commovente del caso concreto e di convincerlo della ineluttabilità (addirittura della improrogabilità) di un intervento risolutore della Corte, quand’anche dovesse esuberare dai confini del suo giudizio.
Ma la narrazione minuziosa del fatto non è casuale nemmeno dal punto di vista tecnico-giuridico. Serve a trarre direttamente da esso i c.d. “criteri di riempimento necessari” richiesti dalla dottrina delle “rime obbligate”. Se fino ad ora non era in discussione che un intervento manipolativo della Corte dovesse desumere le disposizioni ritenute mancanti da altre norme o principi contenuti nel sistema, con la sentenza n. 242 del 2019 si giunge, invece, ad estrapolare dal fatto «i contenuti integranti i presupposti della non punibilità dell’aiuto al suicidio: proposito suicidario autonomamente e liberamente formatosi, persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili dal paziente, capacità del medesimo paziente di prendere decisioni libere e consapevoli»[48].
Non si sbaglia, dunque, quando si afferma che la sentenza n. 242 del 2019 «sancisca definitivamente l’abbandono dello schema crisafulliano delle “rime obbligate”» [49]. E nemmeno se si aggiunge che la volontà pregiudiziale della Corte di dare una soluzione al caso singolo, anziché alla questione di costituzionalità generale, ha prodotto, con una sorta di effetto “a cascata”, il superamento di buona parte dei canoni cui dovrebbe attenersi il giudizio incidentale (a partire dai limiti dell’impugnazione fino a giungere alla sostanziale elusione dei principi di riserva di legge e di tassatività).
Ora, non si tratta solo di constatare l’aspetto formale della inosservanza delle regole di funzionamento del giudizio innanzi alla Corte. Si tratta, piuttosto, di registrare con preoccupazione gli effetti su larga scala, al di là del caso singolo, di tale violazione. Da un lato, l’invasione della sfera riservata agli apprezzamenti discrezionali del legislatore[50] con valutazioni/decisioni di politica del diritto eccedenti i confini del vaglio di costituzionalità[51] e aventi portata normativa[52].
Ciò, peraltro, con tutti i problemi che reca con sé un sindacato di costituzionalità largamente condizionato dal fatto che nei provvedimenti adottati in questa vicenda «esiste un non-detto, un sotto-testo, che coinvolge l’autobiografia (…) dei protagonisti a vario titolo della vicenda giudiziaria» e che «tutto questo non-detto “extragiuridico” (…) è stato sottratto non solo al dibattito, ma anche alla estrinsecazione formale delle motivazioni giuridiche che si sono adottate»[53].
Sicché si è opportunamente domandata attenta dottrina se le costituzioni possano essere interpretate in maniera tale da ricomprendere possibilità che non risultino dalla lettera delle carte, sol perché taluni le considerano diritti, e anzi laddove erano considerate contrarie ai diritti proclamati da coloro che le scrissero. E soprattutto se: «Può considerarsi effettivamente democratica, poi, un’ermeneutica che si allontana dal testo e dalla sua storia? Possono, le medesime carte, subire un processo di reinterpretazione rimanendo formalmente immutate, senza una discussione pubblica, di natura costituente?»[54].
Dall’altro, il rischio – quale ulteriore effetto – di una modifica sostanziale del ruolo della Corte costituzionale. Essa, cioè, tende in questo modo ed in questo momento storico ad accreditarsi, magari oltre le proprie intenzioni, come punto di riferimento degli “scontenti” della politica e si espone al rischio di divenire il terminale delle istanze di coloro – magari una minoranza, sia pure particolarmente influente – che non riescono ad ottenere in sede parlamentare le modifiche legislative che ritengono necessarie.
Non è una osservazione isolata quella secondo cui la sentenza sul caso Cappato rientra in una di quelle “strategie giudiziarie” che accompagnano o addirittura sostituiscono battaglie politiche vere e proprie[55]. Attraverso l’autodenuncia dell’autore del fatto prima, la scelta dell’incidente di costituzionalità da parte del giudice rimettente poi e la decisione della Corte dopo, si è ottenuto per via giurisprudenziale quanto non si era riuscito ad ottenere per via politico-parlamentare[56]. Ciò che caratterizza la pronuncia è la sua progettualità, che ha perseguito, nella sua complessa sequenza, un ben preciso obiettivo quanto all’assetto che si voleva l’ordinamento italiano assumesse sul c.d. “fine-vita” [57].
E sembra francamente un pretesto quello che da più parti viene presentato come il motivo del ruolo “interventista” della Corte, e cioè la crisi di efficienza della politica che tarderebbe a – o mancherebbe del tutto di – fornire soluzioni legislative ai problemi, tra cui quello riguardante le condizioni e i modi di esercizio dell’aiuto al suicidio. In realtà, non può che concordarsi con chi ritiene che, nel caso di specie, non vi fosse, invece, alcun “vuoto di disciplina”, giacché il legislatore si era premurato di colmarlo proprio con la legge n. 219/2017[58], da cui, al contrario, la Corte ha ritenuto di trarre “i criteri di riempimento costituzionalmente necessari” utilizzabili nelle more di un sollecitato intervento del Parlamento.
Ma, da quella legge, che ha di fatto sancito il riconoscimento del diritto di rifiutare le cure, erano state intenzionalmente escluse proprio le condotte di cui agli art. 579 e 580 c.p., «che il legislatore non ha sentito il bisogno di modificare, ritenendole non incompatibili con le nuove norme, o comunque dirette a regolare situazioni ad esse estranee»[59].
In ogni caso, ove anche fossero ravvisabili ritardi e carenze dei decisori politici, il rimedio giusto non sarebbe, comunque, «quello degli eccessi dei garanti che, non meno dei primi, concorrono a mettere sotto stress la Costituzione e lo Stato che da essa prende il nome»[60]. E non lo sarebbe, a maggior ragione, nella materia penale, nella quale la scelta dei beni suscettibili di tutela e la determinazione del contenuto delle singole opzioni incriminatrici devono rimanere affidate all’apprezzamento del legislatore “rappresentativo” della società.
S’è visto invece come l’intervento della Corte abbia determinato un contrasto con alcuni dei principi su cui si regge la normazione penale desumibili dall’art. 25 Cost., soprattutto per quello che riguarda la riserva di legge e la determinatezza della fattispecie. È vero che quando si parla della riserva di legge e della tassatività si fa in genere riferimento alla funzione di garanzia di tali principi (prevenire l’arbitrio del potere giudiziario e di quello esecutivo a tutela della libertà personale del cittadino); ma è evidente che la violazione del principio cui consegua un allargamento dell’area di non punibilità pone comunque problemi[61], perché, una volta “forzato” il principio a fini asseritamente commendevoli, nulla vieta che la sua “tollerata” inosservanza sia in futuro funzionale ad una invasione del potere giudiziario o esecutivo che limiti, anziché estendere, le garanzie di libertà del cittadino[62].
Insomma, il principio piegato al fine da raggiungere suggerisce scenari poco rassicuranti. Qui non è in discussione tanto la meritevolezza del fine. È in discussione che, una volta che si introduca la deroga al principio, essa sarà utilizzabile per qualunque fine si intenda perseguire, anche per il meno nobile e più discutibile (e sempre ammesso che quello per cui è stato piegato il principio in questo caso fosse proprio da perseguire).
Già prima della sentenza n. 242/19 e in tutt’altra occasione, un illustre costituzionalista aveva messo in guardia dai rischi connessi alle deviazioni dal modello costituzionale della tutela dei diritti, il quale vuole che sia il legislatore, e non i giudici (ordinari o costituzionali), a definire i diritti da riconoscere e le modalità della loro tutela.
Osservando che la Corte costituzionale non fosse priva di responsabilità nell’indebolimento di tale modello, lo studioso in questione aveva ricordato le condizioni che dovrebbero assicurare alla stessa Corte il ruolo e le caratteristiche proprie del giudice (anziché del legislatore) in questi testuali termini: «occorre che essa riconosca e applichi i principi che definiscono la giurisdizione, ciò che delimita i poteri di ogni giudice: i principi della domanda e della corrispondenza tra richiesto e pronunciato. Sono canoni, non regole tassative, ma il loro nucleo essenziale è intrinsecamente legato alla legittimazione del giudice. L’intero giudizio incidentale di legittimità costituzionale è tessuto con un unico filo, che inizia dall’interesse ad agire davanti al giudice comune, prosegue con la rilevanza della questione incidentale, continua con il principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato (che non a caso si applica anche alla giurisprudenza costituzionale), e si conclude con la tipicità degli effetti della sentenza di accoglimento (espressa come “divieto di applicazione” della disposizione che ne è colpita). È un filo che non si può spezzare, perché, colpendo il singolo segmento, verrebbe meno l’intero percorso»[63].
La sentenza n. 242 del 2019 fornisce una conferma a quelle preoccupazioni. E dimostra quali negative conseguenze possono prodursi quando “il filo si spezza”.
* Contributo sottoposto a valutazione.
[1] Sin da V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale. II, 2 La Corte costituzionale, Padova, 1976, p. 340; ma ancora oggi, come, per esempio, R. Bin-G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, Torino, 2019, p. 482.
[2] Come ricorda R. Di Maria, Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in www3.unisi.it/eventi/gruppodipisa2007, p.13 – al quale si rimanda, in generale, per una più approfondita valutazione della operatività del principio in questione nel processo costituzionale –, è questo il preciso riferimento normativo dal quale dedurre l’applicazione della regola anche nell’ambito del processo costituzionale.
[3] A. Pisaneschi, Diritto costituzionale, Torino, 2017, pp. 595-596.
[4] V. Crisafulli, Lezioni, cit., p. 341.
[5] Lo evidenziano, tra gli altri, A. Ruggeri-A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2014, pp. 242-243. Ma lo notava già negli anni ’70 V. Crisafulli, Lezioni, cit., p. 342.
[6] Si vedano, per esempio, le sentenze n. 239 del 18.11.2019, n. 221 del 23.10.2019 (peraltro, avente ad oggetto la pretesa incostituzionalità di norme di una legge – la n. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita – egualmente relative ad un tema c.d. eticamente sensibile e per di più redatta dallo stesso estensore della sentenza n. 242/19, di poche settimane successiva), n. 7 del 17.1.2019, n. 194 dell’8.11.2018.
[7] V. Crisafulli, Lezioni, cit., p. 341.
[8] A. Pisaneschi, Diritto costituzionale, cit., p. 596.
[9] A. Ruggeri-A. Spadaro, Lineamenti, cit., p. 242.
[10] Lo afferma lo stesso Servizio Studi della Corte costituzionale, La prassi del controllo di costituzionalità nell’attualità: tipologia delle decisioni “di merito” nei giudizi sulle leggi, Incontro di Lavoro con il Supremo Tribunale Costituzionale (Brasilia 17 marzo 2008), p. 3, pur precisando, ovviamente, che dal rigido schema accoglimento-rigetto e dal ruolo limitato che esso comporta la Corte si è sin dall’inizio distaccata, ritenendoli insufficienti «sia per ragioni di ordine logico-giuridico, sia per le contingenze storico-politiche esistenti nel momento in cui la Corte costituzionale cominciò ad operare» (p. 6). Ancora recentemente F. Giunta, Note minime su politica criminale e controllo di costituzionalità, in Discrimen 18.1.2019, pp. 2-4, ha ricordato che la Consulta è sì il solo organo che può censurare la scelta politica del legislatore, ma solo in termini di legittimità e non anche sotto il profilo del merito, che è giuridicamente insindacabile, rimarcando che in genere la Corte, salvo rare eccezioni, si è guardata bene dall’abbandonare il piano della legittimità, di sua stretta competenza, per approdare ad un sindacato del merito politico-criminale, che invece le è estraneo, anche in presenza di scelte massimamente opinabili.
[11] Lo evidenzia anche G. Razzano, La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un’ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?, in Dirittifondamentali.it, fascicolo 1/2019, p. 3. L’A. rileva che la Corte, per un verso, asserisce che i giudici di Milano invocano una pronuncia a carattere meramente ablativo che non implica intervento “creativo”, e, per l’altro, non procede ad alcuna ablazione, mentre, però, «è difficile non notare la multiforme creatività della pronuncia in questione».
[12] Si tratta dello stesso avverbio che usa la Corte nell’ordinanza, appena dopo la solenne affermazione del diritto alla vita e della conformità a Costituzione della incriminazione dell’aiuto al suicidio, quasi a voler creare – come sottolinea efficacemente G. Rocchi, L’importanza degli avverbi, in L-JUS 1/2019, pp. 37-40 – un collegamento logico, invece non poco problematico, tra la prima affermazione e quella successiva, di segno ben contrario.
[13] Del resto, già all’indomani dell’ordinanza di rimessione della Corte d’Assise di Milano l’art. 32 Cost. era stato definito “il grande assente” della questione di legittimità costituzionale da A. Alberti, Il reato d’istigazione o aiuto al suicidio davanti alla Corte costituzionale. Il “caso Cappato” e la libertà di morire, in Forum di Quaderni Costituzionali 20.3.2018, p. 7, che, nel sottolineare le “ombre” dell’ordinanza stessa e nel prefigurare (sostanzialmente rammaricandosene) il mancato accoglimento della questione «nei termini proposti dal giudice a quo», così osservava: «Diverso sarebbe stato, invece, se l’ordinanza di rimessione avesse prospettato, in nome della libertà costituzionale al suicidio, non già la liceità di qualsiasi condotta agevolativa (non influente sul processo volontario del suicida), bensì la liceità di quelle condotte agevolative che intervengono in soccorso di chi sceglie la morte per sottrarsi a una vita di sofferenza clinica irrimediabile, ossia per liberarsi di una vita condannata a trattamenti terapeutici permanenti e dolorosi. Ma per giungere a una delimitazione chirurgica del dispositivo di accoglimento nel senso che si è detto occorreva specificare meglio il parametro del giudizio costituzionale, valorizzando in modo particolare l’art. 32 della Costituzione (…)».
[14] Così M. D’Amico, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), in Rivista AIC 1/2020, p. 289. Ancor prima dell’ordinanza n. 207/18, anche A. Morrone, Il “caso Cappato” davanti alla Corte costituzionale. Riflessioni di un costituzionalista, in A. Morrone (a cura di), Il “caso Cappato” davanti alla Corte costituzionale (Università di Bologna-12 ottobre 2018), in www.forumcostituzionale.it, 2018/10, p. 12, aveva significativamente osservato: «i rilevati limiti formali e sostanziali dell’ordinanza di rimessione e, soprattutto, la debolezza dell’impianto teorico che la sorregge (scambiando “libertà” per “diritto soggettivo”), spingono la vicenda Cappato verso un esito lineare nel senso di una decisione di rigetto (o processuale o nel merito). L’unico margine sarebbe quello di aggirare il cuore della domanda del giudice a quo (volto, lo ripeto, a riconoscere un diritto alla morte, con tutti gli aggettivi che si vogliono) e tentare la strada strettissima di un’interpretativa (di rigetto o di accoglimento) dell’art. 580 c.p. per trarne, in rapporto alle condotte oggi disciplinate dalla legge sulle DAT, alcune conseguenze sulle condotte di aiuto al suicidio». Ma che si trattasse di una operazione rischiosa, lo evidenziava anche G. Di Cosimo, Scaletta della relazione di base, in A. Morrone (a cura di), Il “caso Cappato”, cit., pp. 18-19, il quale, pur prevedendo che la Corte potesse eccezionalmente recuperare il parametro dell’art. 32 Cost. deducendolo implicitamente dalla motivazione dell’ordinanza di rimessione, aggiungeva tuttavia: «Eccezionalmente perché, in linea generale, la Corte non può definire da sé stessa i confini delle questioni, pena un pericoloso eccesso di potere».
[15] P.F. Bresciani, Termini di giustificabilità del reato di aiuto al suicidio e diritti dei malati irreversibili, sofferenti, non autonomi, ma capaci di prendere decisioni libere e consapevoli (Nota a Corte cost., ord. n. 207/18), in Forum di Quaderni Costituzionali, 14.12.2018, p. 2.
[16] Così L. Pesole, L’intento della Corte costituzionale nell’ordinanza sul caso Cappato, in Giur. Cost. n. 6/2018, p. 2886, la quale osserva che, dopo aver respinto la prospettazione della questione da parte del giudice a quo, «la Corte avrebbe potuto tranquillamente adottare una pronuncia di inammissibilità (come di solito fa quando la materia esige l’intervento del legislatore) o addirittura una pronuncia di rigetto». Anche A. Natalini, Ordinanza monito con rinvio a data fissa, un caso da manuale, in Guida dir. 2018 nn. 49/50, p. 30, parla significativamente di una presa di distanze della Corte «dalle censure più radicali del rimettente». E di “confutazione” dell’ordinanza di remissione parla L. Eusebi, Un diritto costituzionale a morire «rapidamente»? Sul necessario approccio costituzionalmente orientato a Corte cost. (ord.) n. 207/18, in Discrimen, 19.12.2018, p. 2.
[17] M. D’Amico, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale, cit., p. 290.
[18] C. Tripodina, La “circoscritta area” di non punibilità dell’aiuto al suicidio. Cronaca e commento di una sentenza annunciata, in Corti supreme e salute 2019-2, p. 3; D. Pulitanò, A prima lettura. L’aiuto al suicidio dall’ordinanza n. 208/2018 alla sentenza n. 242/2019, in Giurisprudenza Penale Web, 2019-12, p. 1; E. Furno, Il “caso Cappato” ovvero dell’attivismo giudiziale, in Rivista AIC 1/2020, p. 305.
[19] Si tratta, in sostanza, di ciò che, prima dei pronunciamenti della Corte, prefigurava P. Veronesi, Aiuto al suicidio e fine vita del malato sofferente: quali possibili risposte della Consulta alla quaestio Cappato-DJ Fabo?, in A. Morrone (a cura di), Il “caso Cappato”, cit., p. 59, il quale, domandandosi problematicamente se la Corte costituzionale potesse estrapolare dalla motivazione dell’ordinanza di rimessione un petitum agganciato all’art. 32 Cost. e farsi carico in questo modo di una “rimodulazione” della questione, così concludeva: «Come il più comprende il meno, così la Corte potrebbe (forse) cimentarsi in questa operazione».
[20] Si veda la relativa ordinanza in data 10.7.2017 del g.i.p. del tribunale di Milano, riportata in L-JUS, Fascicolo speciale – ottobre 2018 sul tema “L’agevolazione al suicidio davanti alla Corte costituzionale. Documenti e considerazioni”, p. 5 e ss.
[21] M. D’Amico, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale, cit., p. 297.
[22] A. Ruggeri-A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., p. 152.
[23] P. Caretti-U. De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, 2006, p. 398.
[24] A. Pisaneschi, Diritto costituzionale, cit., p. 616.
[25] Anche A. Celotto-F. Modugno, La giustizia costituzionale, in F. Modugno (a cura di), Diritto pubblico, Terza edizione, Torino 2017, p. 755, affermano che la efficacia erga omnes di una decisione di illegittimità costituzionale significa che essa «elimina una volta per tutte la norma dichiarata incostituzionale dall’ordinamento, nel futuro e nel passato». Uno dei due Autori citati, come si vede, è il giudice costituzionale estensore della sentenza n. 242/19.
[26] C. Cupelli, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a sé stessa. La sentenza n. 242 del 2019 e il caso Cappato, in Sistema penale 12/2019, p. 51, il quale ribadisce che modalità e garanzie sostanzialmente equivalenti a quelle procedimentali enucleate dai giudici costituzionali non potranno valere per i fatti successivi alla pubblicazione della sentenza. Sostiene lo stesso, sia pure da una prospettiva diversa, M. Donini, Libera nos a malo. I diritti di disporre della propria vita per la neutralizzazione del male. Note a margine delle “procedure legittimanti l’aiuto a morire” imposte da Corte cost. n. 242/2019, in Sistema penale, 10.2.2020, p. 21, il quale afferma che «condotte future di aiuto non “proceduralizzate” saranno sia tipiche, sia illecite, sia punibili, allo stato, perché ora che il diritto è stato “disciplinato secondo una procedura” da parte della Corte, dipende anche dall’esercizio e dall’osservanza delle verifiche richieste il fatto che si producano gli obblighi per il sistema sanitario».
[27] C. Cupelli, Il Parlamento decide di non decidere, cit., p. 51.
[28] Così A. Natalini, Inedita scriminante procedurale applicabile in futuro, in Guida dir. 2020 n. 3, p. 74,
[29] V. E. Palombi, Istigazione o aiuto al suicidio (voce), in Enc. Dir. XXII 1972, il quale sostiene condivisibilmente che il delitto di cui all’art. 580 c.p. è punito a titolo di dolo generico: il reo non può volere il suicidio, che rientra nella sfera volitiva di dominio della vittima. L’A. aggiunge che se la morte della vittima fosse considerata come il fine ulteriore che l’azione di propone di raggiungere, non occorrerebbe allora, ai fini della esistenza del reato, il verificarsi del suicidio, che al contrario è espressamente richiesto dall’art. 580 c.p.
[30] Così C. Pedrazzi, Inefficaci le sentenze manipolative in materia penale?, in Riv. it. dir. proc. pen. 1975, p. 646 e ss. (scritto riportato in C. Pedrazzi, Diritto penale, I, Scritti di parte generale, Milano, 2003, p. 385).
[31] Così T.E. Epidendio, L’ordinanza n. 207 del 2018 tra aiuto al suicidio e trasformazione del ruolo della Corte costituzionale, in L-JUS n. 1/2019, pp. 26-27. Anche M. D’Amico, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale, cit., p. 287, sottolinea che, tra i profili di rilievo di quella che è stata definita come una decisione “storica”, vi sono anche «le sue ricadute sul principio di legalità penale».
[32] Così li definiscono, per esempio, G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, Parte generale, Bologna, 2019, p. 52.
[33] Punto §4 del Considerato in diritto.
[34] Cfr. V. Manes, Principi costituzionali in materia penale (diritto penale sostanziale), in www.cortecostituzionale.it, ottobre 2014, p. 18, il quale, evidenziando che per orientamento consolidato risalente agli anni ’60 è da ritenersi che nell’art. 25 comma 2 Cost. trovino riconoscimento implicito i principi di determinatezza e tassatività del reato, ricorda, richiamando soprattutto la sentenza n. 327/2008, che i due obiettivi fondamentali del principio sono, per un verso, evitare che, in contrasto con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l’illecito, e, per l’altro, garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta.
[35] Rileva, a tal proposito, A. Ruggeri, Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunziata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019), in Giustizia insieme, 27.11.2019, p. 4: «Si pensi solo (…) alla sorte dei casi analoghi a Cappato, insorti prima della decisione di oggi, dalla Corte parimenti riportati sotto l’“ombrello” protettivo della non punibilità dell’aiuto prestato al suicidio, sempre che siano allo scopo utilizzate modalità idonee “a offrire garanzie sostanzialmente equivalenti”; ed è facile previsione che non poche controversie al riguardo insorgeranno, tali da mettere a dura prova gli operatori chiamati a risolverle».
[36] Sovviene, al riguardo, la sempre attuale considerazione, a proposito delle sentenze manipolative in materia penale, di C. Pedrazzi, Inefficaci le sentenze “manipolative” in materia penale?, cit., p. 382: «Le carenze, per cominciare, sotto il profilo della certezza, essenziale nel nostro campo, sono sotto gli occhi di tutti. Frutto di sottili alchimie, le pronunce di questo tipo non parlano il linguaggio piano e diretto che si può e si deve pretendere da una legge, come quella penale, la cui ignoranza non è consentita ad alcuno. Troppo poco maneggevoli, per adattarsi ad una funzione imperativa, i “dispositivi molto tormentati”, o i problematici rinvii tra dispositivo e motivazione».
[37] Si veda, a questo proposito, il contributo del Direttore dell’Unità di Bioetica e Presidente del Comitato Etico dell’Istituto Superiore di Sanità e Vicepresidente del Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici Territoriali, C. Petrini, Suicidio assistito. Dopo la sentenza della Consulta, quattro scenari per i comitati etici abilitati ad esprimersi su eventuali richieste, in quotidianosanità.it, 18.2.2020, il quale (ancora dopo quasi cinque mesi dalla sentenza della Corte) osserva che nella normativa italiana l’espressione “territoriali” riferita ai comitati etici compare per la prima volta nell’art. 2 della legge 11 gennaio 2018 n. 3, al cui comma 7 si stabilisce poi: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i comitati etici territoriali fino a un numero massimo di quaranta». Ad oggi, tuttavia, il decreto istitutivo dei quaranta comitati etici territoriali, che si sarebbe dovuto adottare entro il 15 aprile 2018, non è ancora stato emanato. Attualmente, quindi, sono operativi solo i comitati etici istituiti dalle Regioni ai sensi del precedente decreto del Ministro della Salute 8 febbraio 2013 (citato in sentenza dalla Corte costituzionale).
[38] È certamente condivisibile che tra le due questioni sollevate nell’ordinanza di rimessione intercorresse un rapporto di subordinazione, il quale – come ricorda G. Pelagatti, “Motivi assorbiti” e giudizio di costituzionalità, in Dirittifondamentali.it, fasc. 1/2019, p. 15 – è definibile come una relazione di interdipendenza logica tra le questioni costitutiva dell’oggetto del giudizio «che implica l’adozione di un ordine processuale nell’esame di esse nel corso del giudizio. Data questa relazione di interdipendenza, una determinata questione – subordinata – può essere sottoposta al vaglio del giudice unicamente nell’ipotesi in cui un’altra – detta principale – sia stata esaminata e respinta».
[39] Si veda A. Natalini, Inedita scriminante procedurale, cit., p. 74, il quale sostiene che la questione attinente al quantum di pena «non può dirsi tecnicamente “assorbita”, perché l’articolo 580 del c.p. non è stato espunto in toto, e anzi – per espresso rilievo della Corte – conserva la sua ragionevolezza nella normalità dei casi, quale divieto penale posto a presidio dei soggetti vulnerabili. La censura sull’esorbitanza del minimo edittale della pena per l’aiuto al suicidio (identica a quella dell’istigazione: cinque anni di reclusione) rimane perciò in piedi (…). Non è dato sapere perché la Corte abbia “schivato” il merito di questa questione».
[40] V. G. Pelagatti, “Motivi assorbiti”, cit., p. 31, il quale sostiene che l’assorbimento improprio dei motivi (da intendersi come l’ipotesi in cui sia dichiarato l’assorbimento di censure di costituzionalità anche quando una determinata decisione non sia effettivamente inclusiva di un’altra) produce per questo un deficit motivazionale, che tuttavia non rileva propriamente come vizio della sentenza della Corte costituzionale, la quale rimarrà pienamente produttiva di effetti giuridici, senza che sia esperibile alcun rimedio.
[41] La stessa Corte costituzionale ha più volte richiamato, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, l’effetto preclusivo, previsto dall’art. 24, secondo comma, legge n. 87 del 1953, alla riproposizione di questioni nel corso dello stesso giudizio, che opera allorché risultino identici tutti e tre gli elementi che compongono la questione (norme impugnate, profili di incostituzionalità dedotti, argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalità): in questo senso, si veda, per esempio, la sentenza n. 225 del 1994. Viceversa, non si determina la preclusione a riproporre nel corso di un medesimo giudizio una questione di legittimità costituzionale, già dichiarata infondata, soltanto quando la questione, pur attenendo alla stessa norma e facendo riferimento ad un parametro costituzionale già invocato, risulta tuttavia formulata in termini nuovi e basata su argomentazioni diverse derivanti da un “quid novi” costituito dallo “ius superveniens”: in questi termini, per esempio, la sentenza n. 257 del 1991.
[42] Si vedano, a questo proposito, le sentenze nn. 113 del 2011 e 215 del 1998, con cui la Corte costituzionale ha affermato che il giudice a quo non può rimettere una seconda volta la medesima questione nel corso dello stesso grado del giudizio pendente fra le stesse parti, così da determinare un bis in idem, che si risolverebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte.
[43] Cfr. G. Pelagatti, “Motivi assorbiti”, cit., pp. 6-7.
[44] P. Carnevale, Incappare in… Cappato. Considerazioni di tecnica decisoria sull’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale, in Consulta online 2019 fasc. II, p. 384, il quale aggiunge ancor più chiaramente: «Si può dire che i contorni di quel caso e i contorni della prefigurata incostituzionalità dell’art. 580 c.p. tendano, in buona misura, a combaciare. Basti qui la significativa somiglianza fra l’elenco dei requisiti che delineano la situazione che deve poter beneficiare in astratto della sottrazione al divieto di aiuto al suicidio e le circostanze concrete in cui è maturata la prestazione assistenziale offerta dall’imputato nel giudizio principale. Si può altrimenti dire che la motivazione dell’ordinanza lasci trasparire come in filigrana i drammatici eventi che hanno accompagnato la morte del Dj Fabiano Antoniani con il supporto fornito da Marco Cappato».
[45] T.E. Epidendio, L’ordinanza n. 207/18, cit., p. 30.
[46] T.E. Epidendio, La sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019: apocalypsis cum figuris, in Giudicedonna.it nn. 2-3/2019, p. 6.
[47] Così L. Violini, Ma una sentenza non basta a risolvere il problema della vita, in Il sussidiario.net, 26.9.2019, che considera: «La coincidenza con il caso è pressoché totale: tutti ci siamo commossi per il suo destino, tutti abbiamo partecipato al suo dramma, forse anche pensato che chi lo ha “agevolato” abbia fatto il suo bene, compiuto il suo desiderio, dato forma alle sue ultime volontà. A quel capezzale c’eravamo tutti e abbiamo vissuto o rivissuto con lui il viaggio, la camera della clinica, le sue ultime parole, financo i suoi ultimi pensieri, i suoi cari, la sua pace. Si narra così la dolce morte, che ha uno sfondo di bene, di affetti sinceri, di pena mitigata dal pensiero di aver fatto quello che l’altro o l’altra desiderava e che tutti desideriamo: che la morte sia dolce, che la terra ci sia lieve».
[48] Cfr. T.E. Epidendio, La sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, cit., pp. 4-5, il quale rimarca, al tempo stesso, che prima di ora i contenuti con cui colmare i presunti vuoti di disciplina erano sempre stati individuati in “punti di riferimento” rinvenibili nel “sistema”, intesi come punti di riferimento “giuridici” e “normativi”, cioè ricavati da tratti di disciplina dettata dal legislatore per altri casi, e che, tuttavia, potevano prestarsi a fornire un contenuto compatibile con la Costituzione ad una diversa disciplina considerata illegittima.
[49] T.E. Epidendio, La sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, cit., p. 1.
[50] Così, tra gli altri, A. Ruggeri, Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, cit., p. 1.
[51] V. R. Di Marco, Ancora su taluni rilevanti problemi giuridici del «Caso Cappato», in www.filodiritto.com, 20 Febbraio 2020, il quale argomenta che, proprio perché la regolamentazione dettata dalla Corte non può considerarsi “a contenuto costituzionalmente vincolato”, i giudici hanno allora operato scelte di politica del diritto ultronee rispetto alle competenze e alle prerogative della Corte costituzionale.
[52] «Sul piano … della ricostruzione teorica, la sentenza n. 242 si configura come derogatoria della legge, in quanto sottrae alla disciplina generale, che resta in vigore, una fattispecie particolare; proprio per questo la sentenza è, anche, inevitabilmente normativa, in quanto ha innovato il diritto oggettivo, individuando la disciplina del caso specifico, sottratta alla regola generale, in termini di generalità e astrattezza»: così G. Razzano, Nessun diritto di assistenza al suicidio e priorità per le cure palliative, ma la Corte costituzionale crea una deroga all’inviolabilità della vita e chiama «terapia» l’aiuto al suicidio, in Dirittifondamentali.it, fasc. 1/2020, p. 642.
[53] Cfr. T.E. Epidendio, L’ordinanza n. 207/18, cit., p. 19, il quale pone nel prosieguo il problema della vaghezza dei fondamenti di legittimazione di un organo giurisdizionale, sia pure sui generis, come la Corte costituzionale (opportunamente privo di responsabilità politica) a creare ed elaborare norme giuridiche che richiedano scelte politiche.
[54] G. Razzano, Il diritto di morire come diritto umano? Brevi riflessioni sul potere di individuazione del best interest, sull’aiuto alla dignità di chi ha deciso di uccidersi e sulle discriminazioni nell’ottenere la morte, in L-Jus – Fascicolo speciale-ottobre 2018 sul tema “L’agevolazione al suicidio davanti alla Corte costituzionale. Documenti e considerazioni”, p. 134.
[55] M. D’Amico, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale, cit., p. 288.
[56] T.E. Epidendio, La sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, cit., p. 13.
[57] G. Razzano, La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un’ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?, in Dirittifondamentali.it, Fasc. n. 1/2019, p. 20.
[58] C. Tripodina, La “circoscritta area” di non punibilità, cit., p. 11.
[59] A. Morrone, Il “caso Cappato” davanti alla Corte costituzionale, cit., p. 4.
[60] Così, condivisibilmente, A. Ruggeri, Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, cit., p. 4.
[61] Già C. Pedrazzi, Sentenze “manipolative” in materia penale, in Riv. it. dir. proc. pen. 1974, p. 444 ss. (scritto riportato in C. Pedrazzi, Diritto penale, I, Scritti di parte generale, Milano, 2003, pp. 377-378), scriveva, a proposito di una pronuncia additiva della Corte in bonam partem, che «non è questa una giustificazione sufficiente, se è vero che la ratio della riserva non va individuata in una generica garanzia di certezza e conoscibilità della norma incriminatrice, ma nell’esigenza di affidare la delimitazione tra il lecito e l’illecito all’Organo costituzionale che più direttamente esprime la sovranità popolare». Anche E.M. Ambrosetti, Nuovi orizzonti per le sentenze manipolative nel diritto penale?, in Discrimen, 23.5.2019, pp. 2-3, afferma che «il vero problema non deriva dagli effetti favorevoli o sfavorevoli al reo derivanti dalla sentenza di parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, ma dal fatto che attraverso queste pronunce la Corte si arrogherebbe una funzione squisitamente politica delle scelte normative in ambito penalistico».
[62] Osserva, a tal proposito, A. Ruggeri, op. loc. ult. cit., che «se il prezzo da pagare per vedere finalmente riconosciuto ed effettivamente salvaguardato un diritto costituzionale è quello riportabile alla inesorabile “logica” machiavellica del fine che giustifica il mezzo, si può obiettare che lo snaturamento dei ruoli istituzionali è un prezzo che l’ordinamento costituzionale non è in grado di pagare, dal momento che ne sarebbero fatalmente contagiati gli stessi diritti».
[63] R. Bin, Chi è il giudice dei diritti? Il modello costituzionale e alcune deviazioni, in Rivista Aic n. 4/2018, p. 644.