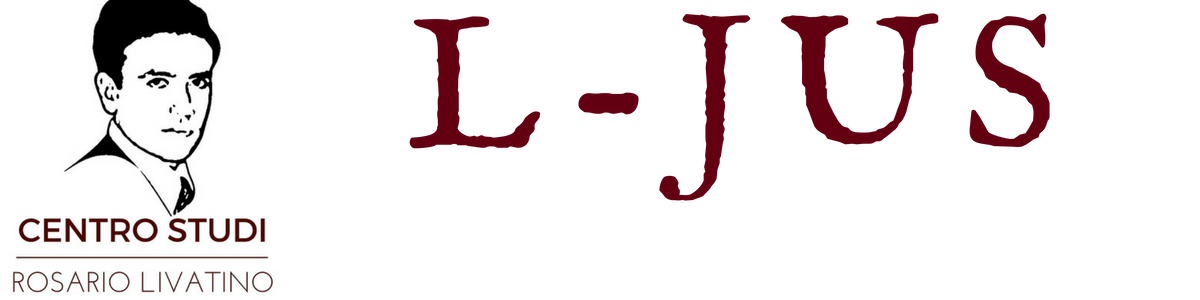Centro Studi Livatino
D.D.L. A.S.735 – NORME IN MATERIA DI AFFIDO CONDIVISO, MANTENIMENTO DIRETTO E GARANZIA DI BIGENITORIALITÀ.
PROFILI CRITICI E RAGIONI DI CONTRARIETÀ
Il disegno di legge n. 735 ha l’obiettivo dichiarato di apportare rettifiche all’attuale normativa in materia di affidamento condiviso e, più nel dettaglio, di modificare quanto finora previsto, in caso di separazione dei genitori, sul mantenimento dei figli e sulla regolamentazione dei rapporti di ciascun genitore con i figli stessi.
Muovendo dal presupposto della centralità della famiglia, nella relazione illustrativa al d.d.l., vengono puntualmente indicati quattro criteri di riferimento, ossia i quattro pilastri su cui si fonda la proposta di riforma:
- la mediazione civile obbligatoria,
- l’equilibrio tra entrambe le figure dei genitori,
- il mantenimento dei figli in forma diretta e
- il contrasto alla c.d. “alienazione genitoriale”.
Come Centro Studi Livatino, formato da magistrati, avvocati, docenti di materie giuridiche e notai, che fra i propri impegni statutari ha in modo specifico la riflessione sui temi della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, riteniamo importante il richiamo alla bigenitorialità – principio fondamentale, purtroppo non sempre attuato nella pratica quotidiana delle crisi familiari –, alla responsabilità dei genitori, alla mediazione familiare come strumento per favorire la conciliazione. Ma osserviamo che dalla lettura degli articoli che compongono il d.d.l. emergono non pochi problemi. Essi meritano attento esame, che segue facendo riferimento proprio all’impostazione dei “quattro pilastri” sopra menzionati.
Se – con le dovute cautele – è apprezzabile l’intento dichiarato nella relazione al d.d.l. di rimettere al centro delle crisi coniugali «la famiglia e i genitori e restituendo in ogni occasione possibile ai genitori il diritto di decidere sul futuro dei figli e lasciando al giudice il ruolo residuale di decidere in caso di mancato accordo», la lettera della varie disposizioni sembra perseguire tale obiettivo con pericolosi automatismi. E se è incontrovertibile il celebre assunto di Arturo Carlo Jemolo – «la famiglia è un’isola che deve essere solo lambita dal diritto» –, da cui deriva l’esigenza di valorizzare la famiglia medesima in quanto «un organismo normalmente capace di equilibri e bilanciamenti che la norma giuridica deve rispettare quanto più possibile», i singoli passaggi del d.d.l. paiono condurre su un terreno nella sostanza diverso.
La presente memoria, consegnata al Relatore del d.d.l. in occasione di un incontro da egli promosso con associazioni o centri studi che si interessano dei profili giuridici dell’istituto familiare, sarà poi depositata in occasione della audizione di rappresentanti del Centro Studi Livatino da parte della Commissione Giustizia del Senato[1]. Costituisce un primo contributo dello stesso Centro Studi: viene portato all’attenzione del Relatore e dei Senatori, nella consapevolezza che saranno necessari ulteriori approfondimenti, in un confronto ancora più serrato con la legislazione vigente e con i problemi applicativi che essa comporta, anche alla stregua dell’intervento del legislatore del 2006, delle soluzioni positive allora introdotte, del seguito che hanno o non hanno avuto nell’esperienza delle aule giudiziarie.
- La mediazione familiare
1.1. In generale
La mediazione familiare può certamente avere un ruolo importante nella definizione di un accordo di separazione, sia quanto agli aspetti economici, sia quanto alla regolamentazione del rapporto genitori/figli. Quando due persone decidono di separarsi vi è sempre un più o meno elevato grado di conflittualità, che è l’esito di frustrazione, disagio, delusione, sconforto, se non addirittura di rabbia. La separazione rappresenta comunque un fallimento (del progetto familiare, delle aspettative di vita di coppia, dei progetti per il futuro proprio e dei propri figli), che non necessariamente può essere attribuito a uno dei partner, anche se spesso alla base dei contrasti vi è la non accettazione delle proprie responsabilità. Tutto ciò è noto in particolare a chi, come avvocato, si occupa della materia; ed è altrettanto nota l’importanza di aiutare la coppia – soprattutto in presenza di figli minori e se le circostanze lo consentono – a dialogare per trovare un accordo, piuttosto che continuare a discutere in un’aula di Tribunale. In alcuni casi, gli avvocati sono in grado di raggiungere questo obiettivo, in altri hanno bisogno dell’ausilio del mediatore familiare, ossia di un esperto capace di entrare in comunicazione con ciascuna delle parti in conflitto e di stimolare nelle stesse, senza esercitare pressioni, una libera elaborazione della soluzione e una gestione pacifica delle differenze.
La mediazione familiare appare dunque un mezzo in sé valido. Tuttavia, quanto previsto dal d.d.l. 735 lascia molto perplessi. Va premesso che i rapporti all’interno della famiglia sono considerati dal nostro ordinamento come meritevoli di specifica protezione da parte dello Stato che, per tutelarne i soggetti più fragili (minore, coniuge più debole), ha previsto una normativa non derogabile dalle parti; e che in presenza di figli minori, nel rispetto delle convenzioni internazionali (tra tutte la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia firmata a New York, 20 novembre 1989 ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176 e la Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata in Italia con legge 20 marzo 2003 n. 77), l’interesse del minore è obiettivo primario da perseguire. Si assiste da anni ad una progressiva degiurisdizionalizzazione del diritto di famiglia, sovente a discapito della parte più debole: si ricordino il c.d. divorzio breve – che in poco tempo pone in difficoltà economica il coniuge più debole che subisca la scelta dell’altro –, la crescente perdita di rilievo che ha assunto il mancato adempimento ai doveri del matrimonio, in primis l’obbligo di fedeltà, la possibilità di procedere alla separazione o al divorzio in Comune, senza il controllo del magistrato a garanzia del coniuge meno forte. Pur nella consapevolezza del danno causato da pronunce giurisprudenziali “creative” in tema di diritto di famiglia, talora con decisioni “praeter legem”, proprio la progressiva degiurisdizionalizzazione non sembra garantire una maggiore tutela.
Dalla lettura degli articoli relativi alla mediazione (art. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 22) e alla nuova figura del coordinatore genitoriale (art. 5), nonché dalla stessa relazione illustrativa, emerge un dato importante: la sovrapposizione fra il modello di mediazione familiare cui sopra si è accennato e il modello di mediazione civile tipico degli altri settori del diritto. Si legge infatti nella relazione (p. 2), a sostegno dell’obbligatorietà della mediazione: «è tuttavia ben strano che sia stata imposta la mediazione preventiva in settori assai meno coinvolgenti la vita delle persone e invece si pongano forti limitazioni con riguardo alla materia del diritto di famiglia». In realtà, in quei settori assai meno coinvolgenti la vita delle persone la mediazione svolge un ruolo diverso: è finalizzata a evitare controversie giudiziarie, e l’accordo che viene raggiunto consiste di fatto in una transazione: le parti coinvolte si fanno reciproche concessioni, rinunciano – grazie all’aiuto del mediatore – ad alcune pretese pur di arrivare ad una definizione rapida della lite. Nella maggior parte dei casi dopo una mediazione civile, definita la causa attorno al tavolo del mediatore e sottoscritto il relativo verbale, le parti coinvolte non hanno necessità di rivedersi o di avere rapporti personali.
La mediazione civile infatti è concepita come percorso alternativo per dare soluzione rapida, in tempi definiti, a controversie civili relative a diritti disponibili, alleggerendo il sovraccarico del sistema giudiziario, e questo spiega il favore della giustizia ordinaria nell’indirizzare verso questo tipo di strumento. I dati sulla sua reale efficacia non sono invero confortanti: dalle statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia per il 2017, a sette anni dall’entrata in vigore della mediazione civile risulta che: (i) meno di un quarto delle controversie trova una soluzione concordata grazie alla mediazione, (ii) nei casi in cui la mediazione è stata disposta dal giudice oppure è condizione di procedibilità le percentuali di fallimento sono rispettivamente del 78% e dell’86%, (iii) la percentuale di successo della mediazione è inversamente proporzionale al valore della causa. Così per es. per le controversie dello scaglione di valore da € 1.000 a 5.000 gli accordi raggiungono il 34% dei casi trattati, per lo scaglione compreso fra € 500.000 e i 2.500.000 la percentuale di soluzione positiva scende al 12%. Quest’ultimo dato fa concludere che più rilevanti sono le questioni trattate e/o i valori oggetto della controversia e maggiore è la percentuale di insuccesso della mediazione.
La mediazione familiare risponde ad altre logiche: le parti coinvolte, anche se separate come coppia, dovranno comunque continuare ad avere rapporti fra di loro come genitori. L’obiettivo della mediazione, quindi, non può essere il mero raggiungimento di un accordo, come sembrerebbe suggerire l’art. 3 del d.d.l. 735. Obiettivo della mediazione familiare, laddove sia possibile iniziare un tale percorso – si ribadisce – è quello di aiutare la coppia a dialogare, a essere costruttivi, a mettere in discussione le proprie pretese e a liberarle dal carico di sofferenza che sovente è di ostacolo all’individuazione delle necessità dei figli. L’accordo poi magari arriverà, ma prima ancora sarà stato raggiunto un risultato più importante, che peraltro consentirà a quell’accordo di essere attuato e modulato in base alle esigenze dei minori: i genitori avranno compreso l’importanza di rispettarsi reciprocamente e di rapportarsi ai figli come persone, orientandosi verso scelte nell’interesse concreto della prole, e non nel proprio.
1.2. L’obbligatorietà della mediazione familiare
È per questo motivo che la mediazione familiare obbligatoria è una contraddizione in termini. Perché sia efficace la mediazione familiare deve essere libera ed incondizionata. Vi sono casi in cui essa deve essere addirittura esclusa, come nelle ipotesi di coppie ad altissima conflittualità, sfociata o in grado di sfociare in episodi di violenza fisica o morale. La violenza non è mediabile, anzi costituisce addirittura un limite per la mediazione, come asserito dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) approvata il 7 aprile 2011, ratificata in Italia con legge 27 giugno 2013 n. 77, che all’art. 48 stabilisce: «Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione». Vi sono dunque dei casi in cui la separazione è necessaria per salvaguardare l’integrità fisica e psicologica dei figli o di uno dei genitori, vittime magari di una forma di affettività patologica manifestata dall’altro genitore. Ecco allora che l’obbligatorietà della mediazione, in questi casi, non può che cagionare disagi e problemi, ma il d.d.l. non prevede deroghe, neppure in tali casi di violenza.
Ancor meno accettabile è che la mediazione familiare sia stata addirittura indicata come obbligatoria a pena di improcedibilità (art. 7 e art. 22) non soltanto – e già di per sé basterebbero – per le ragioni sin qui espresse. Attualmente, per le note carenze dell’organico, il termine di novanta giorni ex art. 706 comma 3 c.p.c.[2] per l’udienza presidenziale in realtà si allunga anche di mesi. Con la mediazione obbligatoria i tempi rischiano di allungarsi ulteriormente, e la procedura potrebbe essere usata per fini dilatori dal coniuge che non abbia interesse a una definizione rapida. Il combinato fra tempi dilatati e impossibilità di perseguire il coniuge che si sottragga all’obbligo di contribuzione penalizzerebbe in tal modo il coniuge più debole, privato di risorse economiche e/o messo in ristrettezze. Si potrebbe prevedere il deposito del ricorso per separazione, e lasciare al tempo intercorrente fra il deposito e la prima udienza l’esperimento del tentativo di mediazione; ma questo aiuterebbe fino a un certo punto: i giudici potrebbero essere indotti a fissare la prima udienza in tempi ancora più lunghi, mentre una coppia conflittuale ha bisogno delle prime disposizioni, pur provvisorie, date coi provvedimenti presidenziali. Va poi considerata la totale mancanza nel d.d.l. di indicazioni sulle persone con difficoltà economiche che avrebbero diritto al patrocinio a spese dello Stato: il testo non pone le spese di mediazione a carico dello Stato, a prescindere dal possesso dei requisiti per l’ammissione al patrocinio gratuito; l’art. 4 del d.d.l. si limita infatti a stabilire «la gratuità del primo incontro», ma nulla dispone per i successivi.
Un altro elemento critico riguarda l’art. 1 del d.d.l., cioè i requisiti per esercitare la professione di mediatore familiare. Al comma 2, lettera c) è previsto che la qualifica di mediatore familiare sia attribuita «anche agli avvocati iscritti all’ordine professionale da almeno cinque anni e che abbiano trattato almeno dieci nuovi procedimenti in diritto di famiglia e dei minori per ogni anno». Questa disposizione lascia perplessi, se si considera l’importanza che col d.d.l. si attribuisce alla mediazione familiare e alla sua funzione sociale riconosciuta dalla Repubblica ai sensi dell’art. 1 comma 1: se al mediatore familiare viene riconosciuto un simile ruolo, non si comprende perché sia stato lasciato ampio spazio di accesso, senza introdurre opportune garanzie di mirata professionalità: non sono tali l’aver trattato un certo numero di procedimenti di diritto di famiglia e dei minori.
Sarebbe come dire che una persona per il solo fatto di essere colta sia idonea a insegnare: è evidente che non è così. Il fatto di conoscere non garantisce di per sé la capacità di saper anche trasmettere agli altri. Allo stesso modo, un avvocato può aver trattato centinaia di separazioni e averlo fatto nella maniera peggiore, senza aver aiutato veramente le parti a comprendere l’importanza, specie in presenza di figli, di mettere da parte istanze egoistiche per aprirsi all’ascolto delle altre parti coinvolte. La capacità e la competenza nel mediare in ambito familiare, per la delicatezza e l’importanza della materia, non possono essere presunte ma devono essere accertate, pertanto quanto previsto dall’art. 1, comma 2 lett. c) è quanto meno incoerente con le premesse.
Da ultimo, ma non ultimo per il rilievo processuale che acquisisce l’istituto, è che la professione di mediatore al momento non è ancora regolamentata. Bisognerà vedere se quanto disposto all’art. 1 del d.d.l. sarà sufficiente a colmare la lacuna e in che tempi: se però la mediazione familiare è condizione di procedibilità già al momento della entrata in vigore della legge, essa deve avere le carte in regola per funzionare a regime, con un albo di mediatori già formati. Attualmente tale albo manca.
1.3. La mediazione familiare e il “coordinatore genitoriale”
L’art. 3 del d.d.l., nel mentre conferisce al mediatore ampi poteri per la definizione dell’accordo, non introduce idonee garanzie nell’ipotesi di partecipazione del minore, come invece va più avanti l’art. 16 comma 2 del d.d.l. a proposito di ascolto videoregistrato. Lascia perplessi che il mediatore familiare «su accordo delle parti» possa chiedere agli avvocati (con evidente discrezionalità) di non partecipare agli incontri successivi al primo, quando però gli avvocati «devono comunque essere presenti, a pena di nullità e inutilizzabilità alla stipulazione dell’eventuale accordo, ove raggiunto». La presenza degli avvocati dovrebbe garantire le parti, soprattutto quando vi siano questioni che riguardano i minori, pertanto non sono chiare le ragioni di una simile previsione. Appare poi di difficile attuazione quanto previsto dal comma 9 dell’art. 3, in base al quale il Tribunale provvede all’omologazione dell’accordo raggiunto in sede di mediazione entro quindici giorni dalla richiesta, senza poter avere accesso agli atti o documenti del procedimento di mediazione, per espressa previsione dell’art. 2, che impone l’obbligo di riservatezza (anche nel caso in cui vi siano questioni riguardati i minori). È un evidente limite alla cognizione del giudice e alla sua funzione di garante della correttezza e della congruità di quanto concordato fra le parti.
L’art. 5 del d.d.l. introduce poi la nuova figura del “coordinatore genitoriale”, definito «un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale»: egli, come spiega la relazione, «operando come terzo imparziale nell’ambito delle disposizioni di natura legale e deontologica della rispettiva professione (…), ha il compito di gestire in via stragiudiziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole minorenne relativamente all’esecuzione del piano genitoriale». È una figura privata – diversa dal mediatore familiare – cui sono attribuiti poteri decisionali (gestire in via stragiudiziale le controversie) nei casi in cui l’intervento del giudice sarebbe necessario, soprattutto a tutela dei minori, ossia nei casi di «alto livello di conflitto» (art. 5 co. 3, lett. a): una figura con compiti delicati e ampi poteri decisionali, senza che ne sia chiaro tuttavia il profilo di competenza. Il d.d.l. si limita a prevedere che possono esercitare la funzione di coordinatore genitoriale (art. 5 co. 2) psichiatri, neuropsichiatri, psicoterapeuti, psicologi, assistenti sociali, avvocati e mediatori familiari. Nulla è previsto sulla verifica delle effettive competenze e della imparzialità del “coordinatore genitoriale”, come nulla si dice sull’eventuale controllo del suo operato o delle decisioni che assume. Tutto ciò è poi reso più grave dall’esplicito esonero della sua responsabilità: in base all’art. 5 c. 4, infatti, «lo svolgimento dell’attività di coordinazione genitoriale non dà luogo a responsabilità personali, salvi i casi di dolo o colpa grave». È inquietante notare come si parli di responsabilità personale e non anche di responsabilità professionale.
Appare fonte di problemi pure l’art. 6, che rende immediatamente reclamabile l’ordinanza del Giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli. Come è noto, il procedimento di separazione e quello di divorzio sono caratterizzati da due fasi: una presidenziale e l’altra davanti all’Istruttore, mentre i provvedimenti provvisori e urgenti emessi dal Presidente possono essere subito reclamati davanti alla Corte d’Appello; successivamente, il processo proseguirà avanti al Giudice Istruttore che potrà modificarli, senza possibilità di ulteriore immediato reclamo. L’ulteriore immediata possibilità di impugnazione rischia di inasprire la lite. In caso di controversia sulla decisione del coordinatore (art. 5 co. 3 lett. b) non sono contemplati eventuali rimedi azionabili dalle parti. Non è chiaro quali poteri abbia il coordinatore per conseguire il rispetto delle decisioni da lui assunte. Né se sia revocabile l’incarico al coordinatore da parte di uno dei genitori, in quali casi e a che condizioni. Né infine quali siano i costi per l’attività prestata – verrà liquidata un’indennità, si applicheranno le tariffe professionali, e quali? – e sulla disciplina per gli aventi diritto al patrocinio a spese dello Stato.
- L’equilibrio fra le figure dei genitori
2.1. La condivisione dell’intento del d.d.l. di garantire la genitorialità
Il d.d.l. prende le mosse da un concetto di bigenitorialità, strettamente legato alla pariteticità ed equipollenza del tempo passato da ciascun genitore con i figli, per giungere a una serie di modifiche di quanto attualmente previsto dalla legge. La tesi di fondo è che l’affido condiviso non ha trovato pratica attuazione perché non sarebbe stato realizzato pienamente l’affido a tempi paritetici (relazione, p. 3). Di qui l’introduzione nel d.d.l. della doppia residenza o del doppio domicilio dei figli in caso di separazione, «non potendosi più identificare un genitore collocatario» – relazione p. 4 – «ma dovendosi prendere atto che il bambino potrà finalmente fare conto su “due case”».
L’intento – certamente lodevole – è di assicurare la presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli. È innegabile che per una crescita sana ed equilibrata un minore necessita di entrambi i genitori. Pienamente condivisibili sono le richieste di molti padri separati – di cui il d.d.l. in qualche modo si fa portavoce – di avere un ruolo di primo piano nella vita dei figli. I bambini, per crescere e riuscire ad instaurare relazioni interpersonali, hanno bisogno della cura e della presenza di entrambe le figure dei genitori: la madre è fondamentale nei primissimi anni di vita, ma il rapporto madre/figli rischia di generare squilibrio nella crescita del bambino se non è bilanciata dalla figura paterna. Padre e madre, aventi ruoli diversi e complementari, rappresentano quindi due figure egualmente importanti per consentire al bambino un sano sviluppo identitario.
Il principio della bigenitorialità, che è anche alla base dell’affidamento condiviso, muove esattamente da questo presupposto, per stimolare la partecipazione attiva di entrambi i genitori – siano essi ancora in coppia o separati – all’educazione, al mantenimento e all’istruzione dei figli in modo equilibrato e rispettoso delle parti coinvolte. Ambedue i genitori sono chiamati a svolgere pienamente il proprio ruolo, nella consapevolezza che il figlio ha bisogno di entrambi: come è affermato nell’art. 337 ter c.c., «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi». Questo significa che un genitore non può escludere l’altro dalla vita del figlio, a meno che non vi siano gravi e accertate ragioni (es. violenza). Altrettanto irresponsabile e inaccettabile è che un genitore lasci di fatto all’altro il ruolo di cura ed educazione, limitandosi a provvedere al mero mantenimento.
Va tuttavia osservato come la disciplina vigente contenga norme che permettono l’adeguamento alla complessità della realtà quotidiana. Per es., l’art. 337 ter, comma 4 e ss. stabilisce già che, in linea di principio, il mantenimento debba realizzarsi in forma diretta «in misura proporzionale al (…) reddito» di ciascuno dei genitori, ma pure che, in caso di necessità, e cioè laddove quest’esigenza di proporzionalità non possa realizzarsi, debba essere disposta la corresponsione di un assegno periodico da parte di un genitore all’altro.
2.2. Interesse del minore o dell’adulto?
Ciò premesso, il d.d.l. è connotato da eccessiva rigidità nel rapporto genitori/figli e dalla lettura della bigenitorialità in termini di una altrettanto rigida ripartizione dei giorni di permanenza dei figli con ciascun genitore. Malgrado nel d.d.l. si faccia più volte riferimento all’interesse dei figli, le norme sembrano muovere da un’altra prospettiva – l’interesse dei genitori –, e quindi da una impostazione adultocentrica, in contrasto con quanto previsto dalla normativa internazionale, dalla dottrina più autorevole e dalla giurisprudenza. A pagina 2 della relazione, dopo aver precisato l’intento di rimettere al centro la famiglia e i genitori, si legge che ciò avviene «restituendo in ogni occasione possibile ai genitori il diritto di decidere sul futuro dei figli».
La conferma di tale impostazione sta nel contenuto degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 e 22 del d.d.l. dai quali emerge una scarsa considerazione del minore e una scarsa conoscenza delle esigenze dei bambini. L’art. 7 del d.d.l. introduce l’obbligo di inserire nell’ambito della memoria difensiva ex art. 706 c.p.c., a pena di nullità, «una dettagliata proposta di piano genitoriale che illustri la situazione attuale del minore e le proposte formulate in ordine al suo mantenimento, alla sua istruzione, alla sua educazione e alla sua assistenza morale». Di piano genitoriale si parla poi anche negli articoli seguenti. Si tratta di un documento che in via sperimentale è utilizzato attualmente da qualche Tribunale, per es. Civitavecchia, ma che, alla stregua di quanto previsto da questo d.d.l., solleva perplessità.
Il piano deve essere innanzitutto dettagliato e redatto a cura dei genitori. Nulla si dice circa l’attenzione che i genitori dovrebbero avere nel fare scelte che tengano conto delle esigenze, delle inclinazioni e delle preferenze dei figli. La partecipazione – anche solo indiretta – dei minori alla stesura del piano genitoriale non è prevista, neppure per gli adolescenti. I minori sono soggetti in formazione: le loro esigenze e i loro bisogni cambiano rapidamente e non tollerano una previsione troppo rigida e dettagliata. Si consideri l’ulteriore automatismo che se un coniuge non ha presentato un proprio piano genitoriale, il Presidente del tribunale accoglierà quello dell’altro, ove non contrario all’interesse della prole. È vero che l’art. 13 conferisce ai genitori il diritto di chiedere la revisione dei piani genitoriali; ma, come precisa la stessa disposizione, qualora vi sia conflittualità tra le parti il giudice invita i genitori ad intraprendere un percorso di mediazione, con la riproposizione di tutte le problematiche di cui sopra.
Il dettagliato piano genitoriale più che rispondere alle esigenze del minore risponde alle esigenze organizzative dei genitori: il minore è di fatto oggetto del piano, senza forme di partecipazione, magari con l’ausilio di un esperto in grado di aiutarlo a dialogare con i genitori e renderli consapevoli dei suoi bisogni, delle sue paure, delle sue incertezze, per giungere a elaborare un piano rispettoso del bambino. Eppure in ambito internazionale l’ascolto del minore ha grande rilievo, perché punta a raccogliere informazioni nel contraddittorio su fatti rilevanti per la decisione, e perché individua le esigenze personali ed educative del minore. La menzionata Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989 sancisce all’art. 12 che gli Stati garantiscano ai minori il diritto di esprimere le proprie opinioni nell’ambito delle procedure che li riguardano. Sulla stessa linea si è espressa la Corte costituzionale italiana, nella sentenza n. 528 del 2000: «la mancata considerazione del minore, come parte del giudizio, inciderebbe negativamente sulla tutela dei suoi diritti ed in particolare di quello ad uno sviluppo compiuto ed armonico della personalità, implicitamente garantito dalle disposizioni costituzionali». In ogni caso, l’eccessiva minuzia di disciplina richiesta dal piano genitoriale mal si concilia con situazioni che, coinvolgendo e riguardando minori, sono in continua evoluzione e richiedono flessibilità più che formalizzazione in accordi dettagliati (si pensi alle frequentazioni amicali o ai luoghi di riunione dei minori).
La previsione della nullità del ricorso e della memoria difensiva, come sanzione per il mancato piano genitoriale dettagliato, potrebbe porre dei problemi rispetto al principio processuale della tassatività delle ipotesi di nullità degli atti processuali. Ci sono casi in cui, per la problematicità delle situazioni, si rende necessario disporre una consulenza tecnica di ufficio per verificare l’idoneità a svolgere le funzioni genitoriali e le condizioni di affido e collocamento, sin dall’udienza presidenziale, così da rendere superfluo, se non addirittura controproducente, il piano genitoriale. Il d.d.l. non spiega che cosa può accadere in casi simili.
2.3. La ripartizione dei tempi
L’art. 11 collega la bigenitorialità a una mera ripartizione paritetica del tempo che il figlio è chiamato a trascorrere con ciascun genitore: «salvo diverso accordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore». Secondo questa disposizione sarebbe nell’interesse del minore trascorrere qualche settimana nell’abitazione del padre e un numero di settimane tendenzialmente analogo nell’abitazione della madre. L’interesse del minore sarebbe inoltre di contare «su due case» (relazione, p. 4). È difficile credere che per un bambino sia positivo cambiare casa ogni metà mese: una simile ipotesi è già stressante per un adulto, tant’ è vero che gli esperimenti di permanenza a rotazione dei genitori nella casa familiare sono per lo più falliti.
La difesa della figura paterna e la sua importanza fondamentale nella vita di un figlio e nella formazione della personalità non può essere affermata sacrificando la serenità e la tranquillità dei bambini. La suddivisione in tempi paritari tra i genitori comporta per loro l’avere due case, in una sorta di perenne condizione di pendolarismo. La divisione in tempi paritari dovrebbe rimanere misura eccezionale: fraziona il minore, costretto in continuazione a cambiare il proprio modo di essere e il proprio comportamento, in base alle richieste e consuetudini del genitore con cui si trova. E poi, come si realizza la divisione in tempi paritetici per un neonato? Un bimbo di età inferiore ai tre anni, allorché l’attaccamento alla madre è fortissimo, dovrebbe vedersi allontanato da lei per tempi di cui non è in grado di sopportare le conseguenze? Il d.d.l. non opera alcuna distinzione in relazione all’età.
Un soggetto in formazione quale è il minore esige una stabile organizzazione di vita, soprattutto nei casi di separazione dei genitori. Non è nell’interesse del minore vivere da pendolare spostandosi da una casa all’altra, per soddisfare la convinzione di chi ritiene che soltanto in questo modo possa veramente parlarsi di affidamento condiviso. Persino quando la dottrina e la giurisprudenza si sono trovate ad affrontare casi di affidamento degli animali domestici in caso di separazione coniugale, l’ipotesi del collocamento a settimane alterne è stata in genere rifiutata, in quanto ritenuta non rispettosa delle esigenze e delle abitudini dell’animale. Se tali attenzioni valgono per un cane o per un gatto, perché a maggior ragione non dovrebbero valere per un bambino? Poiché la proposta di divisione in tempi paritetici si inserisce in un progetto di riformulazione della normativa anche in tema di mantenimento, ciò comporta che il minore abbia poi due diversi guardaroba (uno da ciascun genitore), o uno solo da traslocare periodicamente, unitamente ai libri scolastici e a quanto necessario per le attività extrascolastiche: una vita faticosissima, che accentuerebbe il trauma della separazione.
La pariteticità, nell’ottica della bigenitorialità correttamente intesa, deve riguardare anzitutto la responsabilità e l’impegno dei genitori nei confronti della cura integrale dei figli, e si traduce nella partecipazione di entrambi alla loro crescita, nelle diverse fasi dello sviluppo. Una partecipazione che richiede la continua messa in discussione da parte dei genitori, nello sforzo di cogliere davvero i bisogni dei figli, non già dare per scontato che quanto dagli stessi previsto per il loro – creduto – bene sia giusto. Una partecipazione che non può fare a meno del rispettoso dialogo fra i genitori, nel rispetto degli accordi stabiliti ma con elasticità e buon senso nell’applicazione concreta. Una partecipazione, insomma, che non può essere cristallizzata in una rigida pre-determinazione, in aride pagine di un piano che, proprio perché dettagliato, dovrà essere presto oggetto di ridefinizione e di modifica.
Al di là dell’idea singolare del “doppio domicilio dei minori” – di cui si è detto finora –, va segnalata la disposizione secondo cui il genitore che continui a risiedere nella casa familiare «è (…) tenuto a versare al proprietario dell’immobile un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato». Una regolamentazione così rigorosa rischia di contraddire la funzione stessa riconosciuta al provvedimento di assegnazione della casa familiare. L’idea che sta dietro la possibilità dell’assegnazione della casa familiare è che il soddisfacimento di un’esigenza dei figli – e forse anche solo del coniuge più debole – comporti un sacrificio a carico dell’altro genitore proprietario dell’immobile. Ben più equilibrata è la disposizione vigente, che invece il d.d.l. punta a superare, e cioè la necessità di tenere conto dei vantaggi derivanti dal godimento della casa in sede di determinazione dell’assegno a favore del coniuge assegnatario che versi in difficoltà economica.
Restando sul tema della casa di abitazione, cosa vuol dire poi che «non può continuare a risiedere nella casa familiare il genitore che non ne sia proprietario o titolare di specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione»? Il provvedimento di assegnazione non ha senso proprio in ipotesi di questo tipo? Se l’assegnatario ha già un titolo di godimento della casa familiare a che serve il provvedimento di assegnazione?
Desta inoltre perplessità, sempre in ordine al rapporto genitori/figli, quanto previsto dall’ultima parte dell’art. 14, laddove, nel trattare l’ipotesi del «trasferimento del minore non autorizzato in via preventiva da entrambi i genitori o dal giudice», si considera ciò sempre e comunque contrario al superiore interesse del minore e privo di ogni efficacia giuridica. Non solo, si stabilisce altresì che «è compito delle autorità di pubblica sicurezza, su segnalazione di uno dei genitori, adoperarsi per ricondurre immediatamente il minore alla sua residenza qualora sia stato allontanato senza il consenso di entrambi i genitori o l’ordine del giudice». La norma non considera che un minore possa essere allontanato, proprio nel suo interesse, per ragioni di sicurezza; la norma non prevede deroghe, ad es. per “giustificati motivi”, quali quelli relativi della violenza verbale o fisica di un genitore. Non è inoltre previsto alcun controllo o indagine da parte delle autorità di pubblica sicurezza, chiamate semplicemente ad «adoperarsi per ricondurre» – addirittura immediatamente – «il minore alla sua residenza». In tutto ciò, ancora una volta, non è contemplato l’ascolto del minore, che quindi potrebbe essere ricondotto con la forza in luogo per lui pericoloso.
2.4. L’intervento in giudizio dei nonni
Opinabile, con riferimento all’art. 11, è la previsione di un possibile intervento dei nonni nel giudizio: «gli ascendenti del minore possono intervenire nel giudizio di affidamento con le forme dell’art. 105 del c.p.c.». La presenza dei nonni è fondamentale nella vita dei bambini, oltre a essere spesso di grande aiuto per i genitori per organizzare e conciliare i diversi impegni lavorativi e familiari. Ma l’esperienza ed il buon senso suggeriscono di evitare nelle questioni familiari l’intromissione di soggetti che – seppur mossi magari dalle migliori intenzioni – non potrebbero far altro che alimentare ulteriormente il conflitto. Lo testimoniano, ad esempio, le numerose coppie finite in Tribunale proprio a causa dell’invadenza e dell’intromissione di suoceri e suocere.
Sembra incoerente che un disegno di legge che si pone l’ambizioso traguardo di diminuire la litigiosità nei procedimenti di famiglia consenta ad altri soggetti – non meno coinvolti e/o talora corresponsabili della conflittualità – di intervenire in giudizio, processualmente legittimati. I giudici ricorderanno con una punta di invidia Re Salomone, che in fondo fu chiamato a stabilire fra due sole contendenti quale avesse “diritto” al bambino. Di questo invero si tratta: adulti che rivendicano un preteso “diritto” in nome “dell’amore” verso un minore. Se si fosse voluto considerare almeno in termini equivalenti un corrispondente diritto del minore, si sarebbe dovuta prevedere la possibilità di un intervento del curatore speciale, cioè del soggetto che è chiamato a tutelare la posizione del figlio nei procedimenti in cui si discute di suoi diritti e vi è un potenziale conflitto con le posizioni dei genitori (cui questo d.d.l. aggiunge le posizioni dei nonni). Se l’articolo 11 afferma il diritto del minore «di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale», e questa non è una mera petizione di principio, il minore deve godere quanto meno della stessa possibilità di far valere tale diritto in giudizio, come la hanno gli ascendenti.
Se questo d.d.l. non fosse attraversato da una visione adulto-centrica, sarebbe sufficiente il vigente art. 317 bis[3], che riconosce agli ascendenti la possibilità “nell’interesse del minore” di ricorrere, instaurando un procedimento di volontaria giurisdizione, ex art. 336 c.c. Sotto il profilo processuale, la possibilità di intervenire in giudizio di separazione o divorzio ex art 105 c.p.c.[4] pone certamente il problema di identificare quale sia il diritto in senso stretto azionabile da parte degli ascendenti, «oggettivamente connesso con quello che costituisce oggetto del processo già pendente»[5]. Chiarire quale sia il contenuto e il fondamento del diritto degli ascendenti farebbe comprendere – posto che la norma afferma il diritto del minore a conservare rapporti significativi “con i parenti di ciascun ramo genitoriale”, pur non contemplando alcuna azione per la tutela di tale diritto – per quale ragione non sia stata prevista la possibilità di intervenire ex art. 105 c.p.c. anche per gli altri parenti appartenenti a ciascun ramo genitoriale: perché la nonna con la quale in concreto il minore non ha avuto relazioni continuative, e non invece la zia, con la quale è intercorso un rapporto più stretto?
Un altro aspetto da chiarire allorché si ammette la possibilità di partecipare al contenzioso anche agli ascendenti è se anche loro debbano, a pena di improcedibilità, proporre domanda di mediazione. La logica e l’analogia per quanto avviene per altri tipi di procedimento, e per quanto previsto per la domanda dei coniugi, porterebbe ad una risposta positiva, ma di improcedibilità il testo dell’articolo qui non fa menzione.
- Il mantenimento dei figli in forma diretta
Il d.d.l. introduce novità sul mantenimento dei figli, enfatizzando la forma diretta quale migliore, in quanto contribuirebbe – come si legge a p. 3 della relazione – «a una percezione nel minore di maggiore benessere economico non dovendo più il genitore veder mediato il proprio contributo da una persona – l’ex partner – in cui a torto o ragione non ha fiducia». Non si comprende per quale motivo il minore dovrebbe avere una percezione di maggior benessere economico in caso di mantenimento diretto: se mai in caso di genitori con differenti capacità reddituali egli percepirebbe la netta differenza fra i due genitori. Lascia più perplessi che questa disposizione non tenga conto di quel che accade nella realtà.
Astrattamente parlando, il mantenimento diretto di per sé non sarebbe una forma criticabile: è già previsto dall’attuale normativa. Tuttavia, un’analisi della realtà sociale italiana fa pervenire ad altre conclusioni, come anche osservato dal Consiglio Nazionale Forense nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” (29 novembre 2017): «non può sottacersi che questo modello familiare, fondato sull’effettiva eguaglianza economico-sociale, giuridica e culturale dei due genitori sembra faticare ad affermarsi nella nostra società, dove invece i ruoli genitoriali tradizionali, che assegnano alla madre la prevalenza dei compiti di cura ed accudimento, sono ancora molto marcati. L’assegno periodico di mantenimento, pertanto, trova la sua necessità nel diverso tempo di cura dedicato da ciascun genitore ai figli e in attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza e solidarietà familiare disciplinati dall’art. 316 bis c.c.».
La rigida previsione del d.d.l. manca dell’idea di solidarietà fra i genitori, nell’interesse dei figli. L’art. 11 sul mantenimento diretto non considera le disuguaglianze ancora presenti, specie in ambito lavorativo, fra uomini e donne, e contraddice l’obiettivo dichiarato di porre la famiglia al centro e di garantire l’eguaglianza fra i genitori. Si pone piuttosto come ostacolo all’instaurazione di un dialogo fra i genitori, in quanto tende a accentuare le disuguaglianze, e con esse i conflitti.
La corresponsione a carico di un genitore di un assegno periodico potrà essere prevista solo “ove strettamente necessario e in via residuale”, ma dovranno essere indicate le modalità e le iniziative cui le parti dovranno attenersi, «per giungere al mantenimento diretto della prole» (art. 11 comma 8). Questa forma di assistenza economica in favore del minore, alternativa all’assegno di mantenimento, prevede che il genitore provveda personalmente alle spese ordinarie del figlio durante il periodo che trascorre con lui. La relazione al d.d.l. fa riferimento «all’antiquata idea dell’assegno» (p. 2, 1° cpv.), vigente in Italia, che intende eliminare, proponendo invece la suddivisione per capitoli di spesa tra i genitori, in relazione alle abitudini e al tenore di vita. Il limite di tale opzione è che, ove anche si riuscisse nella complessa opera di individuare le spese necessarie per un figlio in un futuro più o meno prossimo, ciò accentuerebbe agli occhi del figlio le diverse potenzialità economiche dei genitori, a scapito di quello economicamente più debole. L’assegno offre una possibilità perequativa, per cui se il figlio frequenta una certa scuola o può mantenere un determinato tenore di vita, ciò dipende, per lui, dall’intervento di entrambi i genitori. Infine, e non trascurabile, è da segnalare il probabile aumento di contenzioso che deriverà dall’applicazione del mantenimento per capitoli di spesa, laddove un genitore faccia scelte per gli acquisti non condivisi per natura, qualità o quantità, dall’altro genitore.
- La “alienazione genitoriale”
L’art. 17 del d.d.l. prevede che il giudice adotti provvedimenti qualora durante o dopo la separazione la condotta di uno dei genitori costituisca «causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale». La condotta cui fa riferimento l’articolo in esame è quella comunemente chiamata alienazione parentale o genitoriale, come peraltro precisa la relazione a p. 4: «è grazie al godimento del diritto ad avere relazioni con i propri familiari che le persone possono, nel contempo, esercitare i doveri legati al “fare famiglia”».
È indiscutibile per il minore mantenere una relazione stabile e continuativa con tutti i familiari. Tuttavia l’esperienza insegna che vi sono dei casi in cui questo non è possibile, come ad es. quando uno dei genitori ha atteggiamenti tali da esigere una limitazione delle frequentazioni genitore/figlio. Altrettanto indiscutibile è che ogni genitore dovrebbe, nell’interesse dei minori, evitare condotte tali da sminuire l’immagine dell’altro genitore, in particolare agli occhi del figlio. Tuttavia, l’alienazione genitoriale – quella che fino al 2012, prima di una pronuncia sull’argomento da parte del Ministero della Salute, veniva chiamata PAS/sindrome di alienazione parentale – è un concetto che si è cercato di introdurre nelle aule di Tribunale per costringere un minore ad accettare la relazione col genitore “rifiutato”: un concetto elaborato negli USA a partire dal 1985, che ha suscitato critiche e perplessità – lo riconosce la relazione a p.4 –, non avendo fondamento scientifico. Il Ministro della salute italiano, a seguito dell’interpellanza parlamentare n. 2-01706 del 16 dicembre 2012 n. 704, ha affermato che: «sebbene la PAS sia stata denominata arbitrariamente dai suoi proponenti con il termine “disturbo”, in linea con la comunità scientifica internazionale, l’Istituto Superiore di Sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica tali da poter essere considerate una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici».
Nel d.d.l., nonostante la consapevolezza delle critiche sollevate, si è nondimeno attribuita importanza a tale voce, non tenendo però conto del fatto che se un bambino rifiuta la relazione con un genitore non necessariamente lo fa perché è stato manipolato dall’altro genitore. Nel 2013 la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7041 del 2013, I sez. Civile ha affrontato un caso in cui il giudice di merito si era basato su una consulenza che aderiva a tale teoria. Così ha sancito il Giudice di legittimità: «sono state richiamate le perplessità del mondo accademico internazionale, al punto che il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) non la riconosce come sindrome o malattia; che si è evidenziato che vari autori spagnoli, all’esito di una ricerca compiuta nel 2008, hanno sottolineato la mancanza di rigore scientifico del concetto di PAS e che, nel 2009, le psicologhe B.C. e V.S., la prima spagnola e la seconda argentina, hanno sostenuto, in una pubblicazione del 2009, che la PAS sarebbe un “costrutto pseudo scientifico”. Nell’anno 2010, inoltre, la Asociacion Espanola de Neuropsiquiatria ha posto in evidenza i rischi dell’applicazione, in ambito forense, della PAS, non diversamente da quanto già manifestato nel 2003, in USA, dalla National District Attorneys Association, che in nota informativa sosteneva l’assenza di fondamento della teoria, “in grado di minacciare l’integrità del sistema penale e la sicurezza dei bambini vittime di abusi”. Sono stati altresì richiamati i rilievi in base ai quali, anche volendo accedere alla validità scientifica della PAS, molti dei suoi caratteri, come definiti dal suo sostenitore principale, Richard Gardner (nei cui confronti non sono mancati accenni poco lusinghieri, quale l’essersi presentato quale Professore di psichiatria infantile presso la Columbia University, essendo un mero “volontario non retribuito”, e persino l’aver giustificato la pedofilia), non sarebbero riscontrabili nel caso di specie. (…) L’altro principio, parimenti disatteso e non meno importante, riguarda la necessità che il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass. 14759 del 2007; Cass., 18 novembre 1997, n. 11440), ovvero avvalendosi di idonei esperti, verifichi il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale (Cass. 3 febbraio 2012, n. 1652; Cass. 25 agosto 2005, n. 17324). Il rilevo secondo cui in materia psicologica, anche a causa della variabilità dei casi e della natura induttiva delle ipotesi diagnostiche, il processo di validazione delle teorie, in senso popperiano, può non risultare agevole, non deve indurre a una rassegnata rinuncia, potendosi ben ricorrere alla comparazione statistica dei casi clinici. Di certo non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare».
La Cassazione richiama alla prudenza, e prudenza dovrebbe seguire pure il legislatore. In una materia così delicata che coinvolge i minori, una norma, che abbia come presupposto una teoria come quella menzionata, rischia di ledere la dignità della persona. Accreditati studi scientifici frutto di ricerche di psicobiologia nel campo delle neuroscienze affettive insegnano che quando un bambino si sente a disagio con un genitore ed evita la frequentazione con lo stesso, nella quasi totalità dei casi lo fa perché ha paura e la paura – un’emozione primaria, istintiva, non condizionata – è in genere provocata dal comportamento violento (fisico o anche solo verbale) del genitore rifiutato, se non addirittura da abusi sessuali o atteggiamenti che mettono il minore a disagio.
Il d.d.l. in esame, come detto, sembra non considerare tutto ciò, prevedendo addirittura che i provvedimenti di cui agli articoli 342 ter e 342 quater del codice civile «possono essere applicati, nell’esclusivo interesse del minore, anche quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraneazione con riguardo a uno di essi». A parte il fatto che il richiamo all’interesse del minore, per il contesto normativo in cui è collocato, risulta essere un inciso privo di significato, non può non esser criticata questa disposizione nella misura in cui prevede la possibilità – per il solo rifiuto del minore verso uno dei genitori – di applicare provvedimenti sanzionatori all’altro genitore «pur in assenza di evidenti condotte»: è una presunzione ex lege di alienazione genitoriale, che ipotizza un’estensione della disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari pur quando abusi non vi siano stati. Nulla si dice in merito all’importanza di ascoltare il minore e di comprendere, con l’ausilio di esperti qualificati, le ragioni del suo disagio o del suo rifiuto. Malgrado il richiamo all’interesse del minore, l’ascolto del bambino non è previsto, contrariamente a quanto sancito dalle convenzioni internazionali e dalla giurisprudenza costituzionale. Come in altri passaggi, anche su questo versante il d.d.l. non tiene conto di previsioni già contenute nell’ordinamento in vigore: per es., nel caso di condotta del genitore pregiudizievole ai figli, che però non sia tale da dar luogo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, esiste già la previsione dell’art. 333 c.c., che offre uno strumento di tutela sufficientemente duttile.
- Varie, in conclusione
5.1. Eliminato l’ammonimento
L’art. 9 del d.d.l. modifica l’art 709 ter c.p.c. che titola “soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni”, ricomprendendo in tali fattispecie eventuali inadempienze o “manipolazioni psichiche” oltre agli atti che arrechino pregiudizio al minore. Viene eliminata la previsione dell’ammonimento e si stabiliscono solo le già esistenti ipotesi risarcitorie, anche se gli importi della sanzione pecuniaria vengono fortemente elevati: ciò non è condivisibile perché la sanzione dell’ammonimento è l’unica che, non prevedendo richieste risarcitorie o di natura economica, non può dar adito a facili accuse di possibili strumentalizzazioni a fini di lucro.
5.2. Ridotti i termini processuali
La riduzione dei termini di fissazione dell’udienza presidenziale, da 90 a 40 giorni dalla data di deposito del ricorso, potrebbe creare problemi nella predisposizione delle difese del convenuto. Se è vero che l’udienza presidenziale ha carattere sommario e i provvedimenti adottati sono provvisori, quindi modificabili in corso di causa, è altrettanto vero che quante più informazioni documentate vengono proposte e vagliate dal Presidente facente funzioni, tanto più la decisione, benché provvisoria, sarà adeguata alle circostanze di fatto, e spesso condurrà le parti a una definizione consensuale del procedimento. Ma se il resistente, per i termini troppo brevi, non sarà in grado di procurare la documentazione a propria difesa, quanto meno quella più importante (ad es. estratti conto bancari), questo compromette la possibilità che il Presidente assuma i provvedimenti provvisori avendo un quadro sufficientemente adeguato della situazione. Il che comporterà la necessità di prolungare il procedimento per consentire un’istruttoria più completa o il ricorso agli strumenti di impugnazione, con incremento di attività processuale.
5.3. Le disposizioni sui figli maggiorenni
L’art. 15 del d.d.l. modifica l’art 337 septies c.c. che prevede disposizioni in favore dei figli maggiorenni, e introduce la consegna al figlio dell’assegno di mantenimento da parte dei genitori, anche ove egli abiti stabilmente con uno di loro. La corresponsione diretta al figlio maggiorenne oggi viene statuita con prudenza, per evitare contenziosi familiari che facilmente potrebbero insorgere se il ragazzo utilizzasse il denaro per sé, senza partecipare alle spese del proprio mantenimento. Il rischio è di aprire un nuovo fronte di contenzioso familiare, che coinvolga anche i figli. Neppure appare condivisibile la previsione che l’obbligo di mantenimento cessi tout court con il compimento del 25° anno di età. Il percorso scolastico spesso prevede tempi più lunghi; perché il genitore non dovrebbe sostenerlo, cosa che farebbe nel caso di famiglia unita? Perché porre in una situazione di vantaggio il genitore separato e, soprattutto, in una condizione di sfavore il figlio di coppia separata? Una norma del genere si manifesta in modo palese come irragionevole, e quindi incostituzionale.
5.4. L’eliminazione dell’addebito e della sanzioni contro la violazione degli obblighi
L’art. 19 del d.d.l. abroga l’art. 151, co 2 c.c., in base al quale «Il giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio». L’art. 21 abroga l’art. 570 bis c.p. Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio: «Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli». Con questo sono lasciati privi di tutela gli obblighi di cui agli articoli 143, 147 e 148 c.c.[6], sia sul piano civile che su quello penale, svuotandoli conseguentemente di significato: non sono obblighi di carattere morale, ma hanno uno specifico contenuto giuridico.
Un ordinamento che non preveda la possibilità di esecuzione specifica di un obbligo di legge e/o di sanzione in caso di violazione dello stesso, è un ordinamento che viene meno al suo scopo. In virtù di tali abrogazioni, gli impegni assunti con il matrimonio e la famiglia stessa avrebbero minore tutela – se non addirittura inesistente – rispetto a quella prevista per un contratto di leasing o di mutuo. Con il venir meno dell’addebito, infatti, il coniuge che ha avuto un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio non solo non sarebbe condannato alle spese, ma non perderebbe neppure i diritti successori. Si tratta in definitiva di un’altra disposizione in grado di alimentare il conflitto e le tensioni fra persone che hanno deciso di separarsi.
Roma, 30 ottobre 2018
[1] Il documento è stato redatto dalle avv. Daniela Bianchini, Margherita Prandi Borgoni ed Eva Sala, tutte con consolidata esperienza professionale nel diritto di famiglia, col coordinamento del dott. Alfredo Mantovano, vicepresidente del Centro Studi Livatino e con la supervisione del prof. Emanuele Bilotti, professore Ordinario di Diritto privato e Coordinatore del Corso di laurea in Giurisprudenza nell’Università Europea di Roma. È l’esito della condivisione del Consiglio di segreteria del CSL.
[2] «Il Presidente fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso».
[3] Ai sensi dell’art. 317 bis c.c.: «Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma».
[4] Ai sensi dell’art. 105 c.p.c.: «Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le altre parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse».
[5] Cfr. C. Mandrioli, Diritto Processuale Civile, vol. I § 55.
[6] c.c. art. 143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri [Cost. 29, 30].
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
c.c. art. 147. Doveri verso i figli.
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis. [Cost. 30] .
c.c. art. 148. Concorso negli oneri.
I coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316-bis.