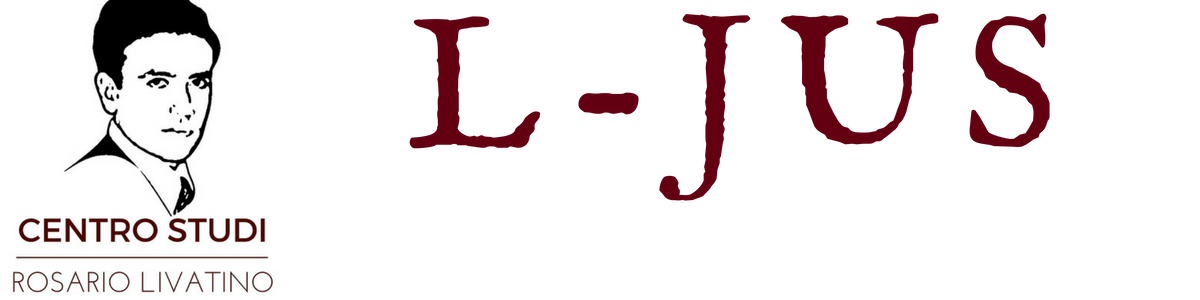Gabriele Civello
Avvocato e Abilitato Professore Associato di Diritto penale
Università degli Studi di Padova
Sommario: 1. Considerazioni introduttive ‒ 2. Le cause semiotico-linguistiche del politicamente corretto ‒ 3. Il rapporto tra parola e realtà in Platone ‒ 4. Il rapporto tra parola e realtà in Aristotele ‒ 5. Il rapporto tra parola e realtà in Sant’Agostino ‒ 6. Il pensiero contemporaneo ‒ 7. Considerazioni conclusive ‒ 8. Una piccola proposta di pars construens.
- Considerazioni introduttive
Nel saggio Politics and the English Language[1] del 1946, George Orwell (1903-1950) sostiene che il decadimento del linguaggio sia diretta conseguenza del declino politico, economico e culturale della nostra civiltà; a tal riguardo, il pamphlet riporta alcuni esempi linguistici, dimostrando come l’idioma inglese sia andato incontro a gravi fenomeni di usura o di ipertrofia quali l’utilizzo superfluo di parole esotiche, la ridondanza di sinonimi e, ancor più, la trasformazione di concetti chiarissimi – ma politicamente “scomodi” – in corrispondenti perifrasi eufemistiche apparentemente più garbate ed eleganti, ma in verità equivoche e ricche di ipocrisia. In tale breve ma densa analisi è racchiusa, secondo i più, una geniale profezia del “politicamente corretto”[2], il quale si sarebbe fatto strada progressivamente all’interno della civiltà cosiddetta occidentale, sino a divenire oggi, dopo oltre settant’anni dalla morte di Orwell, un fenomeno globale apparentemente inarrestabile.
Il politically correct è, a grandi linee, una prassi sociale – una nuova forma di conformismo, da taluni definito persino come una sorta di religione politica[3] – nata soprattutto negli Stati Uniti d’America e, più in generale, nei paesi anglosassoni oltre che scandinavi, la quale comporta la modificazione o la sostituzione di espressioni linguistiche preesistenti con corrispondenti nuove locuzioni o perifrasi; ciò al dichiarato fine di evitare che i preesistenti “modi di dire” possano ferire o persino intimidire determinate classi di soggetti, individuati per il sesso o l’orientamento sessuale, lo status di salute fisica o mentale, l’opinione religiosa o filosofica, la provenienza etnica o geografica, l’appartenenza sociale, economica, sindacale o politica, e così via. Celeberrimi, ad esempio, i casi di sostituzione della parola invalido con disabile e, poi, diversamente abile; cieco con non vedente; nero con persona di colore oppure afroamericano; spazzìno con operatore ecologico; bidello con operatore scolastico, eccetera. Oppure ancora, lasciando solo per un momento l’ambito strettamente linguistico, la rimozione del presepe dalle scuole per non offendere chi non crede in Gesù, l’eliminazione della carne di maiale dalle mense scolastiche o universitarie per non urtare i musulmani, e molti altri casi esemplificativi.
In definitiva, il politicamente corretto sottende il tentativo di edulcorare il linguaggio verbale o non verbale, soprattutto depurandolo da una serie cospicua di curvature assiologiche, nella convinzione che queste ultime potrebbero ferire la sensibilità o l’autostima di taluni; per questa ragione, il citato fenomeno comporta l’adozione eufemistica di espressioni linguistiche o di comportamenti deliberatamente più neutri, anodini, “freddi” e assiologicamente indifferenti (almeno in apparenza), onde scongiurare il predetto effetto potenzialmente offensivo.
- Le cause semiotico-linguistiche del politicamente corretto
Negli ultimi anni, gli studi filosofici, politologici e sociologici sul “politicamente corretto” hanno proliferato in numerosi paesi anglosassoni ed europei, giungendo a individuare l’origine e le cause di tale fenomeno.
Un possibile fattore genetico del politically correct potrebbe essere una sorta di “mutazione” alla quale è andato incontro il pensiero progressista degli ultimi decenni: se, fino agli anni ’50/’60, l’attenzione delle sinistre marxiste era pressoché tutta rivolta alle questioni socio-economiche come il superamento dell’eccessiva sperequazione fra le differenti classi sociali, l’accesso di tutti i cittadini, anche i meno abbienti, ai diritti fondamentali quali la salute, il lavoro, la casa, l’istruzione e così via, dagli anni ’60 ad oggi – e ancor più dopo la caduta del “blocco Sovietico” – l’attenzione dei progressisti si è bruscamente traslata dai temi socio-economici a quelli di natura ideologico-intellettuale come, soprattutto, l’iper-ambientalismo, l’iper-animalismo, le battaglie del gender, LGBT, e così via. Questo è il primo humus nel quale sono nate e si sono sviluppate le maggiori forme di politicamente corretto, fondate sulla cura, spesso maniacale e martellante, nei confronti dei modi di espressione del pensiero, soprattutto nelle sedi pubbliche e istituzionali, piuttosto che del merito delle idee espresse.
Ma un’altra importante causa genetica del politically correct sembra essere una inedita sopraffazione dei contenuti da parte della forma, e dei significati da parte dei significanti[4]: se la tradizione classica di matrice platonico-aristotelica insegnava che le parole non sono puri flatus vocis, ma rappresentano una forma di segno ancillare rispetto agli “enti reali”, la modernità e soprattutto la c.d. “postmodernità” sono epoche nelle quali tale equilibrio ultrabimillenario si è sfaldato rapidamente.
A tal proposito, la strenua battaglia dell’uomo di oggi contro il realismo filosofico sta comportando un effetto collaterale davvero dirompente: il verbo, la parola, il logos, non sono più puri strumenti e mezzi per un fine che li trascenda, vale a dire la significazione di una realtà che è, sì, indicata dalla parola ma non è la parola stessa, non si identifica col segno; al giorno d’oggi, la parola come “segno” tende sempre più ad assumere una sorta di statuto ontologico autonomo, come se il significante stesso potesse fare a meno della realtà oggettiva significata. Si tratta di un fenomeno semiotico che è stato icasticamente denominato “significante alla deriva”[5] e che sottende «l’idea che non esistano proprietà autonome della realtà che non siano riducibili al linguaggio»[6], idea che oggi viene chiamata “svolta linguistica” ma che affonda le proprie radici nel nominalismo medievale e, ancor prima, nella concezione sofistica della parola umana.
- Il rapporto tra parola e realtà in Platone
Sin dai dialoghi di Platone, la filosofia occidentale manifestò una profonda fiducia circa la capacità del logos di farsi effettivo e reale strumento di conoscenza[7], come dimostra l’adozione stessa del metodo dialogico da parte di Socrate e del suo geniale allievo; lo stesso pensiero, si afferma nel Teeteto[8] e nel Sofista[9], non è altro che un silenzioso colloquio “a parole” dell’anima con se stessa, la quale assomiglia così ad un vero e proprio libro[10].
Nel Cratilo, Platone pose già numerose questioni che sarebbero poi state oggetto della scienza semiotica e linguistica contemporanea: a fronte della tesi sofistica espressa da Ermogene, secondo cui i nomi sarebbero frutto del puro accordo e della convenzione sociale[11], Cratilo (allievo di Eraclito) dimostra che i nomi hanno necessariamente un qualche legame naturale – forte o flebile che sia – con le cose da essi significate e rappresentate[12], e in particolare con il loro eidos, la forma, essenza e idea universale cui i singoli enti individuali partecipano.
Si pone, dunque, già in Platone il problema dei rapporti tra significante e significato, tra segno e cose del mondo, tra physis e nomos della parola, in una prospettiva squisitamente realistica, avente cioè a proprio fulcro la res oggettiva, e non già un “io” puramente soggettivo: «altro è il nome, altro è invece ciò di cui esso è nome», afferma Socrate affrontando problematicamente sia la tesi di Ermogene sia quella di Cratilo (430a), non senza precisare di lì a breve che il modo migliore per conoscere le cose è quello diretto, che pone al centro della episteme la res di cui il “nome” è solo una immagine linguistica («le cose devono essere imparate e ricercate non a partire dai nomi, bensì a partire da se stesse molto più che dai nomi»: 439b).
Posto, tuttavia, che gli enti reali, individuali e concreti, sono soggetti al fenomeno del continuo mutamento-movimento, i nomi rappresentano pur sempre un importante ausilio alla conoscenza, poiché concorrono a rispecchiare la stabilità dell’universale che giace all’interno di ogni ente mondano individuale; ciò, nella consapevolezza che il medesimo nome può indicare più cose, e che la medesima cosa può avere più nomi, così che tra le due entità non sempre si dà una relazione biunivoca e rigida[13]. Il discorso «che dice gli enti come sono è vero, mentre quello che li dice come non sono è falso» (385b): non esiste, dunque, per Socrate e per Platone espressione linguistica vera in sé e per sé, poiché il criterio di verità o di falsità di ogni discorso consiste nella conformità o difformità del medesimo rispetto agli enti del mondo in esso significati e rappresentati, per il tramite della entità universale chiamata “idea”[14].
- Il rapporto tra parola e realtà in Aristotele
Il De interpretatione (Περὶ Ἑρμηνείας) di Aristotele è un altro importante snodo nello sviluppo di una teoria linguistica di matrice realistica.
L’incipit dell’opera è particolarmente eloquente e perentorio: «I suoni sono i simboli delle affezioni dell’anima e i segni scritti sono i simboli dei suoni»; a loro volta, le “affezioni dell’anima”, cioè i pensieri o rappresentazioni mentali, si riferiscono alle realtà (pràgmata) di cui sono immagini[15].
Come hanno meglio chiarito gli esegeti[16], lo Stagirita individua dunque quattro piani teorici oggetto di analisi semiotica: le cose reali (pràgmata); le immagini che di esse l’uomo si fa nel pensiero sotto forma di “affezioni” (patémata), immagini (omoiomata) o pensiero stesso (noema)[17]; i suoni (phonai) che sono lo specchio dei pensieri, cioè le parole dette o parlate; infine le parole scritte (graphòmena), segno grafico delle parole “sonore”.
Per Aristotele, le sostanze prime sono gli enti individuali o cose reali[18]; via via che ci si allontana da esse, giungendo ai pensieri, alle parole fonetiche e alle parole grafiche, ci si allontana progressivamente dalla realtà oggettiva e naturale, per approdare al piano logico-linguistico, decisamente ancillare rispetto alla prima.
Anche per Aristotele, poi, come per Platone, «il falso e il vero hanno a che fare con la connessione e la divisione»[19]: se il discorso congiunge cose che nella realtà sono congiunte, o separa cose che nella realtà sono effettivamente separate, allora esso è vero; se, invece, esso congiunge ciò che è realmente disgiunto, o disgiunge ciò che è realmente congiunto, allora esso diviene falso.
- Il rapporto tra parola e realtà in Sant’Agostino
Un altro capolavoro del pensiero semiotico di matrice classica è il De magistro di Sant’Agostino[20], dialogo che secondo i più sarebbe, dopo gli scritti platonico-aristotelici e la parentesi stoica, la più importante fucina nella quale si sarebbe poi plasmata la moderna filosofia del linguaggio.
Colpisce davvero che il santo Autore abbia deciso di trattare il tema del segno linguistico all’interno di un’opera apparentemente focalizzata su tutt’altre questioni teoriche, vale a dire l’educazione e la didattica; ma la perplessità è presto fugata dallo stesso Agostino: ogniqualvolta noi facciamo ricorso alla parola orale e scritta, in certo modo, noi stiamo insegnando al nostro interlocutore un determinato concetto o anche solo le nostre idee o volontà («Noi parliamo al fine di insegnare o rammentare»: § 19). Anche quando noi semplicemente entriamo in un negozio e diciamo che oggi “è una bella giornata di sole”, facciamo ciò per “insegnare”, cioè per rendere edotto il nostro interlocutore che potrà uscire senza ombrello, oppure che noi stessi siamo di buon umore, e così via: ogni parola è, dunque, una forma di “insegnamento”, cioè di trasmissione di pensieri, concetti o realtà a taluno che ancora non li conosca o, quantomeno, non li abbia chiari e presenti.
Alla domanda «il segno può essere segno, se non significhi qualcosa?», il dialogo dà risposta fermamente negativa («non potest»: § 3), ribadendo di lì a breve la catena semiotica già scoperta ed esaminata da Platone e Aristotele: «La parola è segno del nome, e il nome è segno del fiume, e il fiume è segno di una cosa che può vedersi» (§ 9). In questo modo, «il linguaggio porge due volti: per l’uno è proteso all’Essere; per l’altro è rivolto agli uomini. Si può quindi compendiare questa parte del dialogo con la sequenza di idee: vivere nel principio della vita beata è vivere socialmente, nella comunicazione tra più soggetti; dunque è parlare; parlare è insegnare. […] Il problema agostiniano si può così formulare: è possibile per l’uomo immettersi nella via dell’Essere? O anche: può l’uomo comunicare parlando? Insegnare con la parola?»[21].
Le conclusioni di Sant’Agostino sono, come sempre, stringenti: da un lato, «noi non possiamo affatto dialogare, se l’intelletto, udite le parole, non si conduca alle cose di cui le parole sono segni» (§ 22); dall’altro, «le cose che vengono significate sono da tenere in considerazione più dei segni. […] La conoscenza in sé, che ci perviene per mezzo di questo segno, [è] da anteporre al segno stesso» (§ 25).
- Il pensiero contemporaneo
Il pensiero moderno e soprattutto quello contemporaneo, a ben vedere, disarticolano progressivamente il nesso ontologico tra segno linguistico e realtà oggettiva, tra significante e significato, portando a estremo compimento i pregiudizi ideologici dell’antica sofistica greca e del nominalismo medievale.
In particolare, la filosofia novecentesca è caratterizzata da quella che è stata definita la “svolta linguistica”[22]: per Martin Heidegger (1889-1976), il linguaggio è la casa dell’essere (come recita l’incipit della Lettera sull’«umanismo»), quando invece per oltre duemila anni si era pensato l’esatto contrario, vale a dire che l’essere è la casa del linguaggio, nel senso che ogni segno non è mai, assurdamente, “segno a se stesso”, ma è sempre segno di un previo ente, pieno di “essere”.
La concezione heideggeriana del linguaggio parte dal presupposto che «non è l’uomo a disporre del linguaggio, ma viceversa è il linguaggio che dispone dell’uomo»[23]: per tale ragione, l’espressione “filosofia del linguaggio” conterrebbe, per Heidegger, un genitivo non già oggettivo – nel senso di una disciplina umana che abbia ad oggetto quella realtà chiamata “linguaggio” – bensì soggettivo, «proprio nel medesimo senso in cui il pensiero dell’evento non è una riflessione sull’evento, bensì un’esperienza filosofante che matura e si attua a partire dall’evento. […] Il linguaggio è parte integrante dell’evento di appropriazione che si compie fra essere e uomo»[24].
In definitiva, come ben detto da Gianni Vattimo interprete di Heidegger, «la tesi […] che il linguaggio è “la casa dell’essere” è chiarita nel senso che “il linguaggio è la custodia della presenza [cioè dell’essere delle cose come darsi nella presenza], il modo di accedere dell’evento. […] Il linguaggio è essenzialmente qualcosa di cui disponiamo e che tuttavia, per un altro verso, dispone di noi; è consegnato a noi in quanto lo parliamo, ma si appropria di noi in quanto, con le sue strutture, delimita fin dall’inizio il campo della nostra possibile esperienza del mondo. Solo nel linguaggio le cose ci possono apparire, e solo nel modo in cui esso le lascia apparire. “È la parola che procura l’essere alla cosa”»[25].
Ciò, a ben vedere, rappresenta l’inevitabile corollario del “peccato originale” della filosofia moderna, sin dal pensiero filosofico di Cartesio – ma le radici di tale prospettiva sono ben più antiche –, vale a dire credere nel Cogito ergo sum, cioè nella priorità del pensiero rispetto all’essere, quando invece è vera e auto-evidente la proposizione esattamente contraria e speculare, cioè: Sum ergo cogito, sono, esisto, e quindi (solo in quanto io sono) posso anche pensare.
Per la c.d. “filosofia analitica”, nata nel mondo anglosassone ma oggi costituente il paradigma dominante del pensiero nominalistico contemporaneo, i più scottanti problemi filosofici non sarebbero altro che altrettanti quesiti di natura puramente linguistica[26]; e di converso, tutto ciò che non sia suscettibile di essere espresso attraverso proposizioni linguistiche non avrebbe alcuna dignità ontologica, tanto che la maggior parte dei concetti tradizionali del pensiero occidentale come “Dio”, “vero, “bene”, “bello”, “giusto”, non sarebbero che giuochi linguistici privi di contenuto reale, in quanto soggetti a dispute o contraddizioni ritenuti come insanabili (donde la celebre chiusa del Tractatus logico-philosophicus di Ludwig Wittgenstein (1889-1951), che si conclude con la ringhiosa proposizione: «Su ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere»: § 7).
Per la grammatologia di Jacques Derrida (1930-2004), il percorso del trascendentalismo kantiano e poi husserliano dovrebbe essere portato ad estreme conseguenze[27]: se il kantismo aveva sostituito la cosa in sé – presunta come inconoscibile – con gli schemi concettuali della conoscenza umana, Derrida intende smantellare gli stessi “concetti”, mostrando che la vera “sostanza prima” è la scrittura o, meglio, la traccia, il segno. Con Derrida, si passa così dal trascendentale kantiano al trascendentale semiotico, sostenendo addirittura che la vera realtà originaria non sarebbe nemmeno più la parola scritta (che per il pensatore francese sarebbe espressione di logo-centrismo, ego-centrismo ed etno-centrismo occidentale, cioè di violenza metafisica), bensì il puro gesto, il segno non costituito da lettere, la mera “traccia”, che diviene così il vero nuovo “trascendentale” della grammatologia contemporanea, al posto della tradizionale serie tomista “ens, res, aliquid, unum, verum, bonum”.
Per Derrida, in definitiva, la “catena” aristotelica che dalle cose giungeva ai concetti del pensiero, e da questi alle parole orali sino alla parola scritta, dovrebbe essere essenzialmente decostruita e ribaltata, riconoscendo al segno (gramma o grafema) un’autonoma dignità trascendentale rispetto alle parole e a fortiori rispetto alle cose “significate”[28].
«Bisogna pensare la traccia prima dell’ente»[29], afferma l’Autore della Grammatologia, quasi a dire – parafrasando Heidegger – che Il segno è la casa dell’essere.
A tal proposito, ne La voce e il fenomeno, Jacques Derrida illustra in modo particolarmente chiaro la sua idea circa i rapporti tra segno e realtà: «Domandando “che cosa è il segno in generale?”, si sottomette il problema del segno ad un’intenzione ontologica, si pretende di assegnare alla significazione un posto, fondamentale o regionale, in un’ontologia. Un procedimento siffatto sarebbe classico. Si sottometterebbe il segno alla verità, il linguaggio all’essere, la parola al pensiero e la scrittura alla parola. Dire che può esserci una verità del segno in generale, non è forse supporre che il segno non sia la possibilità della verità, non la costituisca, ma si contenti di significarla, di riprodurla, di incarnarla, di iscriverla in modo derivato o di rinviare ad essa? Poiché, se il segno precedesse in qualche modo ciò che si chiama la verità o l’essenza, non avrebbe alcun senso parlare della verità o dell’essenza del segno. Non si può pensare – e Husserl probabilmente lo ha fatto – che il segno […] non cada sotto la categoria della cosa in generale (Sache), non sia un “ente” sull’essere del quale si verrebbe a porre una domanda? Il segno non è forse altra cosa che l’ente, non è forse la sola “cosa” che, non essendo una cosa, non cade sotto la domanda “che cosa è”? Ma al contrario la produce all’occorrenza? Produce così la “filosofia” come dominio del ti esti?»[30].
- Considerazioni conclusive
Dopo questa breve veduta panoramica e grandangolare sui rapporti tra linguaggio e realtà nel pensiero occidentale, possiamo rassegnare ora una piccola conclusione interlocutoria, bisognosa come tale di futuri e ulteriori approfondimenti critici.
Il fenomeno del “politicamente corretto”, a ben vedere, rappresenta l’estremo esito del menzionato percorso ideologico, nel corso del quale l’uomo occidentale ha via via cercato di autonomizzare il significante dal significato, il segno linguistico dalle cose reali da esso indicate: una volta affermato che la parola dell’uomo è dotata di vita propria, di una propria autonomia ontologica rispetto alle cose reali del mondo, il politicamente corretto diviene una conseguenza pressoché necessaria e inevitabile.
Se ciò che conta non sono più gli enti reali, nella loro sostanzialità oggettiva e nei loro rispettivi accidenti di pertinenza, bensì le parole dell’uomo, quasi “parole in libertà”, è inevitabile che l’attenzione si rivolga in misura pressoché esclusiva ai modi di manifestazione del pensiero, piuttosto che agli oggetti reali del pensare: da ciò nasce l’attenzione quasi maniacale verso i toni e gli strumenti di trasmissione delle idee, prima ancora che verso i contenuti delle idee medesime; e la verità del pensiero non si misura più nella corrispondenza o difformità dello stesso rispetto alla realtà, quanto nel grado di approvazione o disapprovazione sociale di una determinata linea ideologica.
Il riduzionismo è, così, dietro l’angolo nel mondo del politicamente corretto, con il conseguente pericolo di perdere ogni contatto con la realtà oggettiva delle cose: non si affrontano più i grandi problemi e le grandi questioni della vita e dell’universo con amore per la verità, ma si dà assoluta prevalenza a ciò che gli altri penseranno di noi e del nostro modo di vedere il mondo, secondo la logica del conformismo-narcisismo tipica dell’era contemporanea.
In tal modo, la società del politicamente corretto non è più interessata ai contenuti razionali del nostro pensiero, ma è subito pronta a incasellare – con il tipico argumentum ad hominem – la nostra persona all’interno di categorie stereotipate come il progressista, il razzista, il passatista, il populista, il sessista, il sovranista, il maschilista, il femminista, il reazionario, senza più alcuna onesta attenzione verso l’intrinseca razionalità o irrazionalità di un determinato contenuto di pensiero.
- Una piccola proposta di pars construens
Probabilmente, il più efficace rimedio alla deriva del politically correct consiste in un rinnovato rapporto tra parole, pensieri e cose del mondo: se il politicamente corretto appare come l’estremo esito di un percorso ideologico teso a smembrare il nesso ontologico tra la realtà concreta del mondo, i pensieri dell’uomo e le rappresentazioni linguistiche e poi grafiche degli stessi[31], probabilmente il primo farmaco contro tale deriva è costituito dalla riscoperta dell’intimo legame razionale che incardina la parola al pensiero, e il pensiero alla realtà.
Inoltre, se la realtà – come ci insegna l’empeiria prim’ancora della pura razionalità – è variegata, differente, altra, cioè fatta dall’intreccio dialettico tra identità e differenza, unità e molteplicità, ogni opzione ideologica elitaria, la quale pretenda di neutralizzare a tavolino o in laboratorio tale dato naturale è probabilmente destinata a produrre effetti collaterali ben peggiori rispetto ai mali che, in ipotesi, ci si proponeva di curare.
Non è detto, infatti, che l’indifferentismo valoriale generi una vera pace sociale, come intende invece affermare un certo irenismo neutralista; anzi, l’esperienza concreta sembra dimostrare l’esatto contrario, e cioè che il neutralismo può, tutt’al più, creare situazioni di apparente “silenzio sociale”, il quale però è solo una effimera crosta sotto la quale continuano inevitabilmente a ribollire proprio quelle differenze e quelle alterità che il protocollo convenzionale si proponeva, per l’appunto, di occultare, senza evidentemente potervi riuscire.
A ben vedere, il rispetto reciproco fra le persone, le culture, le religioni e le nazioni richiede necessariamente uno studio razionale della realtà e un profondo spirito di carità e di sacrificio, il quale deve essere continuo e ininterrotto, poiché altrettanto ininterrotta e continua è l’evoluzione dei tempi e dei popoli; viceversa, il politicamente corretto rappresenta spesso una forma di paradossale riduzionismo il quale, sorto al dichiarato fine di aumentare il rispetto e la tolleranza fra le persone, sembra condurre a forme ancora più sottili e spietate di indifferenza, la quale è anticamera dell’incuria e di sempre nuove forme di disprezzo.
[1] G. Orwell, Politics and the English Language, in Horizon, 1946, vol. 13, pubbl. 76, pp. 252-265.
[2] Sul “politicamente corretto”, la bibliografia internazionale è assai vasta; fra tutti, citiamo qui G. Reguzzoni, Il liberalismo illiberale. Come il politicamente corretto è divenuto la nuova religione civile delle società liberali, Arona, 2015; E. Capozzi, Politicamente corretto. Storia di un’ideologia, Venezia, 2018; J. Friedman, Politicamente corretto. Il conformismo morale come regime, Milano, 2018; R. Huges, La cultura del piagnisteo. La saga del politicamente corretto, Milano, 1994; inoltre, in www.centrostudilivatino.it, cfr. M. Ronco, Il ‘caso Der Spiegel’: fake news e narrazioni mendaci, 18 maggio 2021. Infine, ci sia consentito il richiamo a G. Civello, Cause ed effetti del “politicamente corretto”: una ipotesi di lavoro, in Studium, 2021, in corso di pubblicazione.
[3] Così in G. Reguzzoni, op. cit., passim, spec. p. 63 ss., con una serie di riferimenti storici e di letteratura.
[4] J. Friedman, op. cit., p. 71: «Il politicamente corretto è una forma di comunicazione in cui il valore di segno, l’attribuzione categoriale degli enuncianti e dei testi, è considerevolmente più significativa del loro contenuto semantico».
[5] R. Huges, op. cit., pp. 71-72.
[6] J. Friedman, op. cit., p. 22.
[7] Platone, Sofista, 260a: «Per noi il discorso (logos) è uno dei generi degli enti. Se fossimo privati di esso, saremmo privati – la cosa più grave di tutte – della filosofia stessa. Inoltre, in questo momento, dobbiamo metterci d’accordo su che cosa è un discorso: se ne venissimo privati in modo che esso non esistesse affatto, non saremmo in grado di dire più nulla, se non erro». Sui rapporti tra parola e realtà in Platone, è ormai classico M. Kraus, Namen und Sache, Amsterdam, 1988; cfr. in chiave ricostruttiva, M. Erler, Platone e il linguaggio, in Id., Platone. Un’introduzione, Torino, 2008, p. 121 ss.
[8] Platone, Teeteto, 189e.
[9] Platone, Sofista, 263e: «Pensiero e discorso sono la stessa cosa, tranne che l’uno è un dialogo interno dell’anima con se stessa, che avviene senza voce, ed è proprio questo che noi abbiamo denominato pensiero».
[10] Platone, Filebo, 38e.
[11] Platone, Cratilo, 384d-e: «Il nome di qualunque cosa non gli appartiene per natura, ma solo per disposizione e consuetudine di coloro i quali trasformano le parole in uso corrente e le utilizzano». Sul Cratilo, è celeberrimo il commento redatto da Proclo nel V sec. d.C.
[12] Ibidem, 383a-b: «Ogni cosa possiede la corretta denominazione che gli spetta per natura, […] nel complesso la stessa per Greci e barbari».
[13] Platone, Menone, 74d.
[14] Sul rapporto triadico tra parole, idee e cose del mondo, cfr. M. Erler, op. cit., p. 121 ss.
[15] Aristotele, De interpretatione, 16a. Su questi temi, cfr. J. Pépin, Symbola, semeia, omoiomata: à propos de De Interpretatione I, 16a 3-8 et Politique VIII 5, 1340a 6-39, in J. Wiesner (hrsg.), Aristoteles: Werk und Wirkung, W. de Gruyter, Berlin, 1985, pp. 69-126; R. Polansky, M. Kuczewski, Speech and Thought, Symbol and Likeness: Aristotele’s De Interpretatione 16a 3-9, in Apeiron 23 (1990), pp. 51-63.
[16] L. Palpacelli, Saggio introduttivo al De interpretatione, in Aristotele, Organon (a cura di Maurizio Migliori), Milano, 2016, p. 161 ss.
[17] Aristotele, De interpretatione, 16a 10.
[18] Cfr. E. Berti, Il concetto di “sostanza prima” nel libro Z della Metafisica, in Id., Aristotele. Dalla Dialettica alla filosofia prima, con saggi integrativi, Milano, 2014, p. 529 ss., in cui l’insigne studioso patavino evidenzia come, quando la prote ousia viene identificata da Aristotele con la forma (eidos) delle cose nell’anima, lo Stagirita sta utilizzando il termine ousia nel senso di essentia (cfr. Metafisica, 1032b 16); quando, invece, la prote ousia viene identificata con gli oggetti concreti e reali (come un certo uomo o un certo cavallo), il sostantivo greco ousia sta a indicare la substantia vera e propria (cfr. Categorie, 2a 11-19; 3b 10-18).
[19] Aristotele, De interpretatione, 16a 12 ss.: «Il falso e il vero infatti hanno a che fare con la connessione (synthesin) e la divisione (diairesin). Pertanto, i nomi e i verbi in se stessi sono simili al pensiero senza connessione e divisione, per esempio “uomo” o “bianco”, qualora non si aggiunga qualcosa: infatti non è falso e neanche vero. C’è una prova di questo: infatti “ircocervo” significa qualcosa, ma non è ancora vero o falso, se non si aggiunge l’essere o il non essere o in senso assoluto o in un tempo determinato».
[20] Cfr. A. Canili, Introduzione. Per una storia delle teorie linguistiche: il De Magistro di Aurelio Agostino, in Sant’Agostino, De magistro, Milano, 1993.
[21] Cfr. A. Canili, op. cit., pp. 14-15.
[22] Come noto, Heidegger si occupò dei problemi del linguaggio sin dai suoi primissimi scritti, come dimostra la sua Habilitationsschrift dal titolo La dottrina delle categorie e del significato in Duns Scoto (oggi pubblicata per Mimesis a cura di Antonello D’Angelo).
[23] A. Fabris – A. Cimino, Heidegger, Roma, 2009, p. 119.
[24] Ibidem, 120. Come noto, nel pensiero heideggeriano, il termine Ereignis (evento, evento-appropriazione o avvenimento) sta a indicare una nuova categoria filosofica: non più il concetto aristotelico-tomista dell’ente come un qualcosa di oggettuale e presente al soggetto, bensì una nuova idea di “esperienza vissuta” (Erlebnis), ossia l’accadimento di qualcosa come qualcosa di vissuto ed esperito da me stesso (in contrapposizione al sistema delle Categorie aristoteliche, inteso da Heidegger come troppo statico, rigido e avulso dal fluire della storia). Come tale, Ereignis è qui contrapposto a Vorgang (processo), che indica invece l’accadere considerato in maniera neutra e distaccata come un semplice movimento fisico, senza relazioni con l’io che lo vive e lo esperisce. Dopo la c.d. Kehre o svolta, dal 1936 in poi, Ereignis diventerà parola fondamentale del pensiero heideggeriano e starà a indicare l’essenziale riferirsi dell’Essere all’uomo, l’Essere come essere destinato all’uomo (cfr. il Glossario finale a M. Heidegger, Essere e tempo, nuova edizione italiana a cura di Franco Volpi sulla versione di Pietro Chiodi, Milano, 2001, 589-590). Da tale punto di vista, il concetto heideggeriano di “evento” è essenzialmente relazionale e modale, nel senso che non rimanda ad un che cosa (nell’ottica classica della substantia–essentia e del ti esti greco), bensì a un come viene vissuto l’essere nell’esperienza dell’Esserci, cioè dell’uomo, in una chiave squisitamente fenomenologica che a Heidegger era stata, ovviamente, trasmessa dal maestro Husserl (A. Fabris – A. Cimino, op. cit., p. 85).
[25] G. Vattimo, Introduzione a Heidegger, Bari, 2002, pp. 121-122.
[26] C. Fabro (a cura di), Storia della filosofia, Città del Vaticano, 1959, vol. II, p. 771: «La novità del Neopositivismo è nell’aver concentrato la determinazione della verità nell’analisi del linguaggio così che la determinazione della verità dell’esperienza si risolve di volta in volta in un problema di “sintassi logica del linguaggio”: di qui l’importanza assunta dall’impiego della matematica pura e dei suoi simboli che formano la logistica».
[27] M. Ferraris, Introduzione a Derrida, Bari, 2003, passim.
[28] Cfr. G. Dalmasso, Impensabilità della scrittura, introduzione a J. Derrida, Della grammatologia, Milano, 2012, p. I ss.
[29] J. Derrida, Sulla grammatologia, cit., p. 73 ss.: «Bisogna pensare la traccia prima dell’ente. […] Il campo dell’ente, prima di essere determinato come campo di presenza, si struttura secondo le diverse possibilità – genetiche e strutturali – della traccia». Di contro, così l’Autore descrive la precedente concezione dei rapporti tra segno e cose: «Il signatum rinviava sempre, come al suo referente, ad una res, ad un ente creato o in ogni caso prima pensato e detto, pensabile e dicibile all’eterno presente nel logos divino e precisamente nel suo soffio. Se esso veniva ad essere in rapporto con la parola di uno spirito finito […] tramite l’intermediario di un signans, il signatum aveva un rapporto immediato con il logos divino che lo pensava nella presenza e per il quale esso non era una traccia. E per la linguistica moderna, se il significante è traccia, il significato è un senso pensabile in principio nella presenza piena di una coscienza intuitiva. La faccia significata, nella misura in cui la si distingue ancora originalmente dalla faccia significante, non è considerata come una traccia: di diritto, essa non ha bisogno del significante per essere ciò che è […]. Questo riferimento al senso di un significato pensabile e possibile al di fuori di ogni significante, resta dipendente all’onto-teo-teleologia che abbiamo appena evocato. È l’idea di segno dunque che bisognerebbe decostruire con una meditazione sulla scrittura che si confonderebbe, come deve, con una sollecitazione dell’onto-teologia, che la ripeta fedelmente nella sua totalità e la scuota nelle sue più sicure evidenze» (ibidem, pp. 106-107; corsivi originali, in nota riportati in tondo nel rispetto dei criteri redazionali).
[30] J. Derrida, La voce e il fenomeno. Introduzione al problema del segno nella fenomenologia di Husserl, Milano, 1984, pp. 55-56.
[31] Cfr. J. Friedman, op. cit., p. 22, in cui una radice del politicamente corretto viene individuata nella presunta e asserita «impossibilità di un’argomentazione razionale nella quale delle asserzioni sono comparate alla, o testate con, la “realtà”. Alla fine, la creazione di “regimi di verità” è interamente una questione di potere, il potere dell’imposizione».