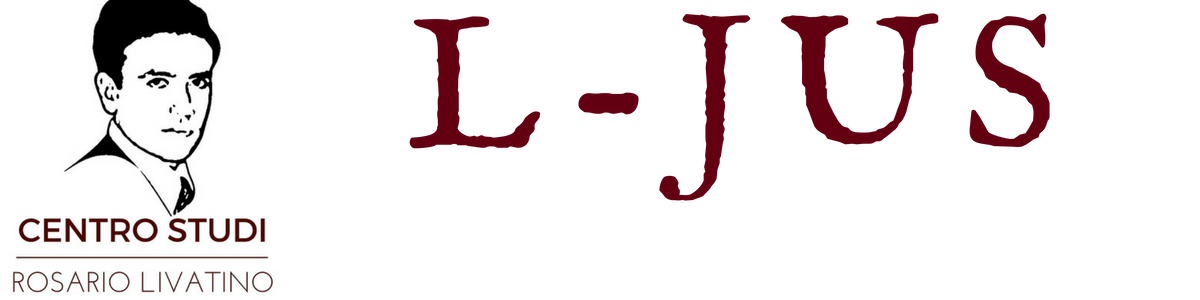Domenico Menorello
Avvocato in Padova e Dottore di ricerca in Filosofia del Diritto
Università degli Studi di Padova
Sommario: 1. Una soluzione di continuità nell’ordinamento italiano. Premessa e sintesi ‒ 2. Il prolungato velo italiano sul “cambio d’epoca” ‒ 3. Il bivio antropologico: Francesco o dell’homo religiosus ‒ 4. Segue: il bivio antropologico: Prometeo o della cultura dello scarto ‒ 5. Un “nuovo diritto” per imporre la scelta di Prometeo ‒ 6. Nel 2014/2015, le leggi 162 e 55 allentano i legami familiari, derubricando il matrimonio a fatto privato ‒ 7. Nel 2016, la legge 76 “Cirinnà” pretende una modifica ontologica della famiglia ‒ 8. Nel 2017, la legge 219 sul “biotestamento” (DAT) spezza il nesso fra “vita” e “dignità”, indirizzando il SSN verso la seconda ‒ 9. Nel 2018/2019, la Corte costituzionale ordina al Parlamento che disciplini la morte assistita ‒ 10. Nel 2020, la de-responsabilizzazione e la de-ospedalizzazione dell’aborto ‒ 11. Ancora nel 2020, la Camera approva il tentativo di imporre per legge l’ideologia gender ‒ 12. Nel 2021, per sentenza diviene possibile la “maternità surrogata” all’estero ‒ 13. Ancora nel 2021, la Camera spinge il Paese nell’anticamera dell’eutanasia ‒ 14. Il “cambio d’epoca” come privilegiata occasione di presenza, nell’unità.
- Una soluzione di continuità nell’ordinamento italiano. Premessa e sintesi
L’ordinamento italiano sembra essere entrato in quel “cambiamento d’epoca” svelato da Papa Francesco nel 2015[1]. A lungo in Italia era sopravvissuto un sottile tratto, apparente e superficiale, di convinzioni sociali, che ‒ seppur sempre più stancamente e retoricamente ‒ affermavano la vita come valore assoluto in ogni circostanza. Da qualche anno, invece, anche gli echi di queste certezze sociali sono svaniti ed è sopravanzata quella crisi in cui si trova tutta la cultura europea e occidentale, che, secondo Benedetto XVI, «prima ancora di essere politica, degli stati e delle sue istituzioni, è una crisi dell’uomo. La crisi è innanzitutto antropologica. Un uomo che ha perso ogni riferimento di fondo, che non sa più chi è»[2]. Di qui lo smarrimento sociale, enfatizzato dalla pandemia, nel quale trova campo l’illusione del mito di una “autodeterminazione” che si vorrebbe assoluta, “liberata” tanto dai legami umani, percepiti come limiti negativi, quanto dalla stessa realtà, ritenuta nichilisticamente recessiva rispetto alle pretese soggettive.
In particolare, per la prima volta nella storia repubblicana, da alcuni anni la legislazione e la giurisprudenza sono diventate strumenti branditi massicciamente per spingere direttamente il popolo verso una concezione prometeica di uomo/divo, unica misura di tutto, che non riconosce responsabilità e condizionamenti, al punto da legare il valore della propria vita al successo di sé. Quando, invece, sopravvengono la fragilità, la debolezza o il fallimento, allora la vita non è più considerata “dignitosa” e le istituzioni sono piegate contro l’esistenza del singolo, fino a scartarla. Così come intuito il 5 giugno 2013 dal Pontefice, l’antropologia “del successo” porta con sé “la cultura dello scarto”[3].
Se per quasi sessant’anni di Repubblica la “politica” e la conseguente legislazione si erano tenute mediamente lontane dalla diretta pretesa di voler incidere su questioni valoriali, salva qualche significativa e profetica eccezione ‒ la più importante delle quali è stata la legge n. 194/1978 ‒, almeno dal 2014/2015 vi è una costante rottura nella concezione delle leve normative e il “diritto” è divenuto esplicito strumento per “liberare” l’uomo, imponendo l’evocato modello di Prometeo. La sequenza di un simile utilizzo del diritto è impressionante: nel 2014-2015 le leggi 162 e 55 hanno reso facilissima la risoluzione del legame matrimoniale, derubricandolo a fatto privato; nel 2016 la legge 76 ha costruito modelli familiari senza legami stabili, né responsabilità verso le persone coinvolte, né apertura alla vita; nel 2017 la legge 219 ha normativamente trasformato il diritto alla vita in diritto ad una “vita dignitosa”, facendo ritenere “scartabili” dal SSN quelle non ritenute tali; nel 2018 e 2019, la Consulta ha “ordinato” al Parlamento di consentire per legge il suicidio medicalmente assistito; nel 2020 il Ministero della Salute ha avviato la “privatizzazione” dell’aborto e la Camera ha licenziato il DDL Zan, con il tentativo di imporre il soggettivismo e il relativismo più esasperati propri dell’ideologia “gender”; nel 2021 una sentenza di marzo ha aperto una breccia per la maternità surrogata, mentre nei mesi successivi si sta procedendo a marce forzate per introdurre l’eutanasia negli ospedali italiani.
Nei paragrafi che seguono ci si soffermerà, in premessa, sulla “sopravvivenza” sociale di certezze derivanti dalla tradizione (par. 2), al fine di cogliere la “rottura antropologica” rispetto al modello sotteso alla tradizione (par. 3) per una scelta ‒ operata soprattutto tramite il diritto ‒ a favore di una diversa e specifica matrice ideologica individualista, sul modello del mito di Prometeo (par. 4). Quindi, ai paragrafi ancora successivi, si incederà nel tratteggiare, per cenni concreti, tale parabola antropologica insita nella produzione legislativa e giuridica degli ultimi anni (paragrafi da 5 a 13), per interrogarsi, infine, su quali questioni strutturali ponga il mutato contesto ordinamentale rispetto a una presenza pubblica dei cattolici in Italia (par. 14).
- Il prolungato velo italiano sul “cambio d’epoca”
Come accennato in premessa, nella società italiana vi è stato un lungo periodo, trascinatosi fino a pochi anni or sono, in cui a uno sguardo superficiale potevano sembrare ancora prevalenti i riflessi di una koiné ampiamente condivisa, incentrata sul ritenuto valore assoluto di ogni circostanza dell’esistenza. Fra i numerosi esempi di tale dato, ne basteranno due, uno politico e uno giuridico.
Quanto al primo, significativa della sopravvivenza di “certezze sociali” cui si è fatto riferimento è l’intervista del 24 gennaio 1995 a Famiglia Cristiana di Massimo D’Alema, quando l’allora segretario dei DS affermava sull’eutanasia, di «essere contrario all’arresto deliberato di una vita» o sulla coppia gay, che essa ha diritto «a vivere senza persecuzioni, ma non può essere una famiglia»[4].
Ancor più precisa, poi, la sentenza del 16 dicembre 2006 della Corte d’Appello di Milano, la quale, nel respingere il ricorso di Beppino Englaro, che voleva togliere alimentazione e idratazione assistite alla figlia Eluana, motivava il diniego «poiché la medesima Corte non ha alcuna possibilità di accedere a distinzioni tra «vite degne e non degne di essere vissute» (…) Il bilanciamento tra il bene giuridico della vita, da un lato, e quelli della dignità e dell’autodeterminazione della persona, dall’altro lato, non può che risolversi a favore del primo». Si tenga ben presente l’endiadi individuata dalla Corte territoriale di Milano “vita/dignità”, che può essere assunta a cartina tornasole di convinzioni in ordine alla gerarchia fra questi due valori, gerarchia che il “cambiamento d’epoca” di lì a pochi anni rovescerà rispetto all’equilibrio individuato nel 2006, il quale, per il vero, poggiava su consolidate basi giuridiche.
Esiste infatti una chiarissima giurisprudenza della Corte Costituzionale, derivata anche dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché dall’esplicito art. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che ha inscritto il diritto alla vita fra i diritti inviolabili dell’uomo ai sensi dell’art. 2 della Carta Costituzionale (cfr. sentenze Corte costituzionale n. 54 del 1979, n. 223 del 1996, n. 35 del 1997)[5] ovvero fra quei diritti che «appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana» (Corte costituzionale n. 1146 del 1988), i quali «impongono una garanzia assoluta» (n. 223 del 1996, citata).
Vi è di più. La sentenza della Consulta n. 218 del 1994 stabiliva addirittura che il diritto a essere oggetto di tale garanzia assoluta «impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possono appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto» alla vita sancito come valore supremo (cfr. sentenze n. 432 del 2005, n. 233 del 2003, n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999, n. 267 del 1998).
Nel 1954 parlando con i ragazzi che incontrava in treno la mattina, don Luigi Giussani si accorgeva che a quella diffusa superficie cristiana nei costumi e nelle prassi italiane non corrispondeva più una reale esperienza di umanità “centuplicata” nella fede. «Si trattava in effetti di un falso equilibrio» ‒ osservava profeticamente nel 1976, ripercorrendo gli inizi del suo apostolato negli anni 1950 ‒ «sostenuto soltanto dal rispetto formale di leggi e consuetudini in cui non si credeva più, e che quindi ben presto sarebbero state abbandonate. Si trattava dunque di un equilibrio soltanto formale: e ciò era inequivocabilmente dimostrato dal suo esito a livello educativo. Una società realmente e fecondamente in equilibrio trova infatti nella generosa disposizione all’impegno dei suoi giovani la prima misura e la prima conferma della propria forza vitale. Nell’Italia degli anni 50, invece, la stragrande maggioranza di essi restava racchiusa nel modesto perimetro di piccole speranze e di piccoli progetti, individuali in quanto all’ambito e borghesi in quanto alla formulazione»[6].
La secolarizzazione erodeva dunque il terreno della cultura italiana carsicamente, così che apparentemente sarebbe ancora a lungo sopravvissuta nella società italiana una qualche forma di pensiero antropologico di matrice cristiana, secondo cui la persona avrebbe dovuto ricevere sempre un giudizio di valore assoluto, rappresentandola – magari inconsciamente – aperta alla vita, il che a sua volta significava riconoscere la famiglia ancora come l’alveo sociale ed educativo primario. Il “non possiamo non dirci cristiani”[7] è stata, insomma, davvero una cifra a lungo dominante della società italiana.
Così, se questa superficiale koiné appariva ancora condivisa nella società, si può comprendere quella ulteriore diffusa implicita convinzione fra i cattolici, secondo cui l’impegno pubblico non poteva che concentrarsi sulle “conseguenze” di tali “certezze” sociali, dunque sulla “politica” tout court e sulle forme partitiche di organizzazione della medesima in particolare. Un impegno politico, quest’ultimo, che, per il vero, nel tempo è apparso sempre più sganciato dagli ideali, via via concentrato in misura crescente sulla gestione del potere, senza accorgersi della mutazione genetica in corso nel corpo sociale. A riprova della caduta di coscienza rispetto agli ideali che avrebbero dovuto, in generale, sorreggere un impegno pubblico, basti ricordare come si sia smarrito persino il significato della primaria categoria politica della moderazione, benché ad essa si siano costantemente riferiti tutti i tentativi “centristi” censibili.
L’essere politicamente moderato, cioè, avrebbe dovuto significare una concezione dell’utilizzo delle leve politiche sussidiario rispetto al tessuto sociale, con il conseguente esercizio di una vigile e severa attenzione, affinché il potere non assumesse pretese di diretta imposizione culturale e antropologica sul popolo, preoccupazione da cui derivava persino il simbolo dello “scudo” proprio del principale partito della prima Repubblica. Un siffatto principio “moderato” si radicava a tal punto nella cultura italiana da far dichiarare, nel 1995, persino al segretario della principale forza di sinistra (storicamente discendente da concezioni della politica di tutt’altro segno) che sulle questioni attinenti la vita e la famiglia «i partiti e la politica debbano fare un passo indietro per lasciare il posto al primato della coscienza»[8]. Tale accezione dell’essere moderati si è però via via smarrita quanto al suo significato di criterio fondante il pensiero e l’azione politici, per assumere, invece, il significato diffuso di una postura sostanzialmente timida e restia a una chiarezza di posizioni, sempre disponibile a qualsiasi accomodamento sui contenuti specie per ottenere o mantenere potere.
In effetti, quel falso equilibrio sociale intuito da don Giussani, trascinatosi per decenni nella recente storia del nostro Paese, ha probabilmente ovattato e oscurato la coscienza della grande “questione antropologica”, che in ogni caso giustificava e originava anche quell’assetto giuridico e istituzionale “prudente” quale era quello mediamente in essere in Italia fino a pochi anni or sono. Tuttavia, la questione antropologica permea sempre più ‒ come si vedrà ‒ la legislazione e la giurisprudenza nel recente decennio sui temi della vita, della morte, della libertà, del significato della realtà, e cioè l’idea stessa di uomo verso cui, legiferando, comunque si prende posizione di fronte alla società.
Sovviene, sul punto, la chiarezza con cui l’Aquinate fornisce il significato strutturale della “norma”. Per San Tommaso una legge «non è che una prescrizione della ragione, in ordine al bene comune, promulgata dal soggetto alla guida della comunità»[9].
Pertanto, la norma e il diritto non possono essere trattati come meri fattori “dati”, da manipolare astrattamente e tecnicamente solo sulla base dell’esplicitarsi formale degli stessi, secondo i dogmi del pensiero giuspositivista a lungo dominante nelle Università italiane, ma vanno finalmente percepiti come segni di una qualche precisa matrice culturale, da individuare, comprendere e giudicare. Non a caso nello stesso tempo in cui Papa Francesco vedeva che «quella che stiamo vivendo non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento di epoca»[10], il Presidente dei Vescovi italiani intuiva immediatamente il passo cui erano e sono chiamati tutti, ma in particolare i cattolici: «Mai come oggi c’è un urgente bisogno di uomini e donne che sappiano usare un linguaggio di verità, senza nascondere le difficoltà, ma indicando una strada e una meta»[11].
- Il bivio antropologico: Francesco o dell’homo religiosus
L’opzione a favore della priorità della “vita” rispetto alla ritenuta “dignità” a lungo in qualche modo perdurata nell’ordinamento italiano, sintetizzata nel 2006 dalla Corte di Appello di Milano sul caso Englaro, non era certamente casuale, ma discendeva da un preciso sguardo sull’uomo. C’è stato, infatti, un Annuncio nella storia, secondo cui “anche i capelli del capo” sono contati, secondo cui ogni istante, esaltante o doloroso che sia, è segno di un destino buono di ciascuno, cosicché ogni circostanza di vita è percepita sempre come un valore assoluto. Sempre “sacra”, perché tutto diviene anelito a un significato da incontrare fuori di sé. È l’homo religiosus[12].
In questo sguardo sull’umano, la “piccolezza”, la “debolezza” e la “fragilità”, quali sono i tratti propri di un nascituro, di un malato o di un anziano, sono percepiti come valore assoluto, anzi proprio simili circostanze sono occasione per una accoglienza e una cura umane particolarmente intense. «Credo che Francesco sia l’esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità» ‒ afferma Papa Francesco nell’apertura della Laudato si’[13] ‒ «In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore. Se noi ci accostiamo alla natura e all’ambiente senza questa apertura allo stupore e alla meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della fraternità e della bellezza nella nostra relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti saranno quelli del dominatore, del consumatore o del mero sfruttatore delle risorse naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi immediati. Viceversa, se noi ci sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno in maniera spontanea. La povertà e l’austerità di san Francesco non erano un ascetismo solamente esteriore, ma qualcosa di più radicale: una rinuncia a fare della realtà un mero oggetto di uso e di dominio».
In questa prospettiva antropologica, la “dignità” non muta di intensità sulla base dell’esito più o meno “positivo” delle circostanze dell’esistenza, ma appartiene comunque a ogni istante di vita, come “dato” riconosciuto, qualsiasi ne sia la condizione.
Alla radice di tale proposta vi è, dunque, un’idea di uomo che ha sempre un valore assoluto, perché ogni circostanza del reale si definisce come relazione, come “segno”, anche accettando il limite per aprirsi all’Altro da sé. “Quid animo satis?” si domandava Francesco d’Assisi[14], cui fa eco ancora la Laudato Sì: “L’apertura ad un «tu» in grado di conoscere, amare e dialogare continua ad essere la grande nobiltà della persona umana. Perciò, in ordine ad un’adeguata relazione con il creato, non c’è bisogno di sminuire la dimensione sociale dell’essere umano e neppure la sua dimensione trascendente, la sua apertura al «Tu» divino. Infatti, non si può proporre una relazione con l’ambiente a prescindere da quella con le altre persone e con Dio”[15].
- Segue: il bivio antropologico: Prometeo o della cultura dello scarto
Il cambio di passo nell’utilizzo del diritto che, come si vedrà, sta incalzando la produzione normativa degli ultimi anni, sembra voler tracciare un modello umano sensibilmente differente da quello accennato al paragrafo precedente, in quanto è una considerazione dell’umano in cui il valore assoluto di ogni istante dell’esistenza non viene più riconosciuto, perché vi sarebbero situazioni di vita “degne” rispetto ad altre “indegne”, nelle quali il valore dell’esistenza diviene recessivo. La concezione antropologica del “nuovo diritto” assume tratti peculiari desumibili da un certo concetto di “libertà”, che si risolve nell’esaltazione del mito dell’”autodeterminazione” di un soggetto concepito come del tutto autoreferenziale e “solo”.
«La libertà, Sancho, è il più gran dono che Dio ha fatto all’uomo»[16]. Anche l’uomo di questo “nuovo diritto” si afferma soprattutto “libero”. Ma pretendendo quale libertà? Innanzitutto, una libertà dai legami umani e dai tratti oggettivi della realtà.
«Una ragione senza interferenze, questo è il mito della pedagogia neutrale, della educazione senza educatore», osserva il costituzionalista Andrea Simoncini[17]. «È evidente» – continua – «che la nascita di un figlio disabile (o più semplicemente di un figlio diverso da come lo vorrei) cambia la vita e ti rende, in qualche modo dipendente da lui. Questo vuol dire che non sono più libero? Il diritto e la tecnica sono diventati gli strumenti fondamentali per “tagliare” questi legami. E per questo diritto e tecnica oggi sono i baluardi della libertà moderna», concepita essenzialmente come l’affrancarsi dalle relazioni umane e più in generale dalla dipendenza dal reale.
Quindi, per affermare una simile concezione di “libertà” va – come vedremo effettivamente accadere – combattuta la “responsabilità”, cosicché devono essere sciolti i legami umani e si procede a un progressivo disconoscimento della realtà come dato oggettivo. Una così costruita idea di libertà, che non vuole relazioni e rifiuta responsabilità e oggettività del reale, implica e conduce al modello di un “uomo solo”. La solitudine, infatti, è l’altra grande cifra antropologica sottesa alla nuova legislazione. Illuminante, sul punto, Stefano Zamagni: «Noi viviamo l’epoca della seconda secolarizzazione. La prima era comportarsi etsi deus non daretur. Quello di cui non si tiene conto è che oggi siamo entrati nella seconda secolarizzazione di cui però nessuno vuol parlare. Questa seconda secolarizzazione è ben resa da quest’altro aforisma: bisogna comportarsi etsi communitas non daretur, come se la comunità non esistesse. Quindi questa seconda secolarizzazione è figlia del cosiddetto individualismo libertario. L’individualismo c’era anche prima, all’epoca della prima secolarizzazione, ma oggi si è accasato con il libertarismo il cui slogan è volo ergo sum, voglio dunque sono, sono perché voglio»[18].
L’intuizione di Zamagni illumina anche l’ulteriore essenziale tratto dell’antropologia pretesa dal “nuovo diritto”: un uomo che non riconosce il reale, né i legami con altro da sé, non può che consistere in quel che “vuole”. Di qui, come anticipato, l’esaltazione della autodeterminazione, che sta divenendo ‒ come si vedrà infra ‒ il criterio assoluto per misurare la dignità stessa della vita umana. Il “nuovo diritto”, cioè, pone con forza «la correlazione fra autodeterminazione e dignità umana»[19]. Ma se esiste solo ciò che voglio, allora la dignità dell’uomo non è più assoluta, ma lo è nella misura in cui l’autodeterminazione si attua. Come per Prometeo.
In sintesi: il diritto alla vita non è più assoluto, ma degrada a diritto a una vita dignitosa. Questa disegnata antropologia, caratterizzata da una vita libera nel senso di essere priva di legami, in cui l’uomo non deve dipendere da altro che da sé per autodeterminarsi, assumendo la stessa autodeterminazione quale unica e suprema misura di tutte le cose, conduce a ulteriori conseguenze.
La libertà, concepita come proiezione soggettiva che non riconosce limite a sé, diviene presto un’iperbole indefinita di “nuovi diritti”, che vengono pretesi dallo Stato, e perciò ci si aspetta che «tutti i fattori della vita siano normati e protetti dalla politica»[20].
Tuttavia, e paradossalmente, un uomo solo, senza appartenenza, in realtà finisce per “autodeterminarsi” secondo la mentalità dominante. Le iperboli soggettive in effetti mutuano i modelli dai canoni più radicati di un atteso “successo”.
Così, la dignità finisce per diventare sinonimo di efficienza, di capacità di essere performanti, che diviene, in questa parabola, il parametro concreto della dignità. Chi non “riesce” o non ha più “successo” per fallimenti, inabilità, povertà, fragilità diviene uno scarto. Può essere scartato. Anzi, viene indotto a desiderare di essere scartato.
L’altra faccia dello scarto è la reificazione della persona. Chi è debole, piccolo, bisognoso è alla mercé del più forte, del più ricco. Si dà «in mano a chi è più forte la vita di chi è più debole»[21], che diviene “cosa”, “merce” che si compra, come ‒ lo vedremo – accade, violentemente, con l’utero in affitto.
Il crinale su cui si posizione questa idea ridotta di uomo è efficacemente scolpito ancora nella Laudato si’: «Quando l’essere umano pone sé stesso al centro, finisce per dare priorità assoluta ai suoi interessi contingenti, e tutto il resto diventa relativo. Perciò non dovrebbe meravigliare il fatto che, insieme all’onnipresenza del paradigma tecnocratico e all’adorazione del potere umano senza limiti, si sviluppi nei soggetti questo relativismo, in cui tutto diventa irrilevante se non serve ai propri interessi immediati. Vi è in questo una logica che permette di comprendere come si alimentino a vicenda diversi atteggiamenti che provocano al tempo stesso il degrado ambientale e il degrado sociale»[22].
- Un “nuovo diritto” per imporre la scelta di Prometeo
Con quali strumenti viene promossa l’antropologia di Prometeo, così funzionale a chi detiene le leve della moda e della mentalità dominante? Certamente con i pervasivi sistemi di comunicazione sociale, specie di nuova generazione. Ma si è capito anche il valore educativo e orientativo della norma, riscoprendo gli insegnamenti di Tommaso d’Aquino[23].
Una norma, una legge sceglie sempre qualcosa ritenuto un bene per tutti, cioè un bene comune, e condiziona l’intera comunità civile verso quello stesso valore. Ce lo rivela il linguaggio, che usa l’aggettivo “legale” o “lecito” come sinonimo di “positivo”, di “buono”. Perciò, chi vuole imporre una nuova mentalità al popolo è diventato (…) tomista e, con buona pace del D’Alema versione 1995[24], ha capito che la nuova antropologia può essere direttamente imposta anche usando il potere pubblico, legislativo e giudiziale.
Se per decenni è stata percepita come una anomalia, o quanto meno come una eccezione, che il Legislatore prendesse diretta posizione su temi “etici”, ormai da alcuni anni si assiste costantemente a una dinamica opposta.
Sembra non reggere più quella convinzione “moderata” a lungo perdurata in Italia, secondo cui la politica avrebbe dovuto principalmente occuparsi di leve ordinamentali, sociali, fiscali ed economiche, non invadendo direttamente il campo delle convinzioni ideali, antropologiche ed esistenziali dei singoli, secondo una concezione di laicità dello Stato propria tanto del Magistero sociale della Chiesa cattolica, quanto dei princìpi della prospettiva politica liberale.
Al contrario, i player culturali “di Prometeo” stanno pesantemente utilizzando ‒ ammoniva Simoncini[25] ‒ il diritto per spezzare più facilmente i legami umani, per allentare le responsabilità e assecondare la pretesa della volontà di liberarsi dai limiti del reale, potendo arrivare a chiedere al Servizio Sanitario Nazionale di uccidere, e così affermando quel modello antropologico individualista verso cui queste iniziative legislative vogliono condurre: un uomo assoluta misura del reale, padrone della vita e della morte, che ritiene di essere libero solo se può svincolarsi da qualsiasi dipendenza, cioè tanto da qualsiasi appartenenza comunitaria ed umana, quanto – e persino – dalle circostanze stesse del vivere reale, comprese quella della malattia e della morte o della differenza sessuale.
La vita vale solo se ha successo. Se asseconda il proprio “sogno”, di solito indotto dai canoni di performanza e utilità sociale. Non è sacra sempre e in qualunque condizione.
Giova, allora, proporre un sintetico excursus in questi ultimi anni nei quali si è consumata una soluzione di continuità nella concezione stessa dell’ordinamento italiano, per fornire esemplificativi indizi della traiettoria antropologica che, con costante continuità e pervicacia, si tenta di imporre al popolo italiano attraverso le leve della produzione legislativa e della interpretazione normativa.
- Nel 2014/2015, le leggi 162 e 55 allentano i legami familiari, derubricando il matrimonio a fatto privato
La legge 6 maggio 2015 n. 55 ha rivisto i termini per ottenere il divorzio. In simili casi, prima di tale riforma per la richiesta di cessazione definitiva del legame matrimoniale le separazioni si dovevano protrarre senza interruzione per almeno tre anni dall’avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale.
Con la legge n. 55/2015 in commento, invece, per la proposizione della domanda di divorzio è sufficiente un anno nella procedura di separazione personale e appena sei mesi nel caso di separazione consensuale (cfr. art. 1). Con il “nuovo diritto”, dunque, è facilitata la “liberazione” dai legami, pretendendo di imporre quella idea di “libertà” come indipendenza dal nesso con gli altri e dalle relative responsabilità.
La novella citata è stata l’immediato seguito della precedente legge 10 novembre 2014 n. 162, di conversione del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, che all’art. 6 ha anche previsto nuovi modi per la separazione coniugale.
In particolare, attraverso lo strumento della negoziazione assistita, la legge in parola consente ai coniugi di recarsi da un avvocato per procedere in tal senso utilizzando una procedura non giudiziale di convenzione assistita.
Eliminando la necessità di un procedimento avanti a un giudice (rimasta solo nei residuali casi di cui all’ultimo periodo del co. 2 dell’art. 6), il “nuovo diritto” ha altresì derubricato il legame matrimoniale a fatto privato, togliendo o smorzando l’aspetto di “responsabilità pubblica” del matrimonio come assunzione di impegni verso terzi (la prole) e verso la comunità civile, sul presupposto per cui la dinamica educativa dei genitori verso i figli è elemento essenziale per l’esistenza stessa di una comunità pubblica.
Nella lettera a D’Alema del 1° febbraio 1995 Carlo Casini chiedeva al leader post-comunista di riconoscere che esiste un “interesse pubblico alla tutela della società naturale che suppone la diversità sessuale, il matrimonio, la fedeltà”, ritenendo che un riconoscimento di tal fatta avrebbe potuto essere ampiamente condiviso da culture diverse. Venti anni dopo, è stata invece scelta la direzione diversa. Anzi opposta.
Le leggi 164/2014 e 55/2015 hanno stabilito che deve essere prioritariamente protetta piuttosto la volontà e l’autodeterminazione dell’uomo solo, negando responsabilità pubbliche e disincentivando legami stabili.
- Nel 2016, la legge 76 “Cirinnà” pretende una modifica ontologica della famiglia
La legge 20 maggio 2016 n. 76, c.d Legge Cirinnà, ha introdotto le unioni civili, ripetendo nella disciplina dell’art. 1, specie ai commi 11, 12 e 13, ampi tratti degli articoli propri del matrimonio contenuti nel Codice civile, quali, ex multis, l’art. 143 (diritti e doveri dei coniugi, ripreso al comma 11 della legge 76/16), l’art. 144 (indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia, parafrasato al comma 12 della “Cirinnà”) e l’art. 159 (del regime patrimoniale legale tra i coniugi, mutuato al comma 13 della stessa legge 76).
Da tale “emulazione familiare”, la legge 76 espunge però con precisione gli obblighi di fedeltà e di collaborazione, coessenziali invece all’art. 143 cod. civ., nonché i doveri verso i figli di cui agli art. 147 e 148 cod. civ. Dunque, con questa legge viene sostanzialmente equiparata a una “famiglia” (le c.d. “famiglie”) anche una “convivenza civile”, che, all’opposto del vincolo familiare proprio della tradizione, si caratterizza per la mancanza di un impegno a un rapporto tendenzialmente stabile e duraturo, che faccia assumere a ciascun contraente formali responsabilità nei confronti dell’altro e dei figli. Così, rispetto alla definizione di “famiglia” icasticamente scolpita da Carlo Casini nel 1995 nel passo citato al paragrafo precedente (diversità sessuale e apertura ai figli, stabilità nell’impegno matrimoniale, responsabilità verso gli altri componenti il nucleo e fedeltà) si compie una pubblica mistificazione culturale, equiparando all’istituto familiare forme di convivenza che ne sono strutturalmente differenti, benché ovviamente del tutto lecite.
Anche in questo caso il nuovo diritto libera dai legami, per proteggere “ciò che si vuole”, ovvero una autodeterminazione contrapposta alla responsabilità. Il nuovo istituto giuridico, inoltre, tutela la convivenza tra persone dello stesso sesso: in tal modo diviene un “modello familiare” un legame per sua natura non disponibile a “nuova vita”, oltre che precario e senza responsabilità verso il partner. Per il “nuovo diritto” il “bene” legislativamente scelto non solo rifugge dai legami e dal servizio all’altro, ma rifiuta di considerare un tratto essenziale, che la realtà oggettiva impone ai fini dell’inscindibile nesso fra famiglia e generatività quale è la diversità sessuale. Se la realtà non coincide con la proiezione dei desiderata soggettivi dei singoli, essa può essere negata con la voluntas legislatoris.
- Nel 2017, la legge 219 sul “biotestamento” (DAT) spezza il nesso fra “vita” e “dignità”, indirizzando il SSN verso la seconda
Si è già avuto modo di osservare come, attorno alle vicende italiane relative al “fine vita”, la questione antropologica si fosse posta in modo plastico già dal caso di Eluana Englaro attorno alla domanda: cos’è la dignità dell’uomo?. Nel 2006 la Corte d’Appello di Milano capiva la portata della scelta fra la “vita” in quanto tale e la “vita dignitosa”, ma ‒ come si è visto ‒ non dubitava che l’ordinamento attribuisse priorità e tutela alla prima.
Il 16 ottobre 2007 la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21748, riteneva invece che la autodeterminazione “presunta” del paziente dovesse essere “il” criterio dominante rispetto al bene della “vita” e che la ritenuta dignità del vivere non avesse connotati oggettivi, non rappresentando più un tratto di qualsiasi circostanza dell’esistenza. Con la legge 22 dicembre 2017, n. 219 ‒ approvata sotto la spinta massmediatica del caso di Fabiano Antoniani, il c.d. d.j. Fabo ‒ la frattura fra questi due concetti si radica definitivamente e si stabilisce che l’ordinamento e lo Stato sono funzionali alla “vita dignitosa”, non alla “vita” in sé stessa: a dieci anni dalla morte di Eluana Englaro la legge sul c.d. “biotestamento” (n. 219/17) ha dunque ribaltato il rapporto “vita/dignità” descritto dalla Corte d’Appello del 2006, sancendo legislativamente la mutazione del diritto alla vita nel ben più ridotto diritto a una “vita dignitosa”[26]. Per l’art. 1 di tale legge la “vita” e la “dignità” non coincidono più, non sono una medesima realtà. La dignità è piuttosto assimilata all’autodeterminazione.
Se il primo tratto della sottesa antropologia all’art. 1 della legge n. 219/2017 appare essere all’evidenza a matrice individualista, una seconda caratteristica dell’uomo protagonista della legge sul biotestamento è la sua “astrattezza”: il reale è tenuto lontano.
Nella disciplina delle DAT, cioè, la volontà della persona cui si dà prioritario rilievo si sgancia dalla realtà, emergendo, così, come si diceva, un modello di uomo astratto, avulso dalle circostanze storiche che attraversa giorno dopo giorno. Rileva in tal senso l’art. 4, che introduce le “disposizioni anticipate di trattamento”, secondo cui ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso le D.A.T., esprimere le proprie astratte convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Tali volontà sono sempre senza una “data di scadenza”, vengono fissate in un momento lontano dall’evento ipotizzato e varranno indefinitamente, anche a decenni di distanza.
L’altra cifra della legge n. 219/17 è l’immagine di un “uomo solo”. Il ruolo dei familiari è grandemente attenuato, come se l’evenienza di una malattia non fosse accompagnata naturalmente dal desiderio, per colui a cui succede, di una ampia condivisione con i propri cari. Similmente, nella relazione di cura i familiari, di cui al comma 2 dell’art. 1, sono un fattore eventuale. E rimangono eventuali anche nel momento difficilissimo, descritto all’art. 5, in cui il medico è obbligato a spiegare l’evolversi di una malattia. Pure la “compagnia” del medico è allontanata. Per il comma 6 dell’art. 1 il medico ora «è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo». In tali casi non può più curarlo. Anzi, solo se vi sarà questo rispetto (peraltro ordinato a volontà magari lontane nel tempo, o non chiare, o variamente interpretabili) egli sarà «esente da responsabilità civile o penale». Non gli è più consentito svolgere la sua vocazione: dialogare, consigliare, attendere, accompagnare chi soffre.
La persona, dunque, viene lasciata “sola”. Il legislatore del dicembre 2017 ‒antesignano di quello che avrebbe incardinato nel 2020 e nel 2021 le proposte di legge sulla c.d. “omofobia” e sul suicidio medicalmente assistito (cfr. infra) ‒ ha mutato il ruolo dello Stato e del Servizio Sanitario Nazionale di fronte a situazioni di sofferenza, di disabilità, di apparente inutilità delle persone. Decidere se il Servizio Sanitario vada finalizzato a una operosa cura anche di un malato cronico o di un disabile o, diversamente, possa rallentare o fermare la propria attività curativa a fronte di fragilità strutturali, significa scegliere la direzione stessa della sanità italiana.
Oggetto della tutela del SSN non appare più il diritto alla vita, bensì il non coincidente diritto a una vita dignitosa. Nel rapporto fra i richiamati principi di tutela della vita e della dignità prevale ora il secondo. Lo Stato ‒ come si diceva ‒ con la legge n. 219/2017 intende proteggere una vita dignitosa, non più la vita in quanto tale. Questo, dunque, lo strappo culturale e istituzionale introdotto con la normativa in commento: vita e dignità non coincidono più e la seconda prevale sulla prima, cosicché protagonista della “legalità” è diventato un uomo “a dignità variabile”, che può essere lasciato morire se è malato o se diviene poco utile rispetto ai canoni della mentalità dominante, secondo un modulo culturale efficacemente fotografato da Chantal Borgonovo, moglie di Stefano Borgonovo: «Non siamo più capaci di accettare la vita stessa che è fatta anche di cose difficili. La malattia fa parte della vita. Come la nascita e la morte. Noi allontaniamo tutto. È tutto rapportato al successo»[27].
- Nel 2018/2019, la Corte costituzionale ordina al Parlamento che disciplini la morte assistita
Nell’indifferenza dei più, il passo ulteriore è arrivato, puntuale, poco dopo. Sospinto, ancora una volta, dalla giurisprudenza, che ha consentito l’inserimento nel Servizio Sanitario Nazionale della procedura medicalizzata di aiuto al suicidio, completando quel percorso di morte avviato dal caso Eluana nel 2007 e dalla legge n. 219 sul biotestamento dieci anni dopo.
Ci si riferisce all’ordinanza della Corte costituzionale n. 207 dell’ottobre 2018[28], cui ha poi fatto seguito la sentenza n. 242 del 22 novembre 2019, riguardanti la conformità alla Costituzione della norma di cui all’art. 580 del cod. pen., che sanziona come reato l’aiuto al suicidio, entrambe pronunciate sulla eccezione sollevata dalla Corte di assise di Milano nel processo a carico dell’on. Marco Cappato sul già citato caso del dj Fabo. Con tale ordinanza, con modalità inedite, la Consulta “ordinava” al Parlamento di varare una legge sui temi della “procurata morte” entro il 24 settembre 2019.
In sostanza, la Corte costituzionale ha posto una questione diretta, deducendola in linea logica dalla legge sul c.d. “biotestamento”: se «la decisione di lasciarsi morire potrebbe essere già presa dal malato, sulla base della (…) recente legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento)» e se una simile «scelta innesca un processo di indebolimento delle funzioni organiche il cui esito – non necessariamente rapido – è la morte» per le «sofferenze provocate al paziente dal suo legittimo rifiuto di trattamenti di sostegno vitali», «in tal modo, si costringe il paziente a subire un processo più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care», cosicché «non vi [sarebbe] ragione» per non dare allora anche «accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale». Così, al § 10 dell’ordinanza in commento si pretendeva allora dal Parlamento: «una disciplina delle condizioni di attuazione della decisione di taluni pazienti di liberarsi delle proprie sofferenze … anche attraverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte, (…)»[29].
La filigrana dello “scarto” appare di tutta evidenza. La vita viene curata se “dignitosa” cioè performante. La sofferenza è un aspetto del reale rispetto al quale si oscurano, “per norma”, la speranza di un significato e la possibilità di un “farsi prossimo” che la accenda: all’ombra del moloch dell’autodeterminazione, gli ospedali devono poter “scartare” chi è nella fragilità. Appena pochi mesi dopo, come si vedrà ai paragrafi successivi, alla Camera inizierà il cammino di un disegno di legge per introdurre il suicidio medicalmente assistito: chi non è più “utile”, chi è malato, debole, va lasciato solo e “aiutato” ad andarsene.
- Nel 2020, la de-responsabilizzazione e la de-ospedalizzazione dell’aborto
Il Decreto AIFA 8 ottobre 2020 ha eliminato la prescrizione medica per le minorenni per assumere la pillola antinidatoria Ellaone, il cui conclamato effetto è anche di impedire all’ovulo fecondato di impiantarsi nell’endometrio[30]. Ora una quindicenne può andare da sola a prendere questa “pillola dei cinque giorni dopo”, e non saprà se ha davvero abortito o meno. Viene in buona sostanza del tutto eliminata la responsabilità di fronte alle proprie scelte.
La medesima logica di una simile non-antropologia nichilista emerge nel Decreto del Ministero della Sanità del 12 dicembre 2020, che ha privatizzato l’aborto farmacologico. La pillola RU 486 ora si può prendere, a certe condizioni, a casa: meglio, dunque, se la donna rifiuta il proprio figlio standosene fra le pareti domestiche. Come nella legge n. 219/2017 e secondo lo schema inserito nel disegno di legge sul suicidio medicalmente assistito, anche in questo caso il Servizio Sanitario si ritrae e non si prende più cura della donna che abortisce, né traspare alcun interesse per il bambino che non nascerà. La donna è lasciata sola, con il suo dramma, così nessuno lo vedrà e si potrà dimenticare più in fretta.
Il nuovo diritto compie, così, il passo più grave: eliminare una vita, togliendo ogni coscienza dell’impatto che questo gesto ha verso sé stessi e per la società. Eliminare una vita non è più percepito come un fatto che ha anche profili rilevanti per la prospettiva pubblica, secondo una seppur residuale sensibilità presente nella ospedalizzazione necessitata che la 194 prevede per ogni IVG. L’autodeterminazione si impone piuttosto come l’unico criterio ritenuto rilevante, che non deve trovare alcun ostacolo di fronte a sé. E il “nuovo diritto” è più propriamente il “diritto dello scarto”.
- Ancora nel 2020, la Camera approva il tentativo di imporre per legge l’ideologia gender
Contra omophobiam. “Contro l’omofobia” è stato lo slogan con cui pressoché tutti i media per mesi e mesi hanno enfatizzato il c.d. ddl Zan, approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre. Ma se solo si legge integralmente il testo arrivato al Senato (A.S. 2005), si scopre che il vero scopo di tale proposta normativa non è affatto l’omofobia: è piuttosto l’imposizione al popolo italiano della dottrina dell’«indifferenza sessuale» (gender) con l’arma della delazione di massa alle Procure penali per nuovi reati di opinione che soffocheranno la libertà di pensiero di tutti[31].
Il testo del ddl Zan, modificando l’art. 604 bis cod. pen., prevede, infatti, nuovi reati con condanne fino a un anno e mezzo di reclusione per chi «istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere» (art. 2 comma 1 lett. b). Ma se i comportamenti discriminatori ingiusti sono già penalmente perseguiti dall’ordinamento, che cosa potrà dunque essere questa nuova istigazione ad atti di discriminazione? Che confini avrà una simile norma che viene parametrata a nozioni totalmente soggettive come quelle inerenti al gender? Il reato avrà un perimetro totalmente indeterminato, del tutto interpretabile soggettivamente. Peggio: la istigazione alla discriminazione potrà essere ritenuta presente dopo un determinato fatto negativo per un soggetto, così scatenando facili processi alle intenzioni. Siamo esattamente di fronte alla persecuzione penale di chi non aderisce alla teoria gender dell’indifferenza sessuale e lo manifesta apertamente, perché, per ammissione degli stessi proponenti[32], tale diverso pensiero potrebbe essere percepito come istigatorio di discriminazioni verso chi pretende detta ideologia. La libertà di espressione è radicalmente minata. Vengono anche vietate, con pene fino a sei anni, la partecipazione o la gestione di associazioni o gruppi che abbiano fra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione per «motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere» (art. 2 comma 1 lett. c).
Sarà reato persino il partecipare ad associazioni o gruppi che abbiano fra i propri scopi un ritenuto e non meglio precisato «incitamento alla discriminazione» per «motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere» (art. 2 comma 1 lett. c). Ogni critica di merito su scopi associativi potrà condurre davanti al Giudice penale: per l’entità delle pene previste, i componenti di una associazione potranno essere preventivamente destinatari di intercettazioni telefoniche, e poi l’associazione potrà venire bloccata e i suoi membri mandati in Procura, così restringendo gravemente il diritto dei cittadini di “associarsi liberamente” voluto dell’art. 18 della Costituzione.
Non risultano precedenti, nella storia repubblicana, in cui il potere pubblico abbia voluto esplicitamente scegliere e indicare con la forza e gli effetti propri di un atto legislativo una fra le varie teorie filosofiche e antropologiche presenti nella società. Così invece avviene all’art. 1 dell’A.S. 2005, ove si indugia nel definire (lett. d), che «per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione».
La norma assume espressamente il pensiero c.d. gender o della «identificazione percepita del proprio sesso» (anche self-id), che propone una visione antropologica, secondo cui il soggettivo prevale totalmente sull’oggettivo e il dato reale non ha in sé stesso alcun valore, al punto da pervenire alla teoria dell’indifferenza sessuale. Il gender, in altri termini, è il pregnante terminale di quella ideologia secondo cui la realtà non ha consistenza obbiettiva, perché esisterebbe solo la volontà dell’uomo, autoreferenziale misura di tutte le cose. È una concezione, questa, che, negando la differenza nel reale, nega perciò la possibilità di una “sostanza” della realtà, e dunque sembra certamente appartenere a un campo di pensiero a matrice nichilista.
Attualmente, il gender è l’estrema frontiera di una concezione dell’uomo opposta alla visione religiosa. Se, cioè, il senso religioso ‒ scolpito nel d.n.a. umano e inestirpabile dal cuore dell’uomo ‒ ci dice che in ogni circostanza cerchiamo un Altro che ci salvi, il gender è invece l’epigono di una antropologia che afferma l’uomo a tal punto unica misura di sé e del reale da disconoscere anche il dato più eclatante quale la differenza sessuale. Detto altrimenti, la natura viene negata per negare la necessità di quell’Altro da sé di cui tutto il reale “parla” (e di cui la differenza sessuale è traccia oggettiva). «Oggi» ‒ ha riflettuto il Card. Pietro Parolin a ridosso del dibattito in parola ‒ «viviamo evidentemente in una società dove il riferimento al valore infinito della vita viene sempre meno», proprio perché viene meno il riferimento «anche a questa apertura al trascendente»[33]. L’ideologia che intende affermare il modello di individuo quali Prometeo o Capaneo[34], presumendo l’uomo unica misura autoreferenziale, non può dunque tollerare il linguaggio “religioso” del reale, che è una sinfonia in cui ogni cosa è breccia di una apertura al diverso da sé, come avviene persino fisicamente nell’interrelazione fra i due generi.
Sotto un ulteriore profilo, il ddl Zan divelle e sradica anche la struttura dello Stato. Se infatti il legislatore “sceglie” una specifica visione antropologica ed etica (cfr. art. 1 co. 1 lettere ‘c’ e ‘d’ A.S. 2005), allora esso mina alle radici la attuale natura di “Stato laico” della Repubblica italiana, infrangendo il nucleo essenziale dei “diritti inviolabili” di cui all’art. 2 della Costituzione, che non possono tollerare una imposizione sulle convinzioni esistenziali di ciascuna persona. Qualora lo Stato occupi quello spazio tipicamente “pre” o “meta” politico, ove alberga il diritto inviolabile del singolo di riflettere e scegliere, anche mutevolmente, il senso e il valore attribuibili alla propria esistenza, tali diritti saranno “violati”, e lo Stato non si atteggerà più in senso sempre rispettoso della sfera esistenziale di ciascuno, ma perderebbe, per l’appunto, il fondamentale carattere della laicità delle proprie istituzioni. Così facendo, cioè, il legislatore provoca una sorta di graduazione e di “gerarchia” delle convinzioni ideali ed esistenziali, assegnando a una sola di esse un primato, il che fa divenire necessariamente recessive le culture diverse.
Oltre all’introduzione addirittura di reati di opinione per chi affermasse una concezione della differenza sessuale diversa da quella gender, l’intento etico-rieducativo diviene inequivoco anche all’art. 5, ove si prevede che in caso di condanna anche solo per «istigazione alla discriminazione» (alias dissenso…) vi possano essere sanzioni accessorie quali una inspiegabile interdizione all’attività politica per tre anni, nonostante il favor alla partecipazione democratica dell’art. 49 Cost., nonché l’inedito obbligo di prestare servizio nelle stesse associazioni LGBT la cui filosofia non era stata condivisa.
Il medesimo tono “etico” che si vuole imprimere allo Stato nel diffondere e nell’educare la società all’ideologia nichilista “gender” connota altresì l’art. 7, che, attraverso l’introduzione della giornata nazionale dedicata alla stessa renderebbe obbligatorio, in ogni scuola di ogni ordine e grado, l’insegnamento di tale ideologia anche ai più piccoli e indifesi e ciò contro il parere dei genitori, che sono gli unici ad avere il “diritto” all’educazione dei figli, riconosciuto dall’art. 30 Cost.
Durante il dibattitto parlamentare, il Presidente emerito della Corte costituzionale, prof. Antonio Baldassarre, ha magistralmente sintetizzato questo grave effetto: «Affermare che la distinzione tra i sessi non è un dato naturale ma è un fatto culturale, significa esprimere una convinzione che tocca i valori morali e religiosi in cui credere: questa è una libertà fondamentale». Se le convinzioni che ritengono che esiste la distinzione tra sessi diventano passibili di incriminazione penale e quelle opposte, inerenti al gender, sono oggetto di indottrinamento nelle scuole, siamo certamente di fronte alla trasformazione della Repubblica italiano in uno Stato etico.
Lo Stato assume così un ruolo attivo nel condizionamento del Paese verso una specifica ideologia, eludendo palesemente «il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero» sancito dall’art. 21 Cost. L’esito liberticida di un “diritto” rifondato per imporre una ideologia appare innegabile.
- Nel 2021, per sentenza diviene possibile la “maternità surrogata” all’estero
Con la maternità surrogata la mercificazione del bambino e della donna sono macroscopicamente evidenti[35], al punto che è stata definita da alcuni autori un caso di «schiavitù contemporanea»[36]. In tal caso, l’autodeterminazione è portata a tal punto da eliminare il rispetto per altri esser umani se essi sono funzionali a dare soddisfazione da un “desiderio” del soggetto più forte. Le caratteristiche proprie della maternità, il legame oggettivo che si stabilisce fra la madre e il figlio, le esigenze oggettive del figlio non vengono riconosciute. In questa antropologia, la realtà non esiste. C’è solo la proiezione infinita del soggettivismo del più forte.
Per questo la maternità surrogata è condannata dal Parlamento Europeo con la risoluzione del 17 dicembre 2015, in quanto «compromette la dignità della donna, dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce», mentre secondo la Corte costituzionale «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane» (sentenza n. 272/ 2017, confermata dalla n. 33/2021). Ai sensi dell’art.12 comma 6 della L. 40 del 2004 in Italia la maternità surrogata è considerata un reato, punibile con la pena della reclusione da tre mesi a due anni e con pena pecuniaria da 600.000 a un milione di euro. La giurisprudenza ha ritenuto il contratto di maternità surrogata nullo, perché con oggetto illecito in quanto lesivo delle norme imperative e del principio di ordine pubblico, ovvero in quanto in frode alla normativa vigente in materia di adozione.
Ma lo scenario è da poco cambiato. La sentenza delle Sezioni Unite civili della Cassazione n. 9006/2021, depositata il 31 marzo 2021, rischia di aprire surrettiziamente la strada alla maternità surrogata, e più in generale alla compravendita della maternità, del corpo della donna e del neonato.
La motivazione formalmente ‒ e significativamente ‒ afferma il contrario, ma nella sostanza è evidente l’assenza di strumenti utili a contrastare questi delitti ovunque commessi. In particolare, le Sezioni Unite da un lato ritengono che, a determinate condizioni, vada trascritta all’anagrafe italiana l’adozione di un bimbo nato da maternità surrogata riconosciuta in un altro Stato, cosicché contro tale breccia normativa decine e decine di associazioni stanno chiedendo da mesi con urgenza l’intervento del Parlamento, affinché il c.d. “utero in affitto” sia previsto come reato internazionale.
Al netto delle larghe intenzioni dichiarate dalle rappresentanze parlamentari, l’iter dei due disegni di legge presentati a tale scopo prosegue con lentezza: e allo stato, questa frontiera estrema dell’individualismo ‒ col drammatico corollario di bambini scelti, all’estero, per catalogo e “donatrici” che prestano il loro corpo a pagamento ‒ è divenuta, purtroppo, reale anche in Italia.
- Ancora nel 2021, la Camera spinge il Paese nell’anticamera dell’eutanasia
Il 9 dicembre 2021 le Commissioni riunite II e XII della Camera hanno licenziato per l’Aula il testo c.d. Bazoli (AC 2 e altri), contenente “disposizioni di morte volontaria medicalmente assistita”. L’iniziativa viene rappresentata come necessario seguito alla sentenza n. 242/2019 C. cost., ma nulla formalmente impedisce di far seguire a tale sentenza una differente disciplina dell’art. 580 cod. pen. Non è tutto. Il testo proposto dalle Commissioni non è affatto la trasposizione in norma del pensiero della Consulta, ma ne dilata ulteriormente le già larghe maglie di essa, e comunque le supera ampiamente.
Si tratta di una proposta che ha in premessa la tutela della vita se “dignitosa”, poiché quando essa ha di fronte una malattia soggettivamente ritenuta insopportabile, si reputa che si debba lasciar spazio a una “autodeterminazione” solitaria e senza speranza[37] precettando il Servizio Sanitario Nazionale di procurare la morte. «Se il testo di legge trovasse accoglimento nelle aule parlamentari» – osserva Alberto Gambino[38] ‒ «si giungerebbe ad un vulnus costituzionale (…) Ne sarebbe conseguenza il ribaltamento della missione istituzionale del SSN che è rivolta «alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio (art. 1, legge 833/78). Le conseguenze sarebbero pesantissime sia in termini culturali che sociali. Un coinvolgimento delle strutture sanitarie – dove per definizione si cura e si somministrano terapie e non farmaci letali – aprirebbe a veri e propri protocolli e prassi mediche di enorme impatto sulla percezione collettiva del ruolo della sanità e ne finirebbero per fare le spese proprio i pazienti più soli e fragili che, avendo anche tale possibilità esiziale, comporrebbero il campione più ricettivo della nuova prospettiva eutanasica. Anche perché, in un’ottica cinica e inconfessabile ma drammaticamente realistica, libererebbero posti letto e risorse economiche».
Dal tenore del testo Bazoli, persino situazioni colpite da una assai diffusa “condizione clinica irreversibile”, come malati cronici o spastici o disabili, possono trovare un SSN disponibili ad ucciderli. Diventa dunque dominante la cultura dello scarto, perché, «al fondo del tema eutanasico si staglia la grande questione antropologica contemporanea e la crescente imposizione per legge di postulati nichilistici, sotto la patina dei luoghi comuni del politically correct. La vita, soprattutto nella fragilità che prima o poi ciascuno manifesta anzitutto a sé stesso, è deprivata di valore assoluto: “i limiti” che la realtà impone non vengono letti come “la possibilità di uno sviluppo umano e sociale più fecondo”, come emerge quando gli uomini hanno “cura per ciò che è debole”: il rifiuto dello sguardo sull’umano e sulla sua intrinseca limitatezza viene accompagnato dall’affermazione del dogma derivante dal “sogno prometeico di dominio sul mondo che ha provocato l’impressione che la cura” del reale e dei più fragili “sia cosa da deboli”[39]. L’uomo vale se permane nel cono di tale sogno, se performa e ha successo e non ha bisogno di essere aiutato e curato, cioè amato. Se al contrario non può più affermarsi sul reale, se addirittura dipende eccessivamente da altro da sé, la sua vita non è degna e un nuovo Stato etico si attiva per porre fine a essa. Come la legge n. 219/2017, anche il t.u. Bazoli e la prospettiva referendaria tesa a permettere l’omicidio del consenziente vanno colte in un tale contesto in senso lato culturale, le cui declinazioni giuridiche puntano a diventare esponenziali ripetitori sociali»[40].
- Il “cambio d’epoca” come privilegiata occasione di presenza, nell’unità
Di fronte a scenari tanto nuovi rispetto anche al recente passato, in cui la società ha perduto le certezze che apparivano scontate fino a pochi anni fa e in cui ogni legame con l’antropologia cristiana sembra improvvisamente perduto e remoto, mentre ne sopravanza una diversa usando soprattutto le leve normative, giudiziarie e legislative, lo schema di gioco dei cristiani sensibili a un impegno pubblico sembra non aver cambiato passo. Anzi, forse per una incosciente inerzia, da dieci anni e più assistiamo a ogni più vario tentativo per riproporre una qualche forma di presenza “nel secolo”, attraverso il solito modulo di ricostituzione di forme partitiche, sviluppando sforzi meramente organizzativi con pochissima attenzione ai contenuti. Il risultato è purtroppo una frammentazione che ha disperso il campo politico di micropartitini e sigle di ogni genere, capaci di raggranellare consensi che a poco servono se non a certificare l’irrilevanza.
In tale dispersione si è addirittura smarrito il significato principe di quella che, nel linguaggio, è rimasta la ritenuta nota comune di tutti i tentativi di riorganizzazione partitica, cioè quel considerarsi “moderati”, che ha finito per apparire come sinonimo di una sorta di atarassica indifferenza a contenuti valoriali. Se, invece, il concetto di “moderazione” fosse stato correttamente abbinato alla ritenuta necessità che la politica non debba usare il potere per imporre modelli esistenziali e antropologici alla società, come accadde e accade per i regimi totalitari o per attuare pretese etiche sulla vita dei singoli, i politici “cristiani” avrebbero almeno dovuto insorgere nei confronti di un utilizzo delle leve normative con il diretto proposito di modificare le convinzioni ideali presenti nel popolo. Ma di questa “insurrezione” si sono viste tracce assai scarne.
È difficile negare l’urgenza di un passo diverso nel concepire l’impegno pubblico dei cattolici, che non può continuare a replicare schemi in uso prima della caduta di ogni simulacro di una comune koiné sociale. Nella “precedente epoca” il perdurare esterno di una (apparente) condivisione diffusa di un giudizio sul valore della vita dell’uomo induceva molti a considerare l’organizzazione in forme-partito la sola strada per una presenza pubblica dei cristiani nella società italiana. Ma la rottura anche dell’ultimo velo antropologico socialmente diffuso, nonché il prepotente uso del potere e delle leve legislative e giuridiche per condizionare la società italiana verso una antropologia dello scarto, chiama a sfide nuove e impone la ricerca di un metodo adeguato al mutato assetto socio-politico.
Il fatto e l’incontro cristiano hanno bisogno di una persona che attenda il “centuplo quaggiù e la vita eterna”, mendicando una Compagnia che venga a salvarci. Se il nostro cuore arde per quella Presenza che si è chinata su di noi, può forse non addolorarci l’azione menzognera con cui, sempre più prepotentemente, viene negata la natura religiosa della nostra umanità? Orientare il popolo con la forza del potere legislativo verso una concezione di uomo che si assume misura onnipotente del reale significa voler sia mistificare la verità della natura umana, che è ontologicamente segnata dal senso religioso, sia, con ciò, aumentare gli ostacoli per l’incontro con il Divino.
In un siffatto contesto, i cattolici sono chiamati innanzitutto a un giudizio pubblico che spieghi e renda chiara la sfida antropologica che è stata lanciata nell’ultimo decennio anche attraverso le leve della politica, della legislazione e del diritto. In tal senso, la prima urgenza, per l’intera società italiana, appare proprio che si comprenda e qualcuno dica pubblicamente ‒ “sui tetti” come invita il Vangelo (Mt. 10,27) ‒ quale nuova idea di uomo sia contenuta e promossa attraverso continue e incalzanti riforme legislative e giurisprudenziali, anche al fine di impedire che questa massiccia operazione di utilizzo del potere per scopi ideologici avvenga inconsapevolmente, coperta dalla retorica di slogan spesso del tutto fuorvianti rispetto alla vera posta in gioco.
«Io credo» ‒ sono ancora le parole del Card Parolin ‒ «che i cristiani debbano insistere su quella che è la visione antropologica della fede, che viene dal Vangelo, che è condizione della salvaguardia della dignità di ogni persona, perché se noi difendiamo questi valori non è tanto per il gusto di difenderli in sé stessi, ma perché siamo convinti che siano condizione indispensabile per difendere, promuovere, tutelare e sviluppare la dignità concreta di ogni persona. Io insisto su questo: non la persona astratta, ma una persona concreta»[41].
Peraltro, un giudizio antropologico pubblico diviene ancor più impellente nel contesto della pandemia, che ha messo a nudo la falsità del finto mito dell’autodeterminazione. Infatti, il tentativo ‒ ancora una volta ‒ di nascondere la realtà con l’ottimismo della propaganda dell’andrà tutto bene ha lasciato presto il passo alla paura. «La circostanza inattesa della pandemia, che si sta prolungando più di ciò che immaginavamo, con tutte le sue pesanti conseguenze sanitarie, sociali, psicologiche e spirituali, mette allo scoperto la terribile fragilità di una certa visione dell’esistenza, tutta schiacciata sull’immediato, sul consumo, sull’accumulo di beni e il godimento di emozioni ed esperienze. È un momento in cui tornano a farsi largo le domande inestirpabili dell’uomo sul senso della vita e della morte, sul significato dell’umano soffrire, su ciò che veramente vale e ha consistenza: chi è leale con la propria esperienza, riconosce l’evidenza del limite che ci costituisce come esseri umani ‒ non siamo padroni della vita, né propria, né altrui ‒ e al tempo stesso la forza inesauribile di un desiderio di vita, di pienezza, di positività che nulla riesce a cancellare»[42].
Le parole del Vescovo di Pavia riecheggiano e confermano l’intuizione di Papa Francesco quando, all’inizio del contagio, accogliendo il dolore di tutta la terra schiacciata dalla pandemia da Covid19, ha avuto il coraggio di chiamare la storia e il mondo intero a prendere coscienza che gli standard divenuti mentalità dominante e dilagante non sono affatto gli unici possibili, ma dipendono da scelte precise sul senso dell’umano. Parlando, solo, dal sagrato vuoto di piazza San Pietro, sotto la pioggia del 27 marzo 2020 ‒ chi lo può dimenticare! ‒, collegato con un mondo mendicante di aiuto e di significato, le parole del Pontefice sono state una lama per ciascuno e per la società in quanto tale: «La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità. La tempesta pone allo scoperto tutti i propositi di “imballare” e dimenticare ciò che ha nutrito l’anima dei nostri popoli; tutti quei tentativi di anestetizzare con abitudini apparentemente “salvatrici”, incapaci di fare appello alle nostre radici e di evocare la memoria dei nostri anziani, privandoci così dell’immunità necessaria per far fronte all’avversità. Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri “ego” sempre preoccupati della propria immagine»[43].
Stiamo dunque vivendo un periodo storico che lascia intravvedere possibilità inaspettate per una ripartenza dell’umano. Come dimostrano le domande ultime che la pandemia sta acutizzando, il nichilismo dominante sembra offrire un paradosso, che lo supera. È uno spiraglio di speranza su cui invita a riflettere uno dei filosofi contemporanei più attenti come Costantino Esposito. Il pensatore barese da un lato ritiene che «nel nostro tempo il nichilismo sembra aver completamente vinto», ma dall’altro, con accenti davvero intriganti, invita ad osservare meglio la scena, sembrandogli che «proprio in questi ultimi anni il nichilismo fosse tornato ad essere una questione aperta, perché le domande che esso, grazie alla sua critica degli idoli, aveva dichiarato ormai impossibili ‒ come la domanda sul senso ultimo di sé e della realtà, sulla verità dell’io e della storia, sul nostro rapporto con l’infinito ecc.‒ tornano ad essere possibili, ragionevoli, brucianti». «Paradossalmente» ‒ prosegue ‒ «oggi il nichilismo non sembra più consistere ‒ come nella sua forma classica ‒ in una perdita di valori e di ideali, ma piuttosto nell’emergere di un bisogno irriducibile. Ci sono meno protezioni ideologiche: il bisogno è più nudo e quindi molto più impegnativo. Non ha più copertura: perciò il nichilismo del nostro tempo può essere paradossalmente una chance per la ricerca di un significato vero per la nostra esperienza nel mondo»[44].
Non è affatto una visione immaginifica l’intuizione di Esposito. Ma una lettura della realtà sociale acuta e adeguata, che fa sovvenire immediatamente alla memoria molti esempi dello stesso segno. Come quando, nel 2017, in quella clinica svizzera dove Fabiano (il “dj Fabo”) aveva scritto di aver scelto la morte perché la «vita non ha più senso» e non gli sembrava più degna, ma la sua compagna, qualche ora prima del suo “suicidio assistito”, aveva lanciato un tweet che ancora strappa l’anima, nel quale confessava di sperare che quell’ultima notte con Fabiano non passasse mai! Quanto è potente il grido di infinito, di compagnia eterna, perché anche quando lo si rifiuta riemerga prepotente, acuto, umano! Similmente, durante le votazioni della legge sul biotestamento alcuni cristiani hanno potuto offrire a tutti, anche ai tanti deputati che stavano per votare la breccia verso l’eutanasia, la speranza di quel bisogno irriducibile scorto dal filosofo Esposito, affermando dagli scranni di Montecitorio che «Il desiderio di significato, la domanda di verità, di bellezza, di giustizia che albergano e si accendono nel cuore di ogni uomo, anche e soprattutto nel dolore, sono il proprium dell’umano, ciò che lo rende grande, ciò che fa ritenere ugualmente “dignitosi” un sovrano e un mendicante, un olimpionico e un disabile»[45].
Ecco, dunque, una ulteriore ragione perché i cattolici cambino epoca nell’impegno pubblico. Il desiderio di capire per sé quale pretesa ridotta sulla concezione dell’essere umano venga sviluppata negli ultimi anni con un nuovo utilizzo delle decisioni politiche e della produzione normativa va, come raccomanda il Vangelo, portato sui tetti non solo perché tutti possano accorgersene, ma anche per riaccendere e incontrare quella misteriosa “irriducibilità” dell’umano che non viene mai meno e che sembra in questo tempo addirittura ridestata dal dramma della pandemia.
Forse proprio e soprattutto noi, che osiamo dirci “cattolici”, siamo chiamati a dire a noi stessi e a ogni uomo che è non più rinviabile ‒ specie nella prova della pandemia ‒ il momento del giudizio sull’antropologia. Nelle norme imposte dal politically correct, quale idea di “uomo” è inconsciamente contenuta e pubblicamente proposta o, meglio, imposta? Un uomo “sacro”, vocato al Mistero, al Destino, dunque assoluto e “sacro” in ogni suo istante, in ogni sua circostanza, anche e soprattutto se fragile, malata, fallita, debole, in crisi? O un “uomo” ridotto, a valore variabile, degno di attenzione solo se funzionale al sistema economico, performante secondo i parametri della mentalità dominante?
Ma quale delle due prospettive corrisponde di più al cuore di ognuno? Dobbiamo porre questa domanda a tutti, pubblicamente! Politicamente. Anche se siamo costretti a dire: “pre-politicamente”, perché non si fraintenda il termine “politica” come mera organizzazione del potere, cifra predominante della politica e, purtroppo, anche dei “centristi” degli ultimi decenni!
In qualche modo soprattutto i cattolici sembrano chiamati, nelle attuali circostanze, a illuminare la scena sociale, facendo vedere di quale portata sia la sfida per tutti. E per affrontare l’antropologia triste, tragica, pretesa dall’individualismo del “nuovo diritto dello scarto” non serve una “morale”. Men che meno un moralismo, ancora più grigio. Ma una bellezza umana, che commuove il cuore e dilata l’intelligenza. Quella bellezza che molti di noi possono vedere e incontrare in tanti luoghi in cui l’umano è sempre accolto con uno sguardo che corrisponde più pienamente all’umano. «Credo» ‒ osserva acutamente il Card. Parolin ‒ «che oggi ci sia molta necessità di essere capaci di infondere speranza, ma di farlo in una maniera abbastanza concreta, non soltanto con degli appelli generici alla speranza, che lasciano un po’ il tempo che trovano, ma dare piste concrete, operative, in cui si possano realizzare cammini e sentieri di speranza»[46].
Una simile sfida, di realizzare cammini di speranza, cui l’attualità sociopolitica ci chiama non può essere vissuta ciascuno per proprio conto. Non possiamo, infatti, non avvertire innanzitutto lo struggimento ut unum sint anche nella dimensione pubblica. Né possiamo peccare a tal punto di realismo da non riconoscere che solo una coralità, una “sinodalità” nell’indicare concretamente e motivatamente “dove” passi il tentativo di piegare la società italiana a una concezione dello scarto può attirare l’attenzione dei decisori e dei player culturali e politici italiani. E se i mille sforzi “partitico-organizzativi” si sono risolti in una ulteriore diaspora, possiamo forse cambiare passo soprattutto inventando e ricostruendo diversi luoghi pre-politici, in cui aiutarci a condividere primariamente un giudizio antropologico, illuminato nelle ragioni dalla fede, ragioni che sappiano ridire contenuti chiari, sappiano svelare e spiegare quale idea ridotta di uomo forgi tante norme e sentenze, per proporre di nuovo a noi stessi e a tutti quella “speranza” evocata dal Segretario di Stato di un uomo sempre sacro, sempre assoluto, e nella fragilità ugualmente “utile al mondo”, come annunciava Madre Teresa.
«Nelle attuali circostanze è assolutamente necessario che (…) sia rafforzata la forma di apostolato associata e organizzata, poiché solo la stretta unione delle forze è in grado di raggiungere pienamente tutte le finalità dell’apostolato odierno e di difenderne validamente i frutti. In questo campo è cosa particolarmente importante che l’apostolato incida anche sulla mentalità generale e sulle condizioni sociali di coloro ai quali si rivolge; altrimenti i laici saranno spesso impari a sostenere la pressione sia della pubblica opinione sia delle istituzioni» (Paolo VI, Apostolicam Actuositatem, 1965).
Paolo VI ha dunque profeticamente intuito uno spazio non ancora convintamente esplorato, quello di un laicato che, associandosi, “incida sulla mentalità generale” con la forza e la bellezza della ragione. Noi cristiani potremo essere “nel mondo” durante e dopo la pandemia, se ritroveremo gusto nel cercare fra noi una comunione nella fede, che sappia generare luoghi tentativamente unitari anche nel pre-politico per condividere giudizi, ragioni e intelligenza che si accorgano della pretesa di piegare la nostra speranza a un orizzonte antropologico ridotto e che sappiano dialogare con tutti sulla maggior ragionevolezza dello sguardo sull’umano che abbiamo incontrato nel fatto cristiano.
Si apre, allora, specie durante la pandemia, una dimensione inedita e di grande fascino che può riaccendere nella società italiana, pubblicamente, un dialogo con tutti, di matrice pre-politico perché autenticamente “politico” sulla grande questione antropologica che urge proprio “nella” politica. È una sfida cui si può rispondere – è bene insistere – solo assieme, tentando una unità fra i cattolici sul giudizio e sugli ideali, che non occorre avere fretta di mortificare in schemi organizzativi di un’epoca che non c’è più, nemmeno per noi.
Vi è una tensione in una parte del laicato cristiano, che desidera un lavoro condiviso e unitario di “ragioni” per giungere a cogliere, se possibile, la filigrana di quella antropologia dello scarto, che afferma Prometeo come modello, in questo modo potendo al tempo stesso anche riscoprire e ristupirsi di quella diversa possibilità di pensare l’uomo come Francesco d’Assisi, per cui, invece, ogni circostanza del reale ‒ felice o sofferente, forte o fragile ‒ ha un valore perché segno di un destino buono. È una sfida della “ragione”, in quanto tale desiderosa di un confronto senza confini! Certi che l’umanità svelata dalla fede in Gesù corrisponde maggiormente alle attese del cuore e della intelligenza di ogni uomo, che sempre domanda un senso per qualsiasi cosa incontri o accada. «Sotto l’azzurro fitto / del cielo qualche uccello di mare se ne va; / né sosta mai: perché tutte le immagini portano scritto: / “più in là”! (Maestrale, in Ossi di Seppia, 1925)». L’intuizione di Montale dimostra, dunque, la bontà della profezia di Paolo VI, perché la ragione illuminata dalla fede e la ragione propria di ogni uomo di fronte al reale coincidono e, proprio in questo tempo senza certezze pre-definite, possono ‒ forse più di prima ‒ parlare lo stesso linguaggio del cuore.
* Contributo sottoposto a valutazione.
[1] Papa Francesco, Incontro con i rappresentanti del V convegno nazionale della Chiesa italiana, Firenze, 10 novembre 2015.
[2] Benedetto XVI, Intervista a Il Foglio, 26 ottobre 2019.
[3] Papa Francesco, Udienza generale, Roma, 5 giugno 2013.
[4] Cfr. anche L. Di Mauro, Bioetica e famiglia. Dialogo D’Alema-Casini, in L’Unità, del 25 gennaio 1995.
[5] Sul significato antropologico dell’art. 2 della Costituzione, cfr., ex multis, I. Cacciavillani, L’articolo due. Partecipazione e solidarismo nella Costituzione, Padova, 2014.
[6] R. Ronza, Comunione e Liberazione. Intervista a Luigi Giussani, Milano, 1976.
[7] Benedetto Croce, Perché non possiamo non dirci cristiani, Bari, 1943.
[8] L. Di Mauro, cit.
[9] Tommaso d’Aquino, Somma teologica, I pars, q. 90, a. 4.
[10] Papa Francesco, Incontro con i rappresentanti del V convegno nazionale della Chiesa italiana, cit.
[11] Gualtiero card. Bassetti, Appello pubblicato sul quotidiano Avvenire, 30 maggio 2018.
[12] Cfr. J. Ries, L’uomo religioso e la sua esperienza del sacro. In Opera omnia, vol.III. Milano, 2007, p. 9.
[13] Papa Francesco, Lettera Enciclica “Laudato si’” sulla cura della casa comune, par. 10, Città del Vaticano, 2015.
[14] San Francesco d’Assisi, I Fioretti di Francesco, Torino, 1991, VIII.
[15] Papa Francesco, Lettera Enciclica “Laudato si’” cit., par. 119.
[16] M. de Cervantes, Don Chisciotte della Mancia, Milano, 2012.
[17] A. Simoncini, Intervista all’Osservatore Romano, 30 maggio 2019.
[18] S. Zamagni, Intervista all’Osservatore Romano, 22 maggio 2019.
[19] A. Mantovano, “Diritto” o “condanna” a morire per “vite inutili”? Aa.Vv., a cura del Comitato Polis Pro Persona, Siena, 2019.
[20] E. Fruganti, in Vite inutili?, cit.
[21] M. Camisasca, Vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, Intervista a LaVerità, 13 dicembre 2021.
[22] Papa Francesco, Lettera Enciclica “Laudato si’”, par. 122, cit.
[23] Cfr. nota 9.
[24] Cfr. nota 8.
[25] Cfr. nota 17.
[26] Cfr. per una riflessione ampia sulla legge n. 219/2017, Aa.Vv., a cura di P. Binetti, Servono ancora i cattolici in politica? Testimonianze del dibattito parlamentare sul valore della vita e sul testamento biologico”, Roma, 2018.
[27] C. Borgonovo, intervista al mensile Tracce, aprile 2017, p. 33.
[28] Cfr. per una riflessione sull’intervento della Corte costituzionale, Aa.Vv. (a cura di D. Menorello), “Diritto” o “condanna” a morire per vite inutili? – Il servizio sanitario verso la “cultura dello scarto” dopo l’ordinanza 207/18 della Corte costituzionale pro eutanasia, Siena, 2019.
[29] C. cost., ordinanza 24 ottobre 2018, n. 207.
[30] Cfr. Consiglio Superiore di Sanità, parere del 10 marzo 2015.
[31] Cfr. A. Mantovano, Legge omofobia perché non va. La proposta Zan esaminata articolo per articolo, Siena, 2021.
[32] A. Mantovano, Legge omofobia. Perché non va, cit. p. 31.
[33] Card. Pietro Parolin, Intervista a Vatican news, 28 novembre 2021.
[34] Capaneo (gr. Καπανεύς) era uno dei sette mitici eroi che mossero contro Tebe, figlio di Ipponoo e di Astinome (o Laodice); gigantesco e tracotante, sfidò Zeus, dal quale fu fulminato mentre cercava di scalare le mura di Tebe.
[35] Cfr. S. Baldassarre, Il mondo di sotto. Donne sfruttate e bambini venduti, s.i.p., 2021.
[36] G. La Rocca, La genitorialità omoaffettiva tra artt. 2 e 29 cost.: la Corte costituzionale sollecita il parlamento su questioni sensibili non solo eticamente, www.ilcaso.it, ottobre 2021.
[37] Per una ampia disamina del testo, A. Mantovano (a cura di), Eutanasia: le ragioni del NO, Siena, novembre 2021.
[38] A. Gambino, Ddl suicidio assistito: disattende le indicazioni della Consulta e può spingere i malati più fragili verso il baratro di scelte drammatiche, Agensir, 13 dicembre 2021.
[39] Papa Francesco, Laudato si’, cit., par. 116.
[40] A. Mantovano, idem, p. 20.
[41] Card. Pietro Parolin, cit.
[42] C. Sanguinetti, Vescovo di Pavia, Omelia nella solennità del Santo Patrono, 9 dicembre 2021.
[43] Papa Francesco, Momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia, Piazza San Pietro, 27 marzo 2020.
[44] C. Esposito, Il nichilismo del nostro tempo. Una cronaca, Roma, 2021.
[45] In Aa.Vv., (a cura di P. Binetti), Servono ancora i cattolici in politica?, cit.
[46] Card. Pietro Parolin, cit.