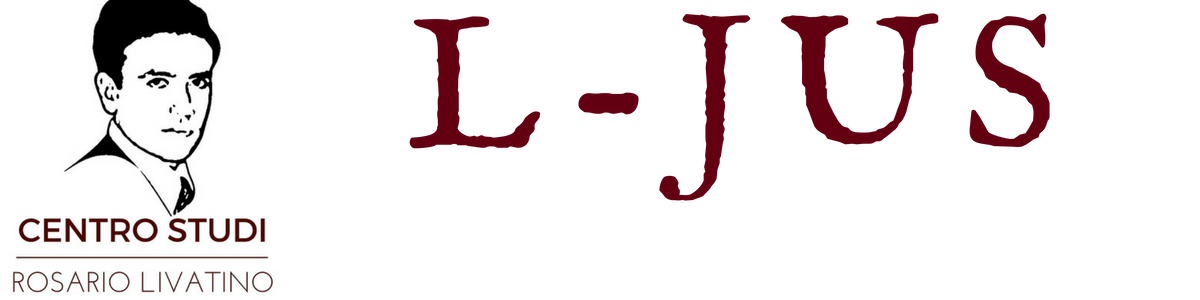Antonio Casciano
Dottore di ricerca in Etica e Filosofia politico-giuridica
Università degli Studi di Salerno
Sommario: 1. La coscienza nella cultura giuridica contemporanea ‒ 2. Tre concezioni della coscienza a confronto ‒ 2.1. La coscienza e i suoi dati im-mediati: Henri Bergson ‒ 2.2. La coscienza come via alla vita eterna: Jaques Maritain ‒ 2.3. La coscienza e il senso ultimo dell’esistenza: Marta Nussbaum ‒ 3. Coscienza e verità morali ‒ 4. La coscienza nella modernità ‒ 5. Coscienza ed ermeneutica dell’oggettività ‒ 6. Coscienza dell’umana condizione di co-esistenzialità e realismo giuridico.
- La coscienza nella cultura giuridica contemporanea
Nella riflessione che segue non sarà proposta alcuna disamina delle differenti modalità attraverso le quali gli ordinamenti giuridici hanno, nel tempo e nello spazio, positivizzato il cosiddetto principio di laicità. Ci si limiterà soltanto a osservare come la nuova sensibilità culturale e giuridica degli organismi nazionali e internazionali all’indomani della Seconda Guerra mondiale, puntando a realizzare una tutela immediatamente azionabile della dimensione individuale dei diritti, assunse, quale obiettivo precipuo dell’incipiente fase neo-costituzionale, la positivizzazione puntuale delle libertà fondamentali del singolo, sempre più univocamente ancorate al principio pre-giuridico del riconoscimento della dignità inerente della persona umana[1] e pensate come sostanziali invarianti degli ordinamenti costituzionali moderni. Questo ha progressivamente condotto, fra l’altro, alla definizione del diritto alla libertà religiosa come di un diritto riconosciuto all’individuo in quanto tale, senza diretto legame con la sua appartenenza all’una o all’altra confessione o comunità religiosa, immediata estensione concettuale e logico-fattuale della sua più ampia libertà in tema coscienza.
L’univoca ed incontestata realtà di questo dato preliminare consente di volgere l’attenzione alla descrizione della tesi che in questa sede si vuole dimostrare, quella cioè relativa al diffuso stato di incertezza, imbarazzo, disagio, quasi, che la cultura giuridica contemporanea vive e subisce al cospetto della nozione stessa di coscienza, per una serie complessa e articolata di concause che si vorrebbe in questa sede isolare ed esaminare. Il nodo gordiano da cui muovere lo sguardo, in vista della possibile disamina eidetica di una simile eziologia, risiede nella definizione stessa della nozione di laicità, qui concepita come quello spazio fondamentale di libertà che gli ordinamenti giuridici riconoscono ai consociati in ordine a quelle verità – morali, religiose, antropologiche – da essi credute e professate in coscienza. Questa definizione della nozione di laicità offre in nuce la triade concettuale a partire dalla quale sviluppare le riflessioni che seguiranno, ovvero: coscienza, verità e diritto. Come intendere queste unità semantiche fondamentali e quale relazione immaginare tra esse?
Iniziando proprio dalla nozione di coscienza, fa d’uopo domandarsi cosa sia la coscienza dell’uomo, e come essa vada esattamente intesa? Per rispondere a questa domanda, si prenderanno in considerazione le teorizzazioni offerte sul punto da tre grandi pensatori, ovvero, nell’ordine, da un convertito, da un credente e da un ateo, affinché la messa a punto di una possibile nozione di coscienza non appaia come direttamente dettata dall’adesione ai postulati morali di chi scrive, sia egli stesso un convertito, un credente o un ateo.
- Tre concezioni della coscienza a confronto
2.1. La coscienza e i suoi dati im-mediati: Henri Bergson
Henri Bergson, nei suoi Saggi sui dati immediati della coscienza[2], muoveva dal teorizzare l’irriducibilità tra dimensione qualitativa e quantitativa, tra vita interiore e vita esteriore dell’essere umano. Ciò che è esterno – e che propriamente costituisce oggetto della conoscenza scientifica – si distingue per differenze quantitative appunto. Lo spazio fisico che noi abitiamo, cioè, attua, realizza, rende possibile, l’estensione degli oggetti e dunque l’esternità di ciascuno di essi rispetto a ogni altro. Gli stati che invece esistono all’interno della coscienza – pensieri, percezioni, intuizioni –, pur essendo molteplici e singolarmente irripetibili, non sono esterni in questo medesimo senso. Ciò che infatti permette e attua la molteplicità dei vissuti della coscienza, in assenza di una esternità squisitamente spaziale, è il tempo: non quello fisico però, oggetto delle misurazioni empiriche operate nell’ambito della scienza sperimentale, bensì un tempo inteso come durata.
Ciò consente d’intendere gli stati susseguentesi della coscienza come qualitativamente distinti, diversi, differenti: «Quando seguo con gli occhi sul quadrante di un orologio il movimento della lancetta che corrisponde alle oscillazioni del pendolo, non misuro la durata, come potrebbe sembrare; mi limito a contare delle simultaneità, cosa molto diversa. Al di fuori di me, nello spazio, vi è un’unica posizione della lancetta e del pendolo, in quanto non resta nulla delle posizioni passate. Dentro di me, si svolge un processo di organizzazione o di mutua compenetrazione dei fatti di coscienza, che costituisce la vera durata. Mi rappresento ciò che io chiamo le oscillazioni passate del pendolo, nello stesso tempo in cui percepisco l’oscillazione attuale, proprio perché io duro in questo modo»[3].
In tale concezione del tempo, inteso come durata, Bergson pensa e iscrive la libertà dell’uomo. Mentre infatti i deterministi tendono, secondo Bergson, semplicemente a dire che, una volta che un uomo ha compiuto una scelta, lo ha fatto obbedendo a una serie di circostante che contingentano e limitano fattualmente il suo agire, e dunque che in fondo si tratterebbe solo di capire cosa e non chi ha determinato quella scelta, chi invece crede nell’esistenza del libero arbitrio tende a sottolineare quello stato di indecisione, incertezza, esitazione che connotano abitualmente l’agire dell’uomo prima che questi decida. Ciò proverebbe in maniera univoca come prima di scegliere l’individuo non abbia effettivamente ancora scelto: la libertà non è dunque altro che spontaneità.
Nella coscienza individuale, cioè, non esiste nulla di identico o di identicamente riproducibile e nulla di prevedibile, giacché tutto nascerebbe dall’esercizio effettivo, sovrano, imperscrutabile di una libertà, di una spontaneità singolarmente agita che declina l’operatività pratica del principio del libero arbitrio. Questa è la concezione della coscienza come luogo di fenomeni intuibili, pensabili, percepibili, ma non descrivibili, sperimentabili, riproducibili fattualmente, perché parti di un flusso vitale che anima singolarissimamente l’interiorità di ogni uomo.
2.2. La coscienza come via alla vita eterna: Jaques Maritain
Jaques Maritain, che fu allievo di Bergson, in un saggio intitolato I diritti dell’uomo e la legge naturale[4], faceva invece notare come la passività inerte della materia che esiste fuori di noi e abita lo spazio fisico in cui noi stessi esistiamo e l’usura che il tempo inesorabilmente esercita su di essa, siano condizioni di esistenza delle esternità oggettuali, le quali degradano le cose di questo mondo. Eppure, a fronte di tali inesorabilità, le forze creatrici, che sono proprie dello spirito/coscienza, oltre che della libertà degli esseri umani, elevano sempre di più la qualità delle energie degli stessi, e queste elevazioni vitali, di cui sono prove tangibili i perfezionamenti della tecnica, sono per loro natura “strumento dello spirito” e innervano i dinamismi di ciò che chiamiamo progresso. Questo genere di dinamismi, tuttavia presuppone la predisposizione strutturale di una serie di condizioni “esterne” al singolo individuo che rendono possibile un agire morale autenticamente libero perché obbediente ai dettami di una coscienza rettamente in-formata. Tali sono le condizioni scelte, poste e garantite dall’ordinamento giuridico.
Riferendosi ai diritti della persona umana come tale, Maritain enumera alcuni diritti fondamentali tra cui il diritto all’esistenza, alla libertà personale, al perseguimento della perfezione della vita umana razionale e morale e aggiunge, per quanto riguarda la libertà religiosa, trattarsi del diritto al perseguimento della vita eterna secondo la via che la coscienza ha riconosciuta come la via tracciata da Dio direttamente. Nell’illustrare in maniera particolareggiata i contenuti di tale diritto, osservava come il primo «di questi diritti della persona umana è quello di andare verso il destino eterno nella strada che la sua coscienza ha riconosciuto come la strada tracciata da Dio. Di fronte a Dio e alla sua verità, essa non ha diritto di scegliere a suo gradimento una qualsiasi strada; deve scegliere il vero cammino per quanto sia in suo potere di conoscerlo. Ma di fronte allo Stato, alla comunità temporale e al potere temporale, essa è libera di scegliere la sua vita religiosa a suo rischio e pericolo; la sua libertà di coscienza è un diritto naturale inalienabile»[5]. Dunque, la persona umana, in ragione della sua dignità, trascende la società e la stessa istituzione statuale, la cui legge positiva può obbligare se e soltanto se intrinsecamente giusta e se al contempo promana da una autorità legittima.
Per conciliare il diritto positivo, nell’oggettività delle sue formulazioni esterne, sia nazionali che internazionali, con la libertà di coscienza nella sua soggettività personale, occorre fugare, secondo Maritain, i due errori, uguali ed opposti, dell’assolutismo e del relativismo: «Da una parte l’errore degli assolutisti, che vogliono imporre la verità con la costrizione, deriva da fatto che essi trasferiscono dall’oggetto al soggetto i sentimenti che provano a buon diritto nei confronti dell’oggetto; essi pensano che, come l’errore non ha per sé diritti di sorta e deve essere bandito dallo spirito (con i mezzi dello spirito), così l’uomo quando è in errore non gode di diritti propri e deve essere bandito dal consorzio degli uomini (con i mezzi del potere umano). Dall’altra parte l’errore dei teorici che fanno del relativismo, dell’ignoranza e del dubbio, la condizione necessaria per la reciproca tolleranza deriva da fatto che essi trasferiscono dal soggetto all’oggetto i sentimenti che provano a buon diritto nei confronti del soggetto – che deve essere rispettato anche quando è in errore – e così privano l’uomo e l’intelletto umano di quell’atto, l’adesione alla verità, nel quale consistono ad un tempo la dignità dell’uomo e la sua ragione di vivere»[6]. Non il dubbio iperbolico, radicale, sistematico, di cartesiana memoria, ma il giogo della verità rende gli uomini disponibili all’ascolto e all’accoglienza reciproca.
La democrazia dovrebbe dunque fondarsi non sul relativismo e sulla negazione della verità, ma sulla comprensione reciproca, su di una convinzione pratica comune riconosciuta come vera. Questa è la concezione della coscienza come sede in cui abita ed opera una verità che trascende l’essere umano e che tuttavia questi può conoscere per mezzo dell’esercizio della ragione naturale e così conformarvisi.
2.3. La coscienza e il senso ultimo dell’esistenza: Marta Nussbaum
Marta Nussbaum, infine, assumeva un concetto di coscienza intesa come «facoltà per mezzo della quale ciascuno è in grado di ricercare il senso ultimo dell’esistenza». Tradotto in altri termini, si tratterebbe della capacità interna della ragione pratica, la quale rappresenterebbe di per sé «un intrinseco valore, indipendentemente dal fatto che le persone ne facciano un buono o cattivo utilizzo»[7]. Questa facoltà si identificherebbe in parte con le stesse modalità di estrinsecazione sue proprie (giudizio, ragionamento, ricerca e esperienza emozionale), in parte con l’oggetto verso essa cui essa tende, ovvero verosimilmente con questioni concernenti il senso ultimo della vita. Descrivendo in tal modo questa facoltà, veniva posto l’accento sul fatto che è la stessa possibilità di esercizio di tale facoltà, e non l’eventuale rilievo epistemico del suo possibile oggetto, a dover rappresentare oggetto di specifica tutela giuridica. Questa è la nozione di coscienza intesa come capacità di ricercare – poco importa cosa –, capacità che ha di per sé una pregnanza assiologica e deontica indipendente dall’oggetto della ricerca stessa, e che delimita congruamente l’ambito di operatività del potere normativo statuale, così da garantire il rispetto della piena eguaglianza di ciascun essere in quanto umano.
Mettendo insieme questi tre concezioni della coscienza, quella che ne fa la sede di fenomeni puramente qualitativi e dunque non quantificabili, calcolabili, misurabili con gli strumenti della scienza; quella che ne fa lo strumento cardine del riconoscimento della dignità personale dell’essere umano; quella, infine che rinvia al suo essere un atto puro di intenzionalità noetica e semantica valido di per sé, si ottiene la cifra, rispettivamente, dell’irriducibilità oggettiva, dell’infungibilità soggettiva, dell’inconculcabilità operativa, in una parola, della dignità eminentemente personale della coscienza individuale, in uno con le ragioni che fondano la necessità di una sua tutela in sede giuridica.
- Coscienza e verità morali
Le idee di coscienza, generate dagli apporti storici della ricerca filosofica, psicologica, scientifica, sono ovviamente innumerevoli, motivo per il quale non si tenterà in questa sede alcuna elencazione che abbia pretesa di esaustività. Dovrebbe tuttavia essere chiaro come solo riconoscendo la coscienza come sede della libera azione e determinazione morale dell’uomo, si può avere contezza dell’importanza che tale nozione riveste anche agli occhi del diritto, assurgendo anzi, proprio in questo specifico ambito, a presupposto ineludibile per l’esercizio di una serie di libertà ulteriori, parimenti fondamentali, quali, a titolo esemplificativo, la libertà di pensiero, di critica, di parola, di associazione, di voto; nessuna di queste libertà sarebbe infatti possibile o pensabile, né alcuna azione morale, frutto dell’esercizio personale e diretto di tali libertà, perseguibile, in assenza di una coscienza veramente libera e dunque in ultima analisi imputabile. La coscienza è la sede in cui albergano le verità ultime cui fanno appello l’intelletto e la volontà di ciascun agente morale che sia in grado di determinarsi liberamente all’azione.
Tante verità morali, dunque, quante sono le coscienze dei singoli? Parrebbe di sì e questo, peraltro, fonderebbe in nuce l’esigenza di laicità, di a-confessionalità, la condizione stessa di pre-moralità presupposta in ordine al moderno Stato di diritto. Eppure altro va ancora precisato, e si cercherà di farlo attingendo al pensiero di un autore da molti considerato pre-moderno, se non addirittura anti-moderno, come Tommaso d’Aquino. Proprio questi, infatti, con accenti sorprendentemente moderni, si spinse nella Summa a parlare delle molte verità che abitano il cuore dell’uomo: «Se, dunque, parliamo della verità in quanto, secondo la propria nozione, è nell’intelletto, allora, dato che esistono molte intelligenze create, vi saranno anche molte verità; e anche in un solo e medesimo intelletto vi possono essere più verità, data la pluralità degli oggetti conosciuti»[8]. In questo passo, parlando delle molte verità dell’intelletto umano, Tommaso non intende riferirsi alla verità in sé o alla verità delle cose così come sono in sé stesse, ma alle verità così come sono appunto nell’intelletto degli uomini, le quali, in quanto storiche, sono necessariamente figlie del tempo, dunque non perenni.
Qualsiasi conoscenza umana, dunque, in sé stessa considerata, sarebbe pur sempre vera, ma di una verità rigorosamente soggettiva. Perché vi sia verità oggettiva occorre, secondo Tommaso, che l’intelletto si lasci misurare dalle cose, e ciò perché ogni uomo è obbligato in coscienza ad accertarsi che le proprie verità soggettive abbiano anche un fondamento di validità oggettiva[9]. Per far ciò, l’uomo deve uscire dal proprio intelletto e confrontarsi con i suoi simili e con le cose, non cercando la verità in sé stesso, secondo la tradizione filosofica socratico-platonica del “Conosci te stesso”, ma fuori di sé, a partire dalle cose appunto. E le cose non sono una materia amorfa, alla quale egli, come il demiurgo platonico, sarebbe libero di imprimere una forma concepita nella sua mente. La forma è già nelle cose che gli si offrono allo sguardo, le quali sono quello che sono indipendentemente dal fatto che l’uomo le pensi o le conosca. Esse osservano infatti determinate leggi, secondo una razionalità intrinseca alla loro stessa natura, che progressivamente penetra, per mezzo dell’osservazione, l’intelletto dell’uomo, il quale, dunque, lungi dall’essere misura delle cose, dalle cose al contrario finisce per farsi misurare[10].
- La coscienza nella modernità
Nella filosofia moderna, invece, a cominciare da Cartesio, si è sostenuta la tesi opposta, quella fatta propria due millenni prima da Protagora: l’intelletto dell’uomo è misura di tutte le cose; Kant dirà che l’intelletto dell’uomo è legislatore su tutte le cose[11]. L’intelletto speculativo teorizzato dalla modernità è in realtà un intelletto che dà alle cose le forme autonomamente concepite dentro di sé, proprio come l’artista dà forma a ciò che personalmente produce. In questo suo gesto, però, egli non è più limitato né misurato da alcunché. Dal suo pensiero dipende e l’essere delle cose e i modi di essere delle cose. Il suo pensiero è onnipotente, è legge alle cose, le quali saranno nel loro essere e nei loro modi così come l’uomo ha deciso che siano nel suo pensiero. L’uomo, che col dubbio iperbolico ha perso l’essere delle cose, deve necessariamente rimettersi a rifare o, meglio a ricreare il mondo. Ed è così che egli si crea il suo mondo, come Dio, e sul quale governerà come re assoluto, sciolto da qualsiasi vincolo metafisico e morale. Perciò egli non ha nessun dovere verso nessun altro essere, dovendo obbedire ai comandamenti di una coscienza che ha sé stessa come suo unico riferimento ed orientamento[12].
L’uomo moderno, l’uomo del cogito ha preteso fondare la sua morale sulla propria ragione ed è quanto ha fatto Kant nella Critica della Ragion pratica, cercando in sé i fondamenti di quella morale, che, non provenendo più dall’essere delle cose, finiva necessariamente col trasformarsi in una morale autonoma. E invece, «il filosofo dell’essere non dice mai: “La verità delle cose sta solo dentro di me”. Dice invece: “La verità delle cose sta prima nelle cose, dopo che le ho conosciute sta anche dentro di me”. E poiché avverte di essere un essere fra tanti esseri, egli al tempo stesso si accorge che la verità non sta soltanto in lui. Non è l’unico a possedere la verità, perché la verità sta ovunque c’è essere attualmente esistente o che è stato attualmente esistente in altri tempi»[13], o che è stato esistente in altri tempi.
Dalla verità così definita deriva anche lo statuto della morale, la quale, poiché proviene al soggetto dall’essere, è per definizione eteronoma. Perciò l’attributo dell’eteronomia, che riconosciamo alla morale, è un attributo così essenziale che una morale non eteronoma non è più morale. Eppure, oggi viviamo nell’epoca del relativismo morale, nel quale ogni coscienza pretende di essere norma a sé stessa, svincolata da ogni normatività eteronoma che trovi fuori di sé, nella natura, un vincolo teleologico di obbligatorietà che sia uno ed uguale per tutti. In particolare, è proprio la nozione onto-antropologica di “natura umana”[14] ad essere principale oggetto di attacco nel tentativo di de-costruzione dell’anthropos in atto. Da spirito incarnato teso al trascendente, l’uomo diviene tabula rasa, senza più un orizzonte di senso escatologico[15], sganciato dal rapporto col divino, ma anche dal limite e dalla precarietà che lo caratterizza. Ciò genera un ripiegamento narcisistico e autoreferenziale dell’individuo su se stesso[16]. Si tratta di un “antropo-decentrismo” che, al fine di scostare la persona dal privilegio ontologico che le pertiene, si presta ora al “superamento dell’incarnazione”, a favore di una nuova identità liquida, nomade, interspecifica, ibrida.
Ebbene, dal momento che i diritti umani, tutti, indistintamente, sono stati detti inerenti, nel Preambolo alla Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, a ciò che l’uomo è, ovvero alla sua condizione ontologica, così definendo un ordine morale e un ordine naturale che sono pre-politici e pre-giuridici, nel momento in cui la verità sull’uomo viene negata dalla coscienza ormai post-umana e post-umanista, la stessa distinzione identitaria di bene e male, in uno con il senso di giustizia che l’uomo è chiamato a scovare tramite l’esercizio della ragione, in armonia con la legge morale naturale, viene posta in discussione. In altre parole, negando la verità sull’uomo, ovvero affermando che non sussiste alcuna “natura data”, l’intero complesso dei diritti umani cade in un cortocircuito insostenibile in cui i beni fondamentali tutelati arrivano a scontrarsi con la prassi[17]. Il diritto post-moderno, insomma, distrutto ogni fondamento metafisico e staccato quindi da ogni fondamento di legittimazione superiore, sta diventando sempre più la tecno-normazione di un percorso di autopoiesi dell’uomo secondo criteri immanenti alla sua volontà di potenza[18], che porterà inesorabilmente a scenari di prevaricazione sempre possibile, al rischio sempre reale homo homini lupus di hobbesiana memoria.
- Coscienza ed ermeneutica dell’oggettività
Come arrestare questo processo di autarchia/anarchia nomopoietica della coscienza post-moderna? Occorre tornare ad un sano realismo conoscitivo, presupposto indispensabile del realismo giuridico, ad una rinnovata concezione onto-normativa della datità naturale. Ammettere un’ontologia della natura, come sostrato teleologico orientante normativamente l’agire umano, non è negare la libertà della coscienza, dacché la morale naturale non contraddice la libera determinazione del singolo, essendo piuttosto la pre-condizione necessaria – ecco il dovere etico – al suo pieno dispiegamento. Infatti obbedendo all’orientamento naturale verso il bene, iscritto nella coscienza di ognuno, l’uomo non sottomette la sua volontà all’arbitrio di un terzo, ma alla legge promulgata dalla sua stessa ragione e dunque, in ultima analisi, a ciò che più intimamente ed autenticamente lo qualifica come uomo.
Una corretta concezione filosofica della persona e della libertà della sua coscienza è dunque la chiave per impostare qualunque problematica di epistemologia della scienza giuridica. Non è un caso che per il Dottore Angelico la natura umana fosse l’essenza stessa in quanto principio di operazioni, e che ordine e finalità nella natura tendessero a unificarsi nella nozione di persona umana: «La persona umana è primitiva; non si deduce da nulla e non si può ridurre a nulla. (…) Non solo la tecnica non può trasformare o alterare l’essenza della natura umana, ma neanche può ri-produrla artificialmente: non può produrre la persona. (…). La tecnica trova nella persona umana e nella natura umana non solo l’eternamente non-trasformabile (…), ma anche l’indisponibile moralmente (…). Ora, l’area dell’indisponibilità morale è più ampia di quella dell’impossibilità ontologica a trasformare [propria della tecnica], e ciò in base a una visione dignitaria, egualitaria e non utilitaristica»[19], o funzionalisitica, ma appunto sostanziale della persona.
E tuttavia una disamina esaustiva della nozione di persona, impone un riferimento al carattere non solo sostanziale, ma anche relazionale della stessa. La persona è per sua natura in relazione con l’essere: «Conviene dire dunque che il nome persona non significa né meramente una sostanza, né meramente una relazione, ma una relazione sostanziale, cioè una relazione che si trova nell’intrinseco ordine dell’essere di una sostanza»[20]. Dunque se la prospettiva ontologica ha lasciato emergere lo statuto essenziale dell’essere personale, uno sguardo fenomenologico sull’esserci dell’essere, sulla declinazione esistenziale dell’ente, rivela una sua “seconda” natura, che gli è propria al pari della prima, e che esattamente come quella lo qualifica identitariamente: si tratta appunto della natura relazionale della persona.
Tale operazione di riduzione fenomenologica, di husserliana memoria, operata a partire dalle “condizioni esistenzialmente proprie dell’uomo”, sembra dunque aver svelato due dati essenziali: 1) la sua strutturale difettività, che lo spinge ad un agire ininterrotto all’interno dello spazio-ambiente che abita, ponendolo in relazione con i suoi simili; 2) la constatazione di un con-esserci nel mondo, la presa di coscienza cioè della necessaria condivisione degli ambienti vitali con soggetti aventi la medesima natura, i medesimi bisogni, la medesima dignità.
- Coscienza dell’umana condizione di co-esistenzialità e realismo giuridico
La compresenza di pretese tutte soggettivamente vere e legittime, pone il soggetto dinanzi ad un bivio: fermarsi alla pura constatazione di un simile stato di cose e lasciare che le dinamiche intersoggettive siano disciplinate in ultima analisi dalla legge del più forte; oppure ricercare forme per una possibile coesistenza di tali pretese, muovendo da una dimensione veritativa che funga da criterio guida[21]. Le condizioni di com-presenza reclamano l’adesione a modelli di condotta che rispondano ad un “dover essere”, o meglio ad un “dover di essere”, il dovere di uniformare le esistenze dei singoli alla verità dell’essere dell’uomo, che “esige da” e nel contempo è “tenuto a”. E in questa struttura ontologico-relazionale dell’umano già si scorge e si comprende il senso e il fondamento tanto della eticità, come della giuridicità: la normatività appare cioè iscritta nella “ontologica co-esistenzialità relazionale” dell’essere umano che, aprendosi dapprima all’alterità giunge ad una auto-comprensione riflessiva del sé e, poi, trascendendo la propria onticità fattuale e concependo la propria esistenza come com-possibilità, accetta la normatività come condizione di esercizio eteronomo della libertà[22].
Il criterio dunque unico per giustificare la legittimità di ogni legge è data dal suo essere strutturalmente funzionale alla co-essenza, co-esistenza, co-interessenza degli esseri umani: vanno obbedite quelle leggi che garantiscono una relazionalità universalmente obbligante. Disobbedire ad un precetto così strutturalmente e funzionalmente orientato, significa in ultima analisi negare la com-possibilità co-esistenziale che è condizione del sussistere della umanità stessa.
Fare di tale funzionalizzazione il criterio per la giustificabilità, sul piano legislativo, di ogni precetto normativo significa reinterpretare in chiave essenzialmente dinamica il giusnaturalismo, adeguandolo alla complessità delle odierne società del pluralismo, etico e religioso, ed operando, a partire da esse, la difficile conciliazione politico-giuridica tra la stabilità onto-normativa della natura ed i mutevoli assetti sociali in cui si svolge la co-esistenzialità dell’uomo, che non smette mai di essere ente pensante e credente, capace di autoriflessione e di autocoscienza e in quanto tale, pur sempre bisognoso di spazi esteriori di libertà che presidino i margini di operatività di quelli interiori, nei quali esercitare propriamente i suoi diuturni atti di fede, di culto, religiosi e morali: «Ciò che conferisce dignità all’uomo ‒ afferma Sergio Cotta ‒ è ciò che lo sovra-ordina agli enti naturalistici: la capacità riflessiva di auto-comprendersi nel trascendimento della propria onticità fattuale»[23], e di far ciò, si aggiunga, nel tempio sacro della propria coscienza, i cui spazi preferenziali di azione vanno dunque protetti e tutelati, nel loro uniformarsi ad una verità superiore che la comprende e la possiede.
* Contributo sottoposto a valutazione.
[1] Il primo capoverso del Preambolo alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, così recita: «Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo; considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione; considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà; considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali; considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni; l’Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Umani». Nostri i corsivi.
[2] H. Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza, tr. it. a cura di F. Sossi, Milano, 2002.
[3] Ivi, p. 71.
[4] J. Maritain, I diritti dell’uomo e la legge naturale, Milano, 1953.
[5] J. Maritain, Oeuvres Complètes, Parigi, 1984, p. 671.
[6] J. Maritain, Tolleranza e verità, in Il Filosofo nella società, Brescia, 1976, p. 65 ss.
[7] M. C. Nussbaum, Liberty of Conscience. In Defense of America’s Tradition of Religious Equality, Basic Books, New York, 2008, p. 169. Nostra la traduzione.
[8] Tommaso D’Aquino, Summa Theologica, I, 166.
[9] «L’intelletto dell’uomo, dunque, non fonda l’essere delle cose, non dà l’essere alle cose né ha il potere di legiferare intorno all’essere delle cose, le quali ricevono quell’essere e le leggi che lo governano da Dio. L’intelletto dell’uomo scopre l’essere delle cose, toglie il velo, che è sulle cose, per vederne l’intima struttura e le leggi, che le governano. Ed è questo appunto il significato etimologico del termine greco, corrispondente al nostro termine verità. La verità era per i greci ajlhvqeia, cioè dis-velamento, atto con cui l’intelletto toglie il velo, per vedere le cose come sono in se stesse. Questo fatto della conformità dell’intelletto dell’uomo alla realtà esistente al di fuori dell’intelletto è la prima condizione del fare filosofia. Tolta questa condizione, crolla tutta la filosofia tomistica. Tolta questa condizione, non è più possibile parlare di morale oggettiva e universale», così F. Fiorentino, Verità, Bellezza e Scienza. Temi di filosofia aristotelico-tomistica/3, Napoli, 2008, p. 28.
[10] Per una teorizzazione completa e chiara in materia di metodologia dell’ermeneutica oggettiva, si veda: F. Fiorentino, Attualità di San Tommaso d’Aquino. Temi di filosofia aristotelico-tomistica/3, Napoli, 2018, p. 268 ss.
[11] Scrive a questo proposito Adorno: «Nella filosofia kantiana è fondamentale il soggetto concepito come un principio libero che dà a se stesso le sue leggi, mentre viceversa tutto ciò che sta al di fuori della sua legge libera e autonoma, dunque anche Dio e l’immortalità, è eteronomo, o dogmatico, si potrebbe dire», in T. W. Adorno, Terminologia filosofica, tr. it. a cura di A. Solmi, vol. II, Torino, p. 496 ss.
[12] «Quando l’essere delle cose dipende dall’intelletto dell’uomo (e dalla sua volontà, che comanda all’intelletto), accade che ciò che in un luogo è uomo, in un altro non lo sia. Esempio vivente di questa contraddizione, che trova la sua giustificazione solo nel relativismo del pensiero soggettivizzato, è la condizione storica del negro, che nello stesso tempo ma in luoghi diversi o negli stessi luoghi ma in tempi diversi, è stato contraddittoriamente uomo e non-uomo», F. Fiorentino, Verità, Bellezza e Scienza, op. cit., p. 39.
[13] Ivi, p. 42.
[14] Per la concezione teleologica della natura, si veda: F. Fiorentino, Etica, Bioetica e Politica. Temi di filosofia aristotelico-tomistica/2, Napoli, 2009, p. 219 ss.
[15] Cfr. E. Voegelin, La nuova scienza politica, Roma, 1968.
[16] Cfr. T. Anatrella, Il regno di Narciso. Una società a rischio a fronte di una differenza sessuale negata, Cinisello Balsamo, 2014.
[17] «Lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non è in grado di garantire». Così scrisse Ernst-Wolfgang Böckenförde nel 1967 nel famoso saggio La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione, Brescia, 2006 (tit. orig. Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation und Utopie, 1967).
[18] Cfr. S. Cotta, L’uomo tolemaico, Milano, 1975.
[19] V. Possenti, Biopolitica, Biodiritto e Nichilismo tecnologico, in Il nuovo meridionalismo, Anno II – n. 2/Aprile 2016, p. 30.
[20] A. Rosmini, Antropologia in servigio della scienza morale, Roma, 1981, p. 516.
[21] Cfr. S. Cotta, Il diritto nell’esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica, Milano, 1991.
[22] Ivi, p. 91.
[23] Ivi, p. 90.