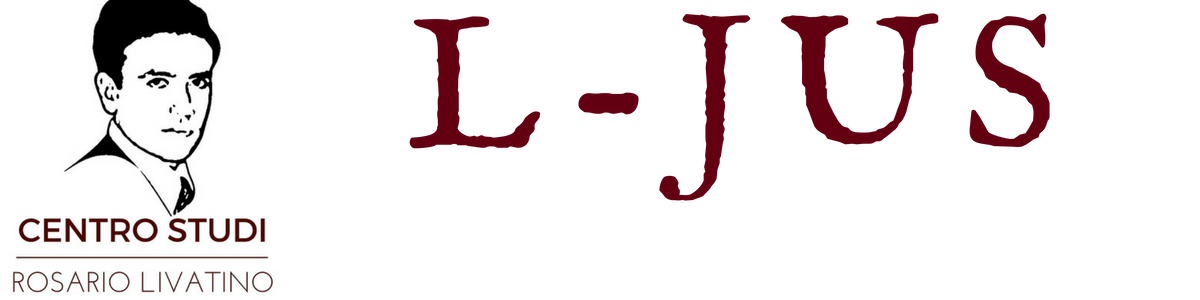Si riporta il testo della relazione di Carmelo Leotta*, depositata in seguito all’audizione informale in Commissione Giustizia e Affari Sociali alla Camera dei Deputati del 4 giugno 2021.
- Il contenuto del testo base
Il testo base in esame disciplina la facoltà per soggetti malati che si trovino nelle condizioni previste dagli artt. 1 e 3 di richiedere l’assistenza medica per porre fine volontariamente e autonomamente alla loro vita, cioè di procurarsi la c.d. «morte volontaria medicalmente assistita». La stessa è definita dall’art. 2 come «decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario Nazionale».
Può accedere alla morte volontaria medicalmente assistita il malato, maggiore di età, se sussistono le seguenti condizioni:
- sia capace di assumere decisioni libere e consapevoli (art. 3, 1° co.);
- sia affetto da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili (art. 3, 1° co.);
- sia in corso una patologia irreversibile o a prognosi infausta o una condizione clinica irreversibile (art. 3, 2° co., lett. a);
- vi sia stata l’attivazione di trattamenti di sostegno vitale (art. 3, 2° co., lett. b);
- vi sia l’assistenza da parte della rete delle cure palliative o espresso rifiuto, da parte del malato, di tale percorso assistenziale (art. 3, 2° co., lett. c).
I requisiti e la forma della richiesta di morte medicalmente assistita sono disciplinati dall’art. 4. In sintesi: la richiesta deve essere «informata, consapevole, libera ed esplicita». Può essere revocata «in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà». La forma della richiesta deve essere scritta ed avere i medesimi requisiti del testamento olografo, di cui all’art. 602 c.c. Qualora le condizioni del malato non permettano il rispetto di tale forma, «la richiesta può essere espressa e documentata con qualunque dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà» (art. 4, 1° co., ult. per.). La richiesta, prevede l’art. 4, 2° co., è indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente ovvero a un medico di fiducia.
Dopo che il medico ha ricevuto la richiesta, assume un ruolo essenziale nella procedura il Comitato per l’etica nella clinica presso l’Azienda Sanitaria territoriale (istituito con regolamento del Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 6). Il Comitato ha caratteri di indipendenza, multidisciplinarietà e autonomia e ha in particolare il compito di svolgere una «adeguata valutazione dei requisiti e delle modalità per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita».
Al Comitato competente per territorio il medico che ha raccolto la richiesta del malato invia un rapporto sulle condizioni cliniche del richiedente e sulle motivazioni a base della richiesta.
Il rapporto:
- contiene copia della richiesta e della documentazione medica e clinica pertinente alla richiesta (art. 5, 2° co.);
- deve precisare se la persona è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi (art. 5, 3° co.);
- deve precisare se la persona è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche (art. 5, 3° co.);
- deve indicare se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative e specificare se il malato è già in carico a tale rete di assistenza o se ha rifiutato tale percorso assistenziale (art. 5, 3° co.).
Il Comitato per l’etica nella clinica, ricevuto il rapporto, entro 7 giorni, trasmette un parere motivato sui presupposti ed i requisiti a supporto della richiesta di morte assistita e lo trasmette al medico richiedente ed alla persona interessata (art. 5, 4° co.). Se il parere del Comitato è favorevole, il medico lo trasmette, insieme alla documentazione in possesso, alla Direzione Sanitaria dell’Azienda Sanitaria Territoriale o alla Direzione Sanitaria dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera di riferimento, che dovrà attivare le verifiche volte a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità di cui al 1° co. (dignità, senza ulteriori sofferenze ed evitando abusi), presso il domicilio del paziente o, se non è possibile, presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica (art. 5, 5° co.). Tra le modalità di cui al 1° co. vi sono anche quelle inerenti all’individuazione da parte del malato delle persone che devono essere informate della sua decisione e che possono presenziare all’atto del decesso.
Ai sensi dell’art. 5, 6° co., la richiesta del malato, la documentazione medica e il parere del Comitato fanno parte della cartella clinica o del fascicolo elettronico sanitario.
L’art. 5, 7° co., disciplina il momento dell’esecuzione dell’atto causativo della morte del paziente e prescrive che il medico presente debba «previamente accertare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà di morte volontaria medicalmente assistita e che permangano le condizioni di cui all’articolo 3». La morte cagionata secondo le disposizioni in esame è equiparata alla morte per cause naturali, a tutti gli effetti di legge.
L’art. 7, 1° co., del testo base sancisce l’esclusione di punibilità per i delitti puniti dagli artt. 580 (istigazione e aiuto al suicidio) e 593 (omissione di soccorso) c.p., per il medico e il personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria e per «tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge».
Il 2° co. dello stesso art. 7 prevede che non sia punibile chi sia stato condannato, anche con sentenza definitiva, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della entrata in vigore della presente legge, se al momento del fatto ricorrevano le seguenti condizioni:
«a) la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita sia stata formulata da persona maggiorenne, capace di intendere e di volere e la volontà di questa si sia formata liberamente e consapevolmente e sia stata inequivocabilmente accertata;
- b) la persona richiedente sia stata affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile e che sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;
- c) la persona richiedente sia stata affetta da una patologia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che ella riteneva intollerabili nel rispetto dei principi generali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 22 dicembre 2017, n. 219».
Infine, l’art. 8 del testo base, in materia di disposizioni finali, prevede che il Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto:
- a) individua i requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale per l’accoglienza dei richiedenti la morte assistita;
- b) definisce i protocolli e le modalità dell’assistenza sanitaria alla morte assistita;
- c) definisce le procedure per assicurare il sostegno psicologico alla persona malata ed ai suoi familiari;
- d) determina le modalità di custodia ed archiviazione delle richieste di morte assistita e di tutta la documentazione ad essa relativa.
L’art. 8, 2° co., stabilisce, infine, che il Ministro della salute presenti annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della legge.
- Inesistenza di un vincolo sulla disciplina del fine vita imposto dalla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale
La proposta di legge intende raccogliere l’auspicio in vista di un intervento legislativo sull’aiuto al suicidio della persona gravemente malata e sofferente, formulato dalla sentenza n. 242 del 24-25 settembre 2019 della Corte costituzionale (cfr. n. 9 del Considerato in diritto), con la quale, nel giudizio incidentale di costituzionalità proposto nel processo Cappato, era infine dichiarata la parziale illegittimità dell’art. 580 c.p.
Prima di affrontare ogni altro profilo, è necessario sgombrare il campo da un possibile equivoco, relativo all’esistenza di un eventuale vincolo posto al legislatore dalla sentenza n. 242/2019 sui contenuti della disciplina legislativa che dovrà stabilire in materia di fine vita. A ben vedere la Corte costituzionale, con la sentenza richiamata, pur fornendo alcune possibili indicazioni sui contenuti della legge (di cui si dirà) non ha imposto alcun vincolo al legislatore; se, infatti, si dovesse ammettere l’esistenza di tali vincoli, si dovrebbe altresì ammettere che si sarebbe realizzata una incrinatura dell’ordine istituzionale, assegnandosi al giudice delle leggi il potere di fissare ex ante i contenuti di un atto legislativo i quali possono essere solo il frutto di una valutazione di natura politica che, in quanto tale, deve essere compiuta dalla rappresentanza (art. 67 Cost.). Quanto ora affermato è sancito a chiarissime lettere dall’art. 28, L. n. 87/1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), che recita: «Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento».
Si osservi come sia peraltro la stessa sentenza n. 242 ad escludere l’esistenza di vincoli de jure condendo in capo al legislatore. Laddove la Corte si premura di spiegare la tecnica decisoria utilizzata (tale per cui, come noto, all’ord. n. 207/2018 ha fatto seguito la pronuncia di parziale incostituzionalità dell’art. 580 c.p. con la sentenza n. 242/2019), precisa, infatti, quanto segue:
«In assenza di ogni determinazione da parte del Parlamento, questa Corte non può ulteriormente esimersi dal pronunciare sul merito delle questioni, in guisa da rimuovere il vulnus costituzionale già riscontrato con l’ordinanza n. 207 del 2018.
Non è a ciò d’ostacolo la circostanza che – per quanto rilevato nella medesima ordinanza e come poco sopra ricordato – la decisione di illegittimità costituzionale faccia emergere specifiche esigenze di disciplina che, pur suscettibili di risposte differenziate da parte del legislatore, non possono comunque sia essere disattese» (Considerato in diritto, 4).
Come si evince, pertanto, dal passaggio della decisione ora riportato, la Corte costituzionale pone un unico “vincolo” al legislatore: quello di intervenire con una legge, ma, per fugare ogni equivoco, ribadisce essa stessa che le esigenze di disciplina sono «suscettibili di risposte differenziate».
- Disciplina della morte volontaria medicalmente assistita e conseguente rinuncia al principio di indisponibilità del diritto alla vita
Ciò chiarito in premessa, è corretto affermare che la sentenza n. 242/2019, dichiarando la parziale incostituzionalità dell’art. 580 c.p., ha ammesso, pur nei limiti di una procedura, il ricorso al suicidio assistito da parte del malato affetto da grave patologia, quale espressione della sua libertà di autodeterminazione terapeutica (Considerato in diritto, 2.3).
Ciò nonostante, una legge che, ove approvata, disciplinasse compiutamente (come la proposta in esame) l’esercizio della facoltà da parte di taluni soggetti di richiedere l’aiuto nel cagionarsi la morte non avrebbe un mero effetto ricettivo del principio già contenuto nella sentenza n. 242 e segnerebbe, piuttosto, un definitivo riconoscimento, sul piano generale delle fonti del diritto italiano, della liceità di una deroga al principio di indisponibilità della vita. Ne deriverebbe un salto radicale, su di un piano culturale e normativo, rispetto a un modello, qual è quello vigente, di tutela indifferenziata, cioè eguale per tutti, del diritto alla vita.
Per comprendere pienamente la portata di un siffatto cambio di paradigma, è opportuno avere a mente che l’ordinamento giuridico qualifica un certo bene come indisponibile quando, a fronte di un giudizio di valore, ritiene che la sua conservazione sia irrinunciabile per la persona umana; pertanto, quando un bene è indisponibile, il suo titolare non può decidere di rinunciarvi né di sacrificarlo o di distruggerlo. Qualora lo faccia, egli non esercita un diritto, ma una mera facoltà di fatto che, quand’anche non possa essergli impedita, conserva una connotazione di contrarietà al diritto, cioè di antigiuridicità. Da qui la scelta di punire chi induce o coopera nell’atto di disposizione di un diritto indisponibile o, peggio ancora, chi da tale atto trae un vantaggio.
Gli esempi di indisponibilità di un bene sono molteplici nel nostro ordinamento. Il diritto alla vita è per eccellenza il diritto indisponibile. Come ha affermato la Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Pretty c. United Kingdom (2002), il diritto alla vita non può ricomprendere, infatti, il diritto a morire, che è il suo contrario. Coerentemente con tale impostazione, in Italia sono oggi puniti l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) e l’istigazione e l’aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), pur con i limiti, rispetto a tale ultimo delitto, posti dalla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale, al caso in cui l’atto suicidario sia compiuto da «una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli» (Corte cost., sentenza n. 242/2019, dispositivo). Nel nostro ordinamento sono indisponibili anche altri beni, inerenti, ad es., alla sfera sessuale. Si consideri il delitto di cui all’art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne) che rende indisponibile per il minore di anni 14 l’esercizio della propria sessualità, punendo con la pena da 6 a 12 anni colui che compie con il minore consenziente atti sessuali. Sempre nell’ambito della tutela della sfera sessuale, l’art. 600 bis c.p. (prostituzione minorile), al 2° co., punisce con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro, chiunque copie atti sessuali con un minore tra i 14 e i 18 anni, in cambio di denaro o di altra utilità, anche solo promessi; risultano, pertanto, inibiti al minore atti dispositivi del proprio corpo integranti il meretricio. Espressione, per il minore, di un principio di indisponibilità della propria sfera sessuale è anche l’art. 600 ter, 1° co., c.p. (pornografia minorile), che punisce con la reclusione da 6 a 12 anni e la multa da 24.000 a 240.000 euro chi realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico con minori di anni 18 (n. 1) e chi recluta o induce minori di anni 18 a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae profitto (lett. 2).
L’indisponibilità di un diritto si giustifica talora per la natura stessa del bene (come accade per la vita) talora per le modalità con cui il bene è fatto oggetto di un atto di disposizione o, ancora, per le caratteristiche del suo titolare (così nel delitto di atti sessuali con minorenne). Ancorché esistano distinte ragioni per sancire l’indisponibilità di un diritto, gli esempi proposti rendono evidente che tale regola funge da strumento di tutela cui l’ordinamento giuridico ricorre per impedire che la persona, per la situazione di vulnerabilità in cui si trova, sacrifichi un bene la cui conservazione e il cui godimento è connaturato alla dignità personale. La regola dell’indisponibilità trova, quindi, la sua ratio di tutela non tanto a vantaggio di chi si trova in condizioni favorevoli (salute, benessere psichico, capacità di autosostentarsi attraverso il lavoro, capacità di relazionarsi, ecc..), ma al contrario a vantaggio di chi versa in una situazione di debolezza, di dolore (fisico, psicologico, morale o spirituale), di necessità o, ancora, di immaturità; è evidente, infatti, che in tali situazioni il soggetto può facilmente convincersi o essere da terzi indotto a ritenere che sia preferibile sacrificare un proprio bene, la cui conservazione è invece connessa alla dignità personale, in vista di un vantaggio immediato. È per questo che l’ordinamento, rispondendo ad un dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) e di eguaglianza (art. 3, 1° e 2° co., Cost.), viene incontro al soggetto debole e, sulla base di uno statuto dignitario riconosciuto ad ogni persona, indipendentemente dalla capacità attuale della stessa di percepire il valore di sé e del bene in gioco, rende “operativa” la regola dell’indisponibilità, prevedendo una pena per il terzo che induce il titolare a disporre del proprio bene indisponibile o partecipa all’atto di disposizione o approfitta del medesimo.
Individuata nei termini anzidetti la ratio della indisponibilità di certi diritti, riconoscere alle persone affette da una patologia irreversibile e da una sofferenza intollerabile la facoltà di chiedere aiuto e assistenza nel darsi la morte, parrebbe prima facie il riconoscimento non di un diritto al suicidio, ma di un diritto a morire per non soffrire. Tuttavia, rispondere al problema della sofferenza grave dei malati affetti da patologia irreversibile ricorrendo ad una siffatta opzione normativa avrebbe una portata senza precedenti. Dal momento, infatti, che il giudizio sulla disponibilità/indisponibilità di un diritto si fonda su un giudizio di valore del bene in gioco, consentire al malato di disporre, seppur nel rispetto di una certa procedura, del proprio bene vita a causa delle condizioni in cui si trova significa affermare che la sua vita “vale” meno di quella del sano. Da un simile approccio deriverebbe, con ogni evidenza, una palese e irriducibile violazione del principio di eguaglianza. Non può non condividersi, pertanto, il giudizio formulato a tal proposito da una voce autorevole della scienza penalistica italiana, secondo la quale creare uno spazio libero dal divieto di disporre del bene vita per i malati, che pur versano in gravi situazioni, «significa porli fuori dall’ordinamento giuridico e negare loro quella tutela che spetta ad ogni uomo» (F. Mantovani, Delitti contro la persona, WKI, Milano-Padova, 2019, p. 77).
Si consideri, inoltre, come l’assegnazione di un diritto o di una facoltà di richiedere la morte medicalmente assistita comporti, sul piano generale dell’ordinamento, un vaglio positivo sulla meritevolezza di tutela di un’aspettativa individuale in vista dell’annientamento di sé. Formulare un simile giudizio di meritevolezza è, tuttavia, un controsenso giuridico perché quando si attua il godimento della pretesa, il soggetto, titolare della pretesa stessa, viene meno perché muore. A tal proposito basti ricordare quanto ritenuto, in senso contrario a questa prospettiva, dalla Corte di cassazione che, con la sentenza a sezioni unite n. 25767/2015, ha affermato che «la non vita non può essere un bene della vita» e che l’«ordinamento non riconosce il diritto alla non vita».
Infine, affermare l’esistenza di un diritto (o anche solo di una facoltà meritevole di tutela) al suicidio assistito cagiona non solo, come si è appena detto, la distruzione di un corretto rapporto tra il soggetto e i suoi diritti (i quali devono essere rivolti alla conservazione della persona e non alla sua distruzione), ma, ancor più radicalmente, causa l’implosione dell’esperienza della giuridicità. Questa si fonda, infatti, sulla previa esistenza di una pluralità di persone, tra loro in relazione: da tale pluralità intersoggettiva origina l’esigenza di attribuire a ciascuno quanto gli spetta (suum cuique tribuere), conformemente a ciò che l’ordinamento ha riconosciuto o attribuito. A fronte di questa perenne verità, la pretesa di affermare l’esistenza di una relazione tra uomini, disciplinata dalla legge in vista della morte proceduralizzata di uno dei soggetti coinvolti, porta alla dissoluzione di un’elementare propensione all’umana solidarietà e, immediatamente a seguire, alla dissoluzione dell’esperienza stessa della giuridicità fondata sull’esistenza di una pluralità di persone e funzionale alla conservazione di tale pluralità.
- Ulteriori effetti dell’adozione di un paradigma di tutela della vita umana fondato su qualità variabili o accidentali della persona
Si è fin qui evidenziato come l’introduzione di una deroga al principio della indisponibilità della vita umana sulla base di un criterio salute/malattia comporterebbe una grave ed insanabile violazione del principio di eguaglianza poiché ammettere tale deroga equivarrebbe ad affermare che la vita del malato vale meno di quella del sano, dal momento che il primo ne può disporre e il secondo no.
L’adozione nel sistema delle fonti dell’ordinamento e, pertanto, su di un piano generale, di un siffatto modello di tutela del bene vita, fondato su qualità variabili o accidentali della persona, tuttavia, non limiterebbe i suoi effetti alla disciplina della fine della vita, ma aprirebbe in prospettiva questioni etiche e, a discendere, normative relative ad ogni questione biogiuridica che il legislatore si troverà in futuro ad affrontare. Di seguito si farà un cenno in particolare a due conseguenze che paiono di fondamentale importanza.
- Se si adotta un modello di tutela della vita e di altri diritti fondamentali che ammette livelli diversi di protezione sulla base di un criterio di qualità, si rende necessario individuare, di volta in volta, la caratteristica della persona o la circostanza che giustifichino, attenuino o escludano tale tutela.
In materia di morte medicalmente assistita, il criterio sulla meritevolezza della tutela si fonda sulla contrapposizione salute/malattia: l’ordinamento riconosce un più ampio valore alla vita del sano e un pari valore alla vita del malato solo fino a quando questi ritenga la propria sofferenza tollerabile e la propria esistenza dignitosa. Un domani il criterio della malattia tollerabile potrebbe essere esteso alla tollerabilità del disagio psichico, sociale, economico, i quali in molti casi sono motivo di sofferenze per la persona non inferiori a quelle cagionate dalla malattia. Ad ogni buon conto, non può sfuggire a nessuno come, nella misura in cui si associa la tutela di un bene fondamentale alla sussistenza di una condizione o qualità, si renda immediatamente necessario scegliere quali siano le condizioni che rendono meritevole la tutela ovvero che ne possono giustificare l’esclusione.
- Laddove si opti per un modello di tutela di beni fondamentali subordinato all’esistenza di una qualità del titolare dello stesso o di altra circostanza si pone immediatamente una questione con rilevanti effetti pratici, vale a dire: con quali modalità accertare, nel caso concreto, la sussistenza di tale qualità o l’integrarsi della situazione che comporta l’esaurimento della tutela?
Nel caso di specie, già sulla base del testo proposto, un primo profilo assai problematico riguarda l’accertamento dell’esistenza di una patologia irreversibile o a prognosi infausta o di una situazione clinica irreversibile. Tali situazioni, a ben vedere, prescindono dall’imminenza della morte e possono essere integrate anche in momenti che anticipano significativamente, sul piano cronologico, l’exitus. Un secondo profilo riguarda l’accertamento della volontà del malato di porre fine alla propria vita. A tal proposito non può peraltro non porsi in evidenza il rischio, quanto mai concreto, di una lettura evolutiva del concetto di “volontarietà” della richiesta di morte medicalmente assistita. È pur vero che il testo base in esame sembrerebbe prevenire applicazioni estensive prevedendo espressamente che la morte sia volontaria e, all’art. 1 ricorrendo, ad esempio, a due avverbi, riferiti all’atto del porre fine alla propria vita: volontariamente e autonomamente. Non solo: tra i requisiti per accedere all’atto, si richiede, sulla scorta della sentenza n. 242 della Corte costituzionale, che il soggetto sia capace di prendere decisioni libere e consapevoli (art. 3). Tuttavia, sarebbe ingenuo non prevedere interpretazioni giurisprudenziali “evolutive” volte a consentire anche all’incapace di accedere alla morte medicalmente assistita, eventualmente per il tramite dell’istituto delle disposizioni anticipate di trattamento disciplinate dalla l. n. 219/2017. Né si dimentichi che nella storia giudiziaria italiana non manca un precedente giudiziario, il caso Englaro del 2007, in cui la Sez. I della Corte di cassazione affermò (sentenza n. 21748) che la richiesta di interruzione del trattamento medico salvavita può provenire, «come estremo gesto di rispetto dell’autonomia del malato», dal tutore della persona priva di coscienza, allorché «tenendo conto dei valori e delle convinzioni propri della persona in stato di incapacità», il protrarsi di tale situazione appaia incompatibile con il senso di dignità della vita precedentemente manifestato dalla persona incosciente (cfr. Cass. civ., sez. I, 16-10-2007, n. 21748, in particolare punto 7.5).
Pertanto, appare assai verosimile ritenere che, una volta imboccato un modello di tutela differenziata del bene vita sulla base di un criterio di qualità, si aprirà inevitabilmente la strada sia a problemi pratici di accertamento dei requisiti che legittimano la richiesta di morte medicalmente assistita sia ad applicazioni estensive della norma, per via giurisprudenziale. D’altronde, rinunciando al principio di indisponibilità della vita umana, ove si ritenga che la tutela della stessa possa soccombere in nome del senso di dignità personale, neppure più si giustificherebbe un’esclusione a priori della richiesta di morte formulata attraverso le DAT oppure dal rappresentante dell’incapace.
- L’impossibilità di distinguere tra diritto ad “essere aiutati a morire” e “diritto a morire”
Ai fini di una valutazione della proposta, è altresì utile approfondire se sia concettualmente corretto tenere distinti da un lato il diritto di “essere aiutati a morire”, dall’altro il “diritto a morire”. L’articolato in esame prevede, infatti, sulla scorta della sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale, la facoltà di compiere un atto di suicidio assistito (e non di eutanasia in senso stretto): la morte volontaria medicalmente assistita può riguardare esclusivamente «la persona maggiore di età, capace di prendere decisioni libere e consapevoli» (art. 3) e richiede che il decesso avvenga con «un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita» (art. 2). Riservando al diretto interessato il compimento dell’atto causativo del decesso, la proposta riconoscerebbe, quindi, un mero diritto ad essere aiutati nel procurarsi la morte e non un diritto a morire né tanto meno ad essere uccisi su richiesta. Nel primo caso, è il soggetto titolare del bene che compie su di sé l’atto (o parte dell’atto) con cui si procura la morte e chiede l’aiuto o l’assistenza di terzi, i quali sono in genere persone professionalmente qualificate (suicidio assistito). Nel secondo caso, laddove, cioè, si riconosca un diritto a morire e ad essere uccisi su richiesta, la morte viene procurata da un soggetto diverso dal titolare del bene, su istanza di quest’ultimo. Questa ipotesi rientra propriamente nella c.d. eutanasia attiva.
La contrapposizione diritto ad essere aiutati nel procurarsi la morte vs diritto a morire, se osservata più attentamente, appare invero assai labile.
Infatti,
- a) affermare che un soggetto ha diritto ad essere aiutato in vista di un obiettivo finale (in questo caso: la morte) significa riconoscere previamente che abbia diritto a raggiungere tale obiettivo, dal momento che è proprio in vista di questo che gli viene prestata assistenza. Sarebbe, infatti, un controsenso affermare che esiste un diritto rispetto ad un mezzo e non riconoscere contestualmente l’esistenza di una pretesa meritevole di tutela giuridica rispetto al fine. Per tali ragioni, il costituzionalista Antonio Ruggieri, in un commento all’ord. n. 207/2018 della Corte costituzionale, già affermava con particolare chiarezza che non è possibile distinguere tra diritto all’aiuto a morire e diritto a morire di una persona che versi in una condizione di grave sofferenza fisica e morale; «l’uno diritto, infatti, poggia sul secondo; e, in tanto perciò se ne può predicare e reclamare la tutela, in quanto previamente si ammetta quest’ultimo» [cfr. A. Ruggieri, Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di C. Cost. n. 207/2018), in M. Ronco, Il “diritto” di essere uccisi: verso la morte del diritto?, Torino, 2019, pp. 7-8].
In altre parole: un ordinamento che riconosce l’esistenza di un diritto ad essere aiutati a morire sta al contempo riconoscendo un diritto a morire.
- b) La pretesa di circoscrivere la deroga al principio di indisponibilità della vita al caso del malato che chiede (non già di essere ucciso), ma “solo” di essere aiutato a darsi autonomamente la morte – deroga dalla quale discenderebbe l’ammissione del suicidio assistito, ma non anche dell’eutanasia – non si giustifica: se, infatti, si assegna un diritto a disporre della propria vita a chi materialmente può compiere l’atto dispositivo, sulla base di quale criterio si può inibire l’esercizio di tale presunto diritto o facoltà a chi non è in grado di compiere da sé l’atto causativo della morte? Una volta che si ammetta un principio di disponibilità della vita umana, sarà conseguente ritenere che a quanti non sono in grado di procurarsi la morte con un atto autonomo dovrà essere garantito che qualcuno non solo presti loro assistenza (come avviene nel suicidio assistito), ma che compia l’atto a loro richiesta.
In sintesi: il diritto ad essere aiutati a morire implica, su di un piano logico, il previo riconoscimento del diritto a morire; il diritto a morire implica però anche il diritto a richiedere di essere uccisi, almeno in tutti i quei casi in cui il soggetto non sia in grado di attuare la propria volontà di morte.
D’altronde che non vi sia soluzione di continuità tra suicidio assistito e eutanasia lo si evince dalla stessa sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019, la quale, richiamando l’ord. n. 207/2018, menziona espressamente l’atto della somministrazione di farmaci in grado di provocare la morte (cfr. Considerato in diritto, 2.4). La circostanza che la Corte contempli tale ipotesi – vale a dire un atto che, con ogni evidenza, esorbita dal concetto di suicidio assistito e configura una forma di eutanasia attiva – rende evidente come la distinzione tra suicidio assistito ed eutanasia, fondata sulla distinzione tra il darsi autonomamente la morte e farsi dare la morte da altri su richiesta, sia assai labile sia sul piano logico che sul piano pratico.
- Confronto tra le indicazioni contenute nella sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale e il testo base in esame
La proposta in esame non solo assegna al malato la facoltà di richiedere l’aiuto al suicidio, ma nel farlo, si accontenta, come ora si dirà, di uno standard di tutela della vita umana inferiore a quello individuato nella sentenza n. 242/2019. La proposta, infatti, non tiene conto di taluni limiti posti dalla Corte costituzionale alla richiesta di suicidio assistito, finendo per tradire lo stesso “spirito” della sentenza che, nel dichiarare la parziale illegittimità della previsione penale che punisce l’aiuto al suicidio, ha cura di precisare che il contrasto costituzionale si pone esclusivamente «entro lo specifico ambito considerato» (v. punto 2.3 del Considerato in diritto, nel cui esordio pure si usa l’espressione «circoscritta area di non conformità costituzionale della fattispecie criminosa», come a ribadire che l’apertura al suicidio assistito non può oltrepassare i limiti essenziali contemplati in sentenza).
Si consideri, in particolare, quanto segue:
- L’estensione, nel testo base, del requisito clinico della «patologia irreversibile»
La sentenza n. 242/2019 circoscrive l’ammissibilità della richiesta di suicidio assistito da parte del malato all’esistenza, tra le altre condizioni, di una «patologia irreversibile», concetto, invero, già assai ampio che ricomprende quello di malattia. Il testo base equipara alla patologia irreversibile la «patologia a prognosi infausta» nonché la «condizione clinica irreversibile». La previsione della patologia a prognosi infausta appare duplicazione inutile che non giova alla chiarezza della norma: una patologia a prognosi infausta è di necessità una patologia irreversibile. Quanto alla previsione della «condizione clinica irreversibile» si tratta di un vistoso ampliamento delle condizioni previste dalla Corte costituzionale, dal momento che una condizione clinica irreversibile non necessariamente corrisponde ad una situazione di patologia. Complessivamente, dal momento che il testo base prevede, anziché un’unica condizione di «patologia irreversibile», le tre distinte ipotesi di «patologia irreversibile», «patologia a prognosi infausta» e «condizione clinica irreversibile», i presupposti di accesso alla morte medicalmente assistita risultano non solo ampliati rispetto a quelli elencati dalla sentenza n. 242, ma anche maggiormente sfumati, posto che è assai complesso riuscire a distinguere i confini tra le tre diverse fattispecie. Non solo: una simile prospettiva tradisce “lo spirito” della sentenza costituzionale che, come noto, ha riconosciuto un diritto a essere assistito nel suicidio, quale modalità alternativa di “congedo” dal mondo, stante la previsione contenuta nella L. n. 219/2017 di rifiuto della cura con contestuale sottoposizione a sedazione profonda. Pertanto, l’unico modo per rendere determinato e preciso il requisito in parola è semmai quello di prevedere che non solo debba esistere una patologia irreversibile (senza aggiungere altre condizioni alternative), ma che, al contempo, debba sussistere una prognosi infausta a breve termine.
Si osservi, inoltre, come il concetto di «situazione clinica irreversibile» appaia difficilmente conciliabile con i requisiti prescritti dalla L. n. 38/2010 per le cure palliative, cui, tuttavia, la persona deve quanto meno poter accedere, secondo la stessa proposta di legge in esame, per poter richiedere la morte medicalmente assistita. L’art. 2 della L. n. 38 citata definisce, infatti, alla lett. a), le cure palliative nei termini che seguono: «insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici». Lo stesso art. 2, lett. c), L. n. 38/2010 definisce il malato, quale soggetto titolare del diritto di ricevere le cure palliative, come «la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita, nonché la persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa».
Ad un’analisi attenta, appare che i requisiti per accedere, de iure condito, alle cure palliative siano più stringenti di quelli richiesti per accedere al suicidio assistito, secondo la proposta.
Infatti,
| per accedere alle cure palliative, ai sensi della L. n. 38/2010: | per accedere al suicidio assistito, ai sensi del testo base: |
| – è necessaria «una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita»; in alternativa è necessaria «una patologia dolorosa cronica da moderata a severa» (art. 2, lett. c) | – è sufficiente anche solo una situazione clinica irreversibile |
| – ai fini della valutazione del dolore del paziente si prescrive, per le cure palliative, un obbligo di rilevazione dello stesso da parte del personale sanitario e l’annotazione nella cartella clinica (art. 7) | – non è prevista una valutazione clinica del dolore del paziente, ai fini della richiesta di morte medicalmente assistita e si richiede unicamente il requisito dell’intollerabilità soggettiva di una sofferenza fisica o psichica (art. 3, 1° co.) |
- Il coinvolgimento in un percorso di cure palliative
Già solo per i due aspetti sopra evidenziati, la proposta in esame, pur lasciando intendere che la richiesta di suicidio assistito sia un’extrema ratio quando le cure palliative hanno fallito, detta una disciplina incoerente con tale premessa perché, come si è detto sub a), richiede, ai fini della formulazione della richiesta di morte medicalmente assistita, requisiti meno stringenti rispetto a quelli previsti dalla L. n. 38/2010 per le cure palliative. La mancata armonizzazione tra le due discipline rivela, pertanto, ad avviso di chi scrive una scarsa attenzione della proposta in esame rispetto ad un obiettivo di valorizzazione delle cure palliative.
Allo stesso giudizio si giunge se si confronta la previsione sulle cure palliative contenuta nella proposta e le indicazioni sul tema contenute nella sentenza n. 242/2019. In quest’ultima si afferma: «Il coinvolgimento in un percorso di cure palliative deve costituire, “un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativa da parte del paziente” (come già prefigurato dall’ordinanza n. 207/2018)» E continua: «Si cadrebbe, altrimenti, nel paradosso di non punire l’aiuto al suicidio senza avere prima assicurato l’effettività del diritto alle cure palliative» (cfr. Corte cost., sentenza n. 242/2019, Considerato in diritto, 2.4).
Anche il testo base in esame contempla, come si è detto, il percorso di cure palliative, all’art. 3, 2° co., lett. c), dove si prevede che la persona richiedente la morte assistita, debba «essere assistita dalla rete di cure palliative o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale». Tuttavia il testo base assume, in materia di cure palliative, un approccio ben distinto da quello della Corte costituzionale. Nella prospettiva della sentenza, infatti, il percorso delle cure palliative deve essere stato attivato prima di poter avanzare una richiesta di suicidio assistito. La proposta di legge, invece, si limita a richiedere, all’art. 3, 2° co., lett. c), che la persona richiedente la morte assistita sia «assistita dalla rete di cure palliative o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale». La prospettiva del testo in esame è profondamente diversa rispetto a quella della Corte costituzionale poiché quest’ultima esige che il malato, prima di richiedere il suicidio assistito, abbia tentato la cura del dolore, nella consapevolezza che «l’accesso alle cure palliative, ove idonee a eliminare la sofferenza, spesso si presta, a rimuovere le cause della volontà del paziente di congedarsi dalla vita» (Considerato in diritto, 5). L’approccio della proposta è, invece, improntato ad una verifica solo formale della volontà di morte del paziente: questi deve essere informato che esistono le cure palliative e deve essere posto nelle condizioni di potervi accedere; tuttavia non si richiede che ne sperimenti gli effetti potenzialmente benefici sul proprio corpo e sulla propria psiche prima di maturare la decisione definitiva.
- Conclusione: necessaria affermazione del principio di indisponibilità della vita umana e piena attuazione del diritto “ad essere aiutati nel morire”
Quanto fin qui detto intende offrire taluni spunti di riflessione al fine di supportare un intervento del legislatore che riaffermi il rapporto inscindibile tra l’impianto personalistico che informa l’ordinamento giuridico italiano e il principio di indisponibilità della vita umana, premessa per un pieno rispetto anche del principio di eguaglianza e del dovere di solidarietà.
Il riconoscimento del carattere irrinunciabile del principio di indisponibilità della vita richiede al legislatore un atto di consapevolezza del proprio ruolo politico che lo impegni a ricercare un equilibrio armonico tra tutela della vita, cura del paziente, rispetto dell’autodeterminazione e lotta alla sofferenza del malato inguaribile, superando una visione frammentata che contrappone tali beni, perdendo così di vista l’obiettivo del bene complessivo della persona.
Al fine di individuare taluni punti fermi in materia di legislazione sul fine vita, si ritiene utile ripartire dall’affermazione dell’esistenza di un diritto del malato non “ad essere aiutato a morire” (da cui si giunge inevitabilmente all’affermazione di un diritto “a morire” e di un diritto “ad essere uccisi”) quanto piuttosto di un diritto “ad essere aiutato nel morire”. Tale diritto discende direttamente dall’art. 32 Cost. e consiste nell’ottenere la somministrazione di tutte le cure di sollievo al dolore anche in assenza di una richiesta espressa (fermo restando, ovviamente, il rispetto del rifiuto al trattamento). Il diritto “ad essere aiutati nel morire” contempla senza dubbio anche la possibilità di ricorrere a trattamenti che abbiano quali effetti non direttamente voluti (ancorché conosciuti) un’anticipazione dell’exitus. Dal momento che la somministrazione di tali trattamenti potrebbe anche integrare la modalità con cui praticare un atto eutanasico, «il discrimine tra eutanasia e comportamento lecito sta nel metodo e nell’intenzione. Sotto il primo profilo, è ovvio che il criterio guida per la somministrazione di farmaci è la proporzionatezza rispetto all’esigenza di contrasto al dolore» (Ronco, voce «Eutanasia», in Dig. disc. pen., V agg., 2010, 235).
La soluzione praticabile sul piano normativo non consiste, allora, nell’introduzione di una procedura per il ricorso del suicidio assistito, ma anzitutto in una implementazione capillare del sistema delle cure palliative previste dalla L. n. 38/2010 e secondo la prospettiva già assunta dal legislatore italiano con la previsione dell’art. 2, 1° co., L. n. 219/2017.
Sul piano strettamente penalistico ritiene chi scrive che l’unica via coerente con siffatta premessa sia quella di prevedere – se ritenuta necessaria – una circostanza attenuante qualora, sussistendo le condizioni a) della malattia irreversibile, b) della sofferenza intollerabile del malato, c) della previa attivazione del trattamento di sostegno vitale, d) della richiesta di morire della persona capace di intendere e di volere, e) dell’attivazione di trattamenti palliativi, il fatto di agevolare l’altrui suicidio sia commesso da persona prossima alla vittima, nello stato di turbamento generato dall’altrui sofferenza.
* Avvocato in Torino e Professore Associato di Diritto penale all’Università Europea di Roma