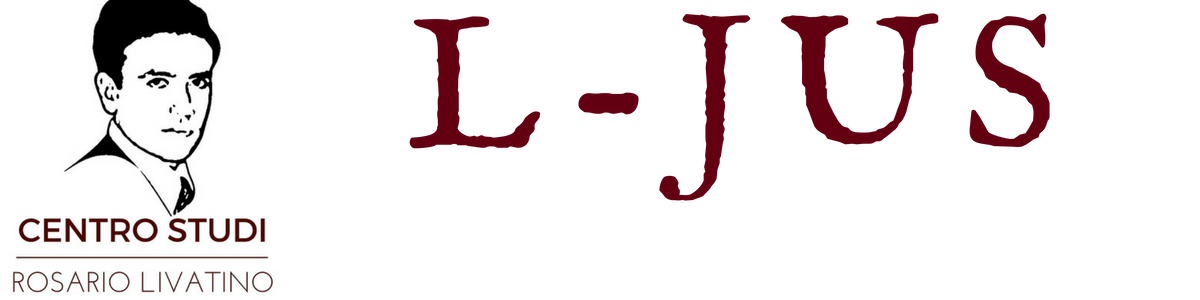Giacomo Rocchi
Consigliere alla Corte di Cassazione
Sommario: 1. Introduzione – 2. L’istituto della liberazione condizionale – 3. La scelta di politica criminale fatta dal legislatore ‒ 4. Il ripensamento della Corte costituzionale sulla spinta della Corte EDU ‒ 5. La soluzione da molti auspicata ‒ 6. Le indicazioni della Consulta ‒ 7. Le indicazioni non vincolanti per il legislatore ‒ 8. Conclusioni.
- Introduzione
Con l’ordinanza n. 97 del 2021 la Corte Costituzionale ha rinviato al 10/5/2022 la trattazione della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione della normativa che esclude dal beneficio della liberazione condizionale il condannato all’ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivante dalla forza di intimidazione delle associazioni di stampo mafioso ovvero al fine di agevolare l’attività di tali associazioni che non abbia collaborato con la giustizia.
Si tratta di condannati che, per la pena loro irrogata, sono responsabili di omicidi o stragi che, per di più, sono stati commessi in un contesto mafioso perché gli autori erano partecipi di un’associazione o comunque alla stessa “vicini”, tanto da approfittare dell’intimidazione sul territorio ovvero compiere i delitti per agevolarla.
Secondo la disciplina complessiva, mentre i condannati all’ergastolo “comuni” – tendenzialmente autori di omicidi premeditati o aggravati da motivi abietti o futili o commessi nel corso di rapine, estorsioni o violenze sessuali – possono aspirare ad essere ammessi alla liberazione condizionale dopo 26 anni di reclusione (che, in ragione degli sconti di pena per partecipazione all’opera rieducativa, possono ridursi a 20 anni), se i delitti sono aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità mafiosa questa possibilità non esiste, a meno che gli stessi non collaborino con la giustizia, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati.
Non solo: l’intero regime penitenziario muta per questi ergastolani non collaboranti che, al contrario di quelli comuni, non possono accedere nemmeno ai benefici penitenziari diversi dai permessi premio e, quindi, alla semilibertà dopo 20 anni di pena (che, in ragione degli sconti già menzionati, possono ridursi a 15 anni) e, nella fase finale dell’espiazione della pena, alla detenzione domiciliare e all’affidamento in prova al servizio sociale.
- L’istituto della liberazione condizionale
La liberazione condizionale è un istituto già presente nel codice penale del 1930: dopo aver scontato una parte consistente della pena (almeno metà; se si tratta di recidivo, tre quarti), il detenuto che ha tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento e che ha risarcito il danno provocato dai suoi delitti, può essere scarcerato rimanendo peraltro, sottoposto a libertà vigilata per un certo periodo (quindi soggetto a controlli, a limitazioni e a obblighi). Se, in questo periodo non commette reati e ottempera agli obblighi derivanti dalla libertà vigilata, la pena residua, che non era stata scontata in conseguenza della scarcerazione, si estingue; nel caso contrario, la liberazione condizionale viene revocata, il condannato rientra in carcere per scontare la pena residua e non può chiedere nuovamente di ottenere il beneficio.
Nel disegno originario del codice, si trattava di una misura premiale diretta ai condannati per pene detentive temporanee anche consistenti; si potrebbe ritenere un’anticipazione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione introdotte con l’ordinamento penitenziario del 1975. In effetti, nel quadro normativo attuale, è sempre la magistratura di sorveglianza ad adottare la relativa decisione e la liberazione condizionale è inquadrata nell’ambito del trattamento penitenziario, che prevede una gradualità dei benefici finalizzata a favorire la rieducazione del condannato: dalla riduzione di pena di 45 giorni per semestre applicata al detenuto che partecipa alle proposte trattamentali e non incorre in violazioni disciplinari, ai permessi premio, nei quali il detenuto esce dal carcere per periodi non superiori a 15 giorni, concessi per coloro che mostrano senso di responsabilità e correttezza e partecipano alle attività organizzate negli istituti, alla semilibertà, in cui il detenuto trascorre parte del giorno fuori dall’istituto carcerario per partecipare ad attività lavorative o istruttive, applicata se vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società, alla detenzione domiciliare e all’affidamento in prova al servizio sociale per la fase finale dell’esecuzione della pena, fino, appunto, alla liberazione condizionale.
Per i condannati all’ergastolo, però, l’istituto della liberazione condizionale ha una portata diversa: permette, infatti, di trasformare la pena che, per definizione, è perpetua, in pena temporanea; la possibilità di ottenere, anche dopo molti anni di reclusione, la scarcerazione e il reinserimento nella vita sociale, può cambiare la “qualità” della detenzione e mantenere viva la finalità della rieducazione della pena imposta dalla Costituzione.
La possibilità di concessione della liberazione condizionale ai condannati alla pena dell’ergastolo venne introdotta nel 1962; negli anni successivi la pena da scontare per accedere all’istituto venne ridotta ad anni 26, venne precisato che per raggiungere tale misura doveva essere conteggiata anche la riduzione di pena per la liberazione anticipata e, ancora, che la necessità del risarcimento del danno era esclusa se il condannato dimostrava di trovarsi nell’impossibilità di adempiere.
Queste riforme impedirono alla Corte costituzionale di dichiarare la pena dell’ergastolo illegittimo, sul presupposto che la perpetuità assoluta della pena contrasta con la sua umanità e con la finalità rieducativa. La Consulta, nel 1997, stabilì che, al contrario degli altri detenuti, i condannati all’ergastolo già ammessi alla liberazione condizionale, successivamente revocata per consumazione di reati o violazione degli obblighi, potevano nuovamente avanzare richiesta di ottenere il beneficio, proprio per impedire che la pena residua tornasse ad essere inevitabilmente perpetua.
- La scelta di politica criminale fatta dal legislatore
Il decreto-legge 152 del 1991, introducendo nell’ordinamento penitenziario l’art. 4 bis, il cui contenuto è esplicitato fin dall’epigrafe (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità dei condannati per alcuni delitti), intervenne sul regime dei benefici penitenziari nei confronti dei soggetti condannati per determinati reati.
A seguito della strage di Capaci del 23/5/1992, il legislatore vietò per i delitti aggravati dal metodo o dalla finalità mafiosa e per quelli di partecipazione ad associazione mafiosa o ad associazione finalizzata a traffico di sostanze stupefacenti o di sequestro di persona a scopo di estorsione la concessione dei benefici penitenziari e della liberazione condizionale salvo il caso in cui il condannato avesse collaborato con la giustizia. La normativa ha visto negli anni successivi numerose modifiche, dovute a pronunce della Corte costituzionale o a interventi del legislatore, sia mediante l’inserimento nell’elenco altri delitti di natura differente, sia prevedendo l’ipotesi della collaborazione impossibile o irrilevante per essere stati i fatti delittuosi integralmente accertati, consentendo in questi casi la concessione dei benefici (e, quindi, anche della liberazione condizionale) purché siano acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata (art. 4 bis comma 1 bis).
È rimasto fermo, comunque, il nucleo della scelta di politica criminale fatta dal legislatore: un soggetto che è stato partecipe ad un’associazione mafiosa o che ha commesso delitti con il metodo mafioso o per finalità mafiose non è meritevole dei benefici penitenziari né, tanto meno, della liberazione condizionale se non ha collaborato con la giustizia, in quanto viene formulata nei suoi confronti una presunzione assoluta di pericolosità non superabile se non con la collaborazione; se la commissione di determinati delitti dimostra l’appartenenza o il collegamento dell’autore alla criminalità organizzata, solo la collaborazione con la giustizia è idonea a dimostrare l’intervenuta rescissione di quei collegamenti la cui permanenza, in caso contrario, è presunta.
Questa presunzione – lo conferma espressamente la Corte costituzionale – non è affatto irragionevole: la partecipazione ad un’associazione di stampo mafioso implica un’adesione stabile ad un sodalizio fortemente radicato sul territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali, dotato di forza incriminatrice e capace di protrarsi nel tempo. La Consulta conferma quanto accertato ripetutamente dai processi: il vincolo associativo può rimanere stabile nonostante lunghe carcerazioni e il soggetto, a meno di compiere una scelta di distacco radicale, tendenzialmente rimane mafioso per tutta la vita.
La collaborazione con la giustizia costituisce, appunto, una scelta di distacco radicale perché contraddice per sua natura il vincolo associativo, contribuendo il collaborante a individuare e a far catturare e condannare per i delitti commessi soggetti ai quali, fino a quel momento, era legato indissolubilmente.
Come è ovvio, la preclusione dei benefici penitenziari ai mafiosi che non collaborano con la giustizia non si giustifica soltanto con la portata individuale della scelta collaborativa da parte del singolo detenuto, ma è finalizzata ad ottenere – così come è avvenuto in questi decenni – un aiuto spesso decisivo per la lotta dello Stato contro le associazioni criminali e per la scoperta e la punizione degli autori di gravissimi reati.
- Il ripensamento della Corte costituzionale sulla spinta della Corte EDU
La scelta legislativa era stata più volte ritenuta legittima dalla Corte costituzionale: in particolare, con la sentenza n. 135 del 2003, la Consulta rimarcava che la preclusione ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale non era frutto di un automatismo legislativo, ma derivava dalla scelta del condannato di non collaborare, pur essendo nelle condizioni di farlo.
Sulla spinta della Corte EDU, tuttavia, la Corte costituzionale è sostanzialmente tornata sui suoi passi, valutando in maniera differente la collaborazione o la non collaborazione del detenuto.
In primo luogo si sottolinea che, così come la collaborazione del condannato può essere frutto di valutazione utilitaristiche e non comportare inevitabilmente l’abbandono della scelta di vita originaria, allo stesso modo la scelta di non collaborare può essere determinata da ragioni estranee al mantenimento dei rapporti con le associazioni criminali: in effetti, secondo la Corte EDU, la dissociazione con l’ambiente mafioso può esprimersi in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia; la presunzione di mantenimento di collegamento con le associazione criminali derivante dalla scelta di non collaborare impedisce di valutare il percorso rieducativo compiuto dal detenuto nei lunghi anni della detenzione; infine, la presunzione è frutto di una generalizzazione che può essere smentita dai dati dell’esperienza: ad esempio, l’associazione criminale di cui il condannato faceva parte potrebbe essere scomparsa, perché sgominata o estintasi.
In secondo luogo, la Consulta dubita che la scelta di collaborare o meno sia sempre effettivamente “libera”: la collaborazione può richiedere la denuncia a carico di terzi, può comportare pericoli per i parenti del detenuto e può rischiare di determinare autoincriminazioni anche per fatti non ancora giudicati.
Sotto un diverso profilo, la Corte costituzionale ha ritenuto che, se è legittimo attribuire una valenza premiale alla collaborazione del detenuto, è illegittimo aggravare il trattamento penitenziario dei detenuti non collaboranti «in conseguenza del fatto che il detenuto esercita la facoltà di non prestare partecipazione attiva a una finalità di politica criminale e investigativa dello Stato» (sentenza n. 253 del 2019); con espressione molto forte – non ripetuta, però, nell’ordinanza qui in commento – la Corte affermava che l’attuale normativa «opera una deformante trasfigurazione della libertà di non collaborare (…) che certo l’ordinamento penitenziario non può disconoscere ad alcun detenuto».
In definitiva, secondo la Corte costituzionale, perché la normativa sia legittima la presunzione su cui si fonda la preclusione dell’ergastolano non collaborante ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale deve trasformarsi da assoluta a relativa, cosicché il presupposto deve poter essere oggetto di “specifica e individualizzante valutazione da parte della magistratura di sorveglianza”.
- La soluzione da molti auspicata
Se questa impostazione aveva indotto la Consulta a dichiarare illegittima la preclusione ai permessi premio ai detenuti, anche condannati all’ergastolo, per delitti di partecipazione ad associazione mafiosa o commessi con metodo mafioso o per finalità mafiose, che non avessero prestato la collaborazione con la giustizia (sentenza n. 253 del 2019), con riferimento all’accesso alla liberazione condizionale la Corte si è fermata, ritenendo rischioso un intervento meramente “demolitorio”, sia con riferimento al complessivo equilibrio della disciplina sia per le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva.
La Corte si è resa conto, infatti, che la posta in gioco è ancora più radicale, soprattutto perché l’accesso alla liberazione condizionale determina, per il condannato all’ergastolo, l’estinzione della pena e il definitivo riacquisto della libertà.
Occorre, quindi, un intervento del legislatore che deve compiere le scelte di politica criminale che una sentenza di illegittimità costituzionale non può comportare.
In effetti, la soluzione da molti auspicata – anche dall’ordinanza di rimessione – era quella di riprodurre anche per la liberazione condizionale la disciplina risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina dei permessi premio: attribuire ai Tribunali di Sorveglianza il compito di valutare, anche per i condannati all’ergastolo per delitti di contesto mafioso che non collaborano con la giustizia, la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione condizionale, vale a dire sia l’avvenuto ravvedimento che l’esclusione di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del ripristino degli stessi.
Si tratta di una soluzione che sembra esaltare il ruolo della Magistratura di Sorveglianza ma che appare oltremodo rischiosa, proprio per il pericolo di pressioni pesanti per una decisione che – come sottolinea la Consulta – determina l’estinzione definitiva di una pena e la sostanziale restituzione alla libertà anticipata di soggetti responsabili di delitti efferati compiuti nell’ambito di un’associazione criminale avente una fortissima capacità di intimidazione.
L’azione di intimidazione potrebbe essere rivolta anche nei confronti degli operatori penitenziari, le cui valutazioni possono portare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza di certezza dell’avvenuto ravvedimento del condannato.
Sotto un altro aspetto, la valutazione dell’inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di ripristino di tali collegamenti che il Tribunale di Sorveglianza sarebbe chiamato a fare (si tratta dell’ulteriore requisito preteso dalla Corte Costituzionale per superare la preclusione all’accesso ai permessi premio degli ergastolani non collaboranti) rischia di basarsi su informazioni prive di certezza da parte delle Forze di polizia o delle Direzioni Antimafia, con il pericolo che la verifica del requisito assuma le forme di un adempimento burocratico.
In fondo, il reale rischio è che – di fatto – la collaborazione con le Forze di polizia e con l’Autorità giudiziaria perda di rilevanza e, quindi, venga meno o si riduca in maniera consistente. Non è certo questo il luogo per criticare la decisione della Consulta – anche perché non avrebbe alcuna utilità – ma appare piuttosto sorprendente la raffigurazione, contenuta nella sentenza n. 253 del 2019 e nell’ordinanza in commento, della collaborazione dei condannati per reati di contesto mafioso come “frutto di mere valutazioni utilitaristiche”, spesso dovuta a molte ragioni “non sempre commendevoli” e contestualmente della mancata collaborazione di altri come esercizio di una libertà innegabile, di un vero e proprio diritto a fronte delle esigenze investigative e di politica criminale dello Stato, e insieme come scelta drammatica, anzi “tragica”, tra la propria libertà, acquistata a rischio di pericoli per i propri cari, con la necessità di denuncia a carico di terzi e con il rischio di autoincriminazioni per fatti non ancora giudicati, e la rinuncia ad essi.
Sembra davvero una rappresentazione in parte deformata. I soggetti di cui si parla – si ricordi: condannati all’ergastolo – si sono resi responsabili di delitti efferati compiuti nell’ambito di associazione criminali la cui pericolosità è nota e da tutti valutata, contro le quali lo Stato combatte da decenni a prezzo del sacrificio di cittadini, appartenenti alle Forze dell’ordine, avvocati, magistrati. Che questi soggetti si prestino a collaborare con lo Stato per motivi utilitaristici – cioè per ottenere benefici, riduzioni di pena ecc. – non è certo una sorpresa, ma è sostanzialmente un presupposto della normativa: la Stato accetta di prestare ad essi utilità per ottenere vantaggi nella lotta contro il crimine organizzato. In ogni caso, a ben vedere, anche l’ergastolano che collabora con la giustizia, per ottenere la liberazione condizionale, deve dimostrare al Tribunale di Sorveglianza il suo “sicuro ravvedimento” (Sez. 1, Sentenza n. 12782 del 24/02/2021 Cc., dep. 02/04/2021, Rv. 280864 – 0).
Interessa, piuttosto, la diversa figura dell’ergastolano che non collabora: i motivi di questa scelta possono essere più vari, ma la stessa Corte Costituzionale riconosce che il principale, che è lecito presumere, è la permanenza dei contatti con la criminalità organizzata, quel sentirsi ancora legato ad un’affiliazione o a un contesto che, tendenzialmente, dovevano essere – quelli sì – perpetui.
Quali sono i motivi differenti che potrebbero giustificare la mancanza di collaborazione? La Corte ne elenca tre: il pericolo per la sicurezza dei propri cari che, peraltro, potrebbe essere annullato o ridotto dalle attività ordinarie o straordinarie già svolte dalle Forze di Polizia; il pericolo di autoincriminazione per fatti non ancora giudicati: un pericolo che, dal punto di vista pratico, è sostanzialmente irrilevante poiché la mancata collaborazione determina l’impossibilità della liberazione condizionale; la necessità di una denuncia a carico di terzi: quest’ultima motivazione appare davvero sorprendente.
In effetti, occorre chiarire – e la Corte costituzionale sembra non volerlo fare fino in fondo, soprattutto nell’ordinanza n. 197 – se la scelta di non collaborare sia un vero e proprio diritto a tutela della dignità della persona del detenuto ovvero se debba avere una motivazione adeguata. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, nell’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale che aveva dato luogo alla sentenza n. 253 del 2019 sui permessi premio, rimarcava che la mancata collaborazione potrebbe derivare dal «rifiuto di causare la carcerazione di altri con i quali si abbia o si sia avuto un legame familiare o affettivo» o ancora dal «rifiuto di accedere alla collaborazione perché non si vuole essere tacciati di averlo fatto soltanto per calcolo utilitaristico, per una riduzione di pena o per ottenere un beneficio penitenziario»: cioè, a ben vedere, si rifiuta la collaborazione per difendere una propria “dignità criminale”, per non compiere un atto che sarebbe censurato da coloro che conoscono il soggetto e che ritenevano non avrebbe mai detto una parola sui complici da perfetto mafioso.
Attribuendo valore a questa motivazione, la mancata collaborazione con la giustizia viene, appunto, elevata a diritto indiscutibile e sostanzialmente non valutabile – il soggetto non collabora perché ritiene “giusto” non collaborare ‒ con la conseguenza che la differenza di trattamento a nei confronti dei collaboranti e dei non collaboranti perde una giustificazione effettiva, contro le stesse indicazioni della Corte costituzionale.
- Le indicazioni della Consulta
Benché la Consulta abbia rimesso le scelte al legislatore, numerose sono le indicazioni e le considerazioni contenute nella ordinanza: indicazioni di cui tenere conto, perché «sarà compito della Corte di verificare ex post la conformità a Costituzione delle decisioni effettivamente assunte», come specifica l’ordinanza.
In primo luogo, la Corte non smentisce del tutto quanto affermato nella sentenza n. 135 del 2003 in ordine alla libertà della scelta dell’ergastolano di non collaborare: questa libertà non è negata del tutto, ma è “dubbia”; essa “può assumere una portata drammatica” e “in casi limite può trattarsi di una scelta tragica”; quindi si tratta di casi eventuali che non possono essere presunti – perché resta valida la presunzione opposta: la mancata collaborazione come indice di permanenza del vincolo associativo – e devono pertanto, essere accertati e dimostrati.
Ecco che, tra le scelte che il legislatore è chiamato a fare in attuazione dell’indicazione della Consulta, viene menzionata quella di far emergere «le specifiche ragioni della mancata collaborazione». In altre parole, la normativa che preclude la liberazione condizionale agli ergastolani non collaboranti sarebbe legittima purché prevedesse la possibilità di tenere conto delle “specifiche ragioni” che impediscono al detenuto di collaborare, che rendono non libera la scelta di accedere a quello scambio, forse non commendevole, ma che lo Stato continua ad offrire; una impossibilità che si affiancherebbe a quella della collaborazione impossibile già regolata dall’art. 4 bis comma 1 bis ord. pen.
Una normativa potrebbe, quindi, prevedere l’onere dell’ergastolano per reati aggravati dal contesto mafioso di esplicitare i motivi per cui non intende collaborare con la giustizia – potrebbe trattarsi di una dichiarazione per la quale si dispone la inutilizzabilità assoluta ai fini processuali ‒ nonché la possibilità per gli organi statali di verificare la fondatezza di tali motivi e di accertare, altresì, se gli stessi sono superabili (ciò vale, in particolare, per la protezione dei soggetti vicini al detenuto). Si deve ribadire che, tra gli specifici motivi, non dovrebbero essere considerati validi quelli basati sulla “dignità criminale” del soggetto, che ritenga “non commendevole” accusare e far perseguire altri soggetti autori di gravi delitti: lo scambio tra Stato e detenuto collaborante viene offerto per motivi che il soggetto – che, peraltro, è già stato ritenuto responsabile di efferati delitti – può ritenere non particolarmente apprezzabili, ma che lo Stato, al contrario, valorizza come importanti.
In secondo luogo – come ripetutamente indica la Consulta – presupposto di ammissibilità di una domanda di liberazione condizionale da parte di ergastolano per delitti di contesto mafioso non collaborante dovrebbe essere la non sottoposizione al regime di cui all’art. 41 bis ord. pen. In effetti, quel regime viene prescritto per il detenuto per i quali sussistono elementi tali da far mantenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale e viene prorogato qualora risulta che la capacità di mantenere detti collegamenti non è venuta meno. Si tratta di regime disposto dal Ministro della Giustizia ma sottoposto ad un controllo giurisdizionale (reclamo davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma, ricorso per cassazione per violazione di legge) che la stessa Corte costituzionale ha ritenuto legittimo.
In terzo luogo, occorre porre l’attenzione sul giudizio che il Tribunale di Sorveglianza è chiamato a compiere nei confronti dell’ergastolano non collaborante che chiede di essere ammesso alla liberazione condizionale: il detenuto – stabilisce l’art. 176 cod. pen. – deve avere tenuto durante il tempo di esecuzione della pena un comportamento tale da “far ritenere sicuro il suo ravvedimento”; come si vede, si tratta di una valutazione che deve essere certa e non soltanto probabilistica e che non contiene una prognosi, ma un accertamento di un fatto già avvenuto.
In altre parole, il Tribunale di Sorveglianza può concedere un permesso premio ai detenuti che hanno mostrato di essere responsabili e corretti per permettere loro di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro, ma si tratta di un beneficio breve, circondato da cautele, revocabile, finalizzato a verificare il progresso trattamentale; analogamente, le altre misure alternative alla detenzione vengono concesse con analogo giudizio probabilistico e prognostico; al contrario, se concede la liberazione condizionale, il Tribunale deve dare atto che il ravvedimento del detenuto è già sicuramente avvenuto in precedenza.
Non solo: ciò che viene accertato non è un fatto – seppure di carattere psichico – di scarso rilievo, perché la parola “ravvedimento” porta con sé l’indicazione di una integrale e definitiva decisione di abbandonare una vita criminale, la cui negatività deve essere riconosciuta dal soggetto, e di reinserirsi nella società. La nozione di “ravvedimento” implica la realizzazione, da parte del condannato, di comportamenti oggettivi dai quali desumere la netta scelta di revisione critica operata rispetto al proprio passato, che parta dal riconoscimento degli errori commessi e aderisca a nuovi modelli di vita socialmente accettati (Sez. 1, Sentenza n. 45042 del 11/07/2014 Cc., dep. 30/10/2014, Rv. 261269 – 01); non consiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condannato, necessaria per fruire dei benefici previsti dall’ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positivi dai cui poter desumere l’abbandono delle scelte criminali, tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato (Sez. 1, Sentenza n. 486 del 25/09/2015 Cc., dep. 08/01/2016, Rv. 265471 – 01), tanto che l’adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato assume rilievo ai fini della verifica, non tanto dell’avvenuta eliminazione del pregiudizio cagionato, quanto piuttosto della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali (Sez. 5, Sentenza n. 11331 del 10/12/2019 Cc., dep. 03/04/2020, Rv. 279041 – 01).
Senza dubbio, ravvedimenti di questo genere possono avvenire in carcere, soprattutto dopo una lunga detenzione: si deve tenere conto, però, che, per l’ergastolano per delitti commessi in contesto mafioso non collaborante, sussiste una presunzione di pericolosità che la Consulta ha confermato, una presunzione di “conservazione dei legami con l’organizzazione criminale di originaria appartenenza”.
Ecco che risulta necessaria una duplice severa valutazione che permetta al Tribunale di Sorveglianza di annullare questa presunzione sotto due profili: accertando (nel senso letterale del termine, verificando con certezza: quindi in senso più “forte” di quanto preteso dalla Corte costituzionale per la concessione dei permessi premio) che devono essere esclusi sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti; nonché, ancora, accertando che la mancata collaborazione – le cui specifiche motivazioni devono essere, appunto, esplicitate e verificate – non incida sul giudizio di un sicuro ravvedimento del detenuto ottenuto dalla valutazione del suo comportamento nel corso della detenzione.
In un passo dell’ordinanza, la Consulta sottolinea che «la valutazione in concreto di accadimenti idonei a superare la presunzione dell’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata (…) deve rispondere a criteri di particolare rigore … per l’accesso alla liberazione condizionale di un ergastolano (non collaborante) per delitti collegati alla criminalità organizzata e per la connessa valutazione del suo sicuro ravvedimento, sarà quindi necessaria l’acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, tali da escludere sia l’attualità dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino».
Come si vede, è un giudizio sicuramente arduo e per esso sembra necessario che il legislatore disegni dei criteri adeguati per non lasciare assoluta discrezionalità ai Tribunali di Sorveglianza, anche per prevenire pressioni e intimidazioni cui si è già fatto cenno.
- Le indicazioni non vincolanti per il legislatore
La Corte costituzionale fornisce altre indicazioni che, tuttavia, non sembrano vincolanti per il legislatore.
In primo luogo, restando al tema degli ergastolani non collaboranti per delitti di contesto mafioso, osserva che stessi potrebbero essere ammessi ai permessi premio (in forza della sentenza n. 253 del 2019) e, in ragione della normativa da approvare, anche alla liberazione condizionale: ma «resterebbe loro inibito l’accesso alle altre misure alternative – lavoro all’esterno e semilibertà – cioè proprio alle misure che invece normalmente segnano, in progressione dopo i permessi premio, l’avvio verso il recupero della libertà». La Corte ne deduce che «un accoglimento immediato delle questioni proposte, in definitiva, comporterebbe effetti disarmonici sulla complessiva disciplina in esame».
Si tratta di considerazioni la cui portata non sembra adeguatamente valutata dalla Consulta.
Come si è visto, l’ordinanza si fonda sulla illegittimità costituzionale di una normativa che configuri l’ergastolo come una pena perpetua sia in fatto che in diritto, risultando, invece, necessario che l’ergastolano continui ad intravedere una concreta possibilità di terminare la pena detentiva, perfino nel caso di liberazione condizionale concessa e poi revocata per consumazione di reati o violazione degli obblighi (sentenza n. 161 del 1997). Questa esigenza – che è quella che muove anche la Corte EDU – non implica affatto il riconoscimento all’ergastolano non collaborante di tutte le possibilità trattamentali offerte agli altri detenuti. Quando la liberazione condizionale venne riconosciuta anche a favore dei detenuti condannati all’ergastolo (1962), la misura non era stata affatto prevista come esito finale di un percorso costituito dalla fruizione di misure alternative alla detenzione: si può avere “ravvedimento” del detenuto, dopo molti anni di detenzione, anche se lo stesso non ha usufruito della semilibertà o dell’ammissione al lavoro all’esterno.
Può sembrare una posizione molto rigorosa ma – tenendo conto della personalità dei soggetti di cui la Corte Costituzionale, con l’ordinanza in epigrafe, si occupa – la stessa è legata alla concreta uscita dal carcere, con tutti i pericoli che si possono facilmente immaginare, in tempi molto brevi: per il lavoro all’esterno, dopo dieci anni (che, in forza della liberazione condizionale, potrebbero diventare poco più di sette anni) mentre per la semilibertà, dopo 20 anni, riducibili a 15 in forza della liberazione anticipata.
Ben potrebbe, quindi, il legislatore non prevedere l’automatica estensione ai condannati all’ergastolo non collaboranti di tutti gli istituti penitenziari o, quanto meno, la loro applicazione con limiti più rigorosi rispetto agli altri condannati all’ergastolo.
- Conclusioni
Il tema degli effetti estensivi dell’ordinanza n. 97 del 2021 e della normativa approvanda è, in realtà, più ampia.
Si deve ricordare che, con la sentenza n. 253 del 2019 sui permessi premio, la Consulta, benché le questioni fossero state sollevate con riferimento alla preclusione alla misura nei confronti degli ergastolani per delitti di contesto mafioso non collaboranti, estese la pronuncia a tutti i detenuti per i delitti compresi nell’art. 4 bis ord. pen. – di carattere mafioso o meno – che non collaborano con la giustizia ritenendo che, in mancanza di tale estensione, la disciplina di risulta sarebbe risultata incoerente.
Si tratta di valutazione che, se è logica con riferimento ad un istituto come il permesso premio – una sospensione breve e controllata della detenzione – non è affatto necessitata con riferimento alla liberazione condizionale che presuppone un giudizio di sicuro ravvedimento del condannato e determina l’estinzione definitiva della pena. In altre parole, ben si potrebbe ritenere che, per i condannati per i delitti di contesto mafioso ad una pena detentiva temporanea, sia legittimo non estendere la possibilità di accedere alla liberazione condizionale in caso di mancata collaborazione con la giustizia permessa, invece, ai detenuti all’ergastolo.
Come più volte sottolineato, l’ergastolo è una pena particolare, per la quale sussiste la necessità costituzionale di permettere sempre la possibilità di un suo termine anticipato; un’esigenza che non tocca affatto gli altri soggetti condannati a pena temporanea.
Un’ultima indicazione della Corte costituzionale riguarda la possibilità di introdurre «prescrizioni peculiari che governino il periodo di libertà vigilata del soggetto in questione». In effetti, il condannato all’ergastolo “comune” ammesso alla liberazione condizionale è sottoposto per legge alla libertà vigilata, una misura di sicurezza in forza della quale il condannato è soggetto alla sorveglianza dell’autorità di pubblica sicurezza e per la quale sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.
Se il pericolo incombente – nonostante il giudizio di avvenuto ravvedimento del condannato – è quello della possibilità che lo stesso riprenda i contatti con l’associazione di appartenenza o, comunque, con l’ambiente criminale nell’ambito del quale aveva commesso i delitti, è evidente che il legislatore dovrà disegnare obblighi coerenti con la necessità di prevenire questo pericolo.