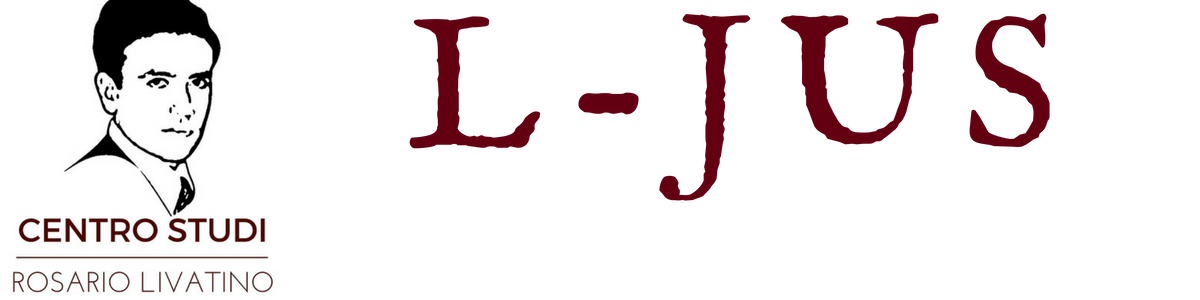Claudio Galoppi
Consigliere uscente del Consiglio Superiore della Magistratura
L’ordinanza emessa dalla Corte di Assise di Milano nell’ambito del procedimento che vede come imputato Marco Cappato solleva questioni di estremo rilievo le quali trascendono il caso in esame e finiscono per chiamare in causa i principi fondamentali del nostro ordinamento.
L’episodio da cui scaturisce il processo è, nella sua dimensione fattuale, assolutamente semplice e del tutto incontestato, e pur nella sua semplicità pone in discussione i principi fondamentali del nostro ordinamento imponendo all’interprete di affrontare, in radice, il rapporto tra l’individuo, i suoi diritti e le sue libertà, e l’organizzazione collettiva in cui lo stesso è inserito con le finalità che la stessa persegue ed i doveri del singolo che rispetto a queste sono strumentali.
L’accadimento naturale, noto a tutti, riguarda la condotta tenuta da Marco Cappato in favore di Fabiano Antoniani, malato irreversibile, ma non terminale, che venne accompagnato dal Cappato in Svizzera allo scopo di sottoporsi, presso una clinica specializzata, ad una procedura di suicidio assistito.
Con l’ordinanza emessa nel corso del procedimento pendente nei confronti di Marco Cappato la Corte di Assise di Milano solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui:
– incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o rafforzamento del proposito di suicidio, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13 comma 1 e 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea Diritti dell’Uomo;
– prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul processo deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25 comma 2 e 27 comma 3 della Costituzione.
Ad avviso dei giudici remittenti, infatti, in forza del combinato disposto degli artt. 3, 13 co. 1 e 117 Cost., quest’ultimo con riferimento agli artt. 2 e 8 CEDU, il suicidio costituisce esercizio di una libertà dell’individuo.
Pertanto solo azioni idonee a pregiudicare l’autodeterminazione dello stesso costituirebbero offesa al bene giuridico tutelato dalla norma in esame, e solo queste risulterebbero meritevoli di sanzione penale; l’art. 580 c.p., viceversa, si presta a dare rilievo penale a condotte di mera partecipazione al suicidio sebbene non idonee a pregiudicare la decisione di chi esercita il proprio diritto a porre fine alla propria esistenza.
Giova rilevare al riguardo come l’art. 580 c.p., secondo l’opinione maggioritaria e la giurisprudenza sul punto (con particolare riferimento all’isolata pronuncia del 1998, nella quale la Corte di Cassazione ha ritenuto che le tipologie di condotte, così come disciplinate, siano previste in via tra loro alternativa), si configuri quale reato a fattispecie alternative volto ad incriminare tre diverse condotte, le quali differiscono le une dalle altre per la diversa incidenza sulla formulazione del proposito suicidario:
– le prime due condotte, che la rubrica colloca entrambe sotto la nozione di istigazione, si distinguono in “determinazione” e “rafforzamento” dell’altrui proposito, indicandosi con la prima qualsiasi condotta idonea a far sorgere in un individuo un proposito prima inesistente, e con la seconda qualsiasi condotta volta al rafforzamento di un’intenzione che, seppur blanda, fosse già presente nell’individuo; tali condotte incidono ed invadono la sfera deliberativa dell’individuo, viziandone la autonomia e spontaneità, sì da costituire contributo causale alla realizzazione dell’evento suicidio;
– la terza condotta, identificata nell’aiuto al suicidio, incrimina invece chiunque ne agevoli in qualsiasi modo l’esecuzione.
Proprio in forza di tale alternatività, qualunque azione agevolativa del suicidio, che possa causalmente risultare connessa all’evento, deve considerarsi idonea ad integrare il reato in quanto condotta di “aiuto” al suicidio, ancorché, come nel caso affrontato dalla Corte di Assise di Milano, estranea in concreto alla formazione del processo deliberativo del soggetto passivo (Cass. pen., sez. I, n. 3147 del 6.2.1998).
Alla base delle norme sull’istigazione e aiuto al suicidio, introdotte dal legislatore del 1930, vi era la considerazione del suicidio come un disvalore ed infatti solo per preminenti ragioni di politica criminale era stato ritenuto inutile e dannoso punirne il tentativo. La sanzione prevista dalla norma era pensata a tutela del diritto alla vita, concepito come valore in sé, indipendentemente dalle deliberazioni del titolare.
La Corte di Assise di Milano parte dalla costatazione che alla luce dei principi costituzionali, risulta necessario mutare quei concetti propri dell’epoca pre-costituzionale.
In particolare, afferma la Corte milanese, dalla lettura complessiva del testo si apprezza una nuova e diversa considerazione del diritto alla vita la quale, sebbene non trovi espressa definizione nel testo costituzionale, si pone come presupposto degli altri diritti riconosciuti all’individuo e attraverso questi si definisce.
Introducendo l’innovativo principio personalistico enunciato all’art. 2 e l’inviolabilità della libertà individuale di cui all’art. 13, la Carta costituzionale ha dunque sancito una vera e propria inversione di rotta: è infatti l’uomo, e non più lo Stato, al centro della vita sociale. Ed è proprio alla luce di tale invertita centralità che la vita umana non può essere concepita in funzione di un finalità eteronoma.
Tale libertà trova, ad avviso dei giudici milanesi, l’ulteriore declinazione di libertà dell’individuo intesa quale libertà da interferenze arbitrarie dello Stato (art. 13).
Di tale diritto costituiscono espressione da un lato «il potere della persona di disporre del proprio corpo»[1], dall’altro l’impossibilità per ogni individuo di essere costretto «a subire un trattamento sanitario non voluto, in assenza di una norma che esplicitamente lo imponga».[2]
Principio quest’ultimo che trova massima espressione nell’art. 32 Cost., il quale, nell’affermare la libertà dell’individuo alla autodeterminazione, intesa quale rifiuto di cure e corrispondente obbligo per l’ordinamento di rispettarne la decisione, pone anche i limiti oltre i quali non può spingersi il potere/dovere dello Stato di intervenire nella tutela della salute dei cittadini, anche nell’ipotesi in cui da tale scelta potesse derivarne la sua morte.
Secondo questa prospettazione, infatti, una conferma della incomprimibilità del diritto alla libertà per finalità eteronome, ovverosia in funzione di obblighi solidaristici, si evince, ancorché implicitamente, dall’assenza di divieti di porre in essere attività pericolose per la propria incolumità ed altresì anche dall’assenza di un obbligo di curarsi (come più volte ribadito con riferimento al rifiuto di emotrasfusioni espresso dai testimoni di Geova[3]).
La stessa giurisprudenza della Corte Edu, evidenzia ancora la Corte rimettente, valorizzando il diritto alla vita ex art. 2 Cedu e le garanzie della persona di fronte ad arbitrarie ingerenze delle pubbliche autorità ex art. 8 Cedu, è di recente giunta «ad affermare il ‘diritto di un individuo di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà’ e [che] l’intervento repressivo degli Stati in questo campo può avere solo la finalità di evitare ‘rischi di abuso’, ovvero di ‘indebita influenza’ nei confronti dei soggetti particolarmente vulnerabili, come sono le persone che hanno perso interesse per la vita».
Tre le pronunce emblematiche del processo evolutivo della giurisprudenza europea:
Pretty c. Regno Unito[4], nella quale la Corte Edu ha affermato: (i) che l’art. 2 Cedu non può essere interpretato – in negativo – nel senso di conferire il diritto di morire, e non può neppure far nascere un diritto all’autodeterminazione circa la scelta se vivere o morire; (ii) che le norme nazionali che puniscono l’aiuto al suicidio non violano l’art. 3 Cedu; (iii) che l’imposizione di un trattamento medico senza il consenso del paziente può costituire una violazione dell’art. 8 Cedu.
Due pronunce successive rappresentano tuttavia un deciso superamento dei predetti principi, atteso che nel corpo delle stesse la Cedu evidenzia un vero e proprio diritto di un individuo di decidere il mezzo ed il momento in cui la sua vita debba finire sempre che il soggetto sia in grado di assumere una decisione libera e pienamente consapevole[5].
Nello stesso senso, ad avviso del giudice rimettente, la recentissima legge sul biotestamento (l. 219/2017), la quale, nella misura in cui riconosce la possibilità di ogni individuo di disporre anticipatamente le proprie volontà sul “fine vita”, evidenzia dunque che, in caso di malattia, il legislatore ha espressamente riconosciuto il diritto a decidere di lasciarsi morire a tutti i soggetti capaci.
Del resto se il mancato riconoscimento da parte del legislatore di un diritto al suicidio assistito, secondo la Corte, implicherebbe l’impossibilità di pretendere dai medici del servizio pubblico la somministrazione o la prescrizione di un farmaco che procuri la morte, non può tuttavia condurre a negare la sussistenza della libertà della persona di scegliere quando e come porre fine alla propria vita, posto che una simile libertà troverebbe fondamento nei principi espressi dagli articoli 2 e 13 della Carta costituzionale.
L’ulteriore censura di legittimità prende le mossa dal profilo sanzionatorio della fattispecie nella misura in cui, laddove si ritenessero rilevanti ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 580 c.p. anche le condotte meramente agevolative, comunque non si giustificherebbe la previsione della medesima cornice edittale prevista per le condotte di istigazione che appaiono certamente più incisive, anche sotto il profilo causale, rispetto alla condotta di chi abbia esclusivamente contribuito al realizzarsi dell’altrui autonoma deliberazione. Pertanto la previsione sanzionatoria della reclusione da 5 a 10 anni risulterebbe incostituzionale per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena.
Ciò premesso deve rilevarsi come, in un’ottica di corretto inquadramento del concetto di eutanasia (per tale intendendosi la cd. “dolce morte” ovverosia una morte indolore), di norma nell’ambito dello stesso vengono raggruppate diverse ipotesi:
1) eutanasia pura: consistente nella morte naturale, resa indolore o meno dolorosa dalla medicina palliativa; fattispecie che non ha mai dato luogo a problematiche dal punto di vista della liceità atteso che lo scopo della medicina moderna non è solo guarire o procrastinare il più possibile la morte bensì anche aiutare il malato non solo a non morire ma più in generale ‘nel morire’ alleviandone le sofferenze;
2) eutanasia passiva consistente nella rinuncia alle terapie medico-chirurgiche le cui problematiche devono essere risolte alla luce dei principi generali in materia di omissione giuridica (ex art.40 comma 2° c.p.); al riguardo si suole distinguere tra:
2.A) eutanasia passiva consensuale, consistente nel rifiuto dell’attivazione o della continuazione di terapie la quale costituiscono non già l’espressione di un diritto al suicidio bensì, unicamente, l’inesistenza dell’obbligo giuridico di curarsi, con la conseguenza che la salute non può essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva; tale tipo di eutanasia deve dunque ritenersi certamente lecita sebbene la stessa ponga, sul piano concreto, la verifica di un valido rifiuto (che sia personale, reale, informato e autentico, profili questi, assai spesso difficilmente ricavabili in concreto);
2.B) eutanasia passiva non consensuale, da ritenersi illecita in quanto attuata nei confronti di un soggetto che abbia espresso la volontà di essere curato ovvero non abbia espresso una volontà di segno contraria; con la conseguenza che il medico ha l’obbligo di attivare o continuare il trattamento terapeutico;
3) eutanasia cd. attiva, consistente nella morte, possibilmente indolore, provocata ed assistita da un comportamento attivo altrui, del malato incurabile, allorché l’evento mortale sia imminente o a non lunga scadenza ed i mezzi antidolorifici risultino impotenti ad attenuare l’intollerabilità o la tormentosità delle sofferenze fisiche: è notoria al riguardo la distinzione tra eutanasia attiva non consensuale (3.A), da qualificarsi alla stregua dei vero e proprio omicidio doloso (premeditato e spesso pluriaggravato) in quanto lesiva del diritto alla vita (per quel che ne residua), del diritto alla autodeterminazione ed il infine del diritto di vivere il proprio morire; (3.B) l’eutanasia attiva consensuale, la quale, come dimostra il caso Cappato, rappresenta il punto focale del dibattito concernente il problema eutanasico e che tuttavia, allo stato, risulta vietata in base al nostro diritto vigente in quanto lesivo del diritto alla vita e tale da superare i limiti oggettivi degli atti dispositivi del proprio corpo (art.5 c.c.).
Ciò rilevato in linea generale deve peraltro osservarsi come certamente problematica appare l’impostazione palesata nell’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale e concernente l’interpretazione restrittiva della condotta agevolatoria del suicidio, laddove si afferma che la norma sanzionerebbe ogni condotta che abbia dato un apporto causalmente apprezzabile ai fini della realizzazione del proposito suicidario.
Sarebbe riduttivo, del resto, ricondurre il contributo dell’imputato, il quale, accordandosi con la vittima, provvide ad organizzarne il viaggio in Svizzera presso la clinica ove si sarebbe svolto il suicidio assistito, come legato al suicidio solo in un’ottica di mero determinismo causale materiale potendosi viceversa rilevare come la condotta dell’imputato abbia costituito anche una forma di rafforzamento della volontà suicida della vittima.
Sulla falsariga di tale argomentazione appare peraltro incentrata la decisione del G.u.p. del Tribunale di Vicenza il quale, in un caso simile (Trib. Vicenza, G.U.P., sent. 14 ottobre 2015, dep. 2 marzo 2016, imp. A. T., in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, fasc. 1), ha ritenuto che la mera condotta di accompagnamento in Svizzera di una persona intenzionata a sottoporsi alla pratica del suicidio assistito, non rientrasse nella fattispecie di cui all’art. 580 c.p., neanche come mera agevolazione materiale, in quanto non «direttamente e strumentalmente connessa all’attuazione materiale del suicidio».
E tuttavia appare evidente come la stessa prospettazione formulata alla vittima da parte dell’imputato, circa la possibilità di recarsi in Svizzera per accedere al suicidio medicalmente assistito, rappresenta inevitabilmente un deciso rafforzamento della volontà di attuare il suicidio così come esso si è poi effettivamente verificato, e dunque, per questa via, lo stesso rappresenta un rafforzamento della volontà di praticare “quel suicidio”.
Né appare configurabile l’esistenza di un “diritto a morire con dignità” quale base dell’operatività di una scriminante per la condotta di Cappato o, comunque, per dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.
La disciplina legislativa in materia di indisponibilità del diritto alla vita, (con particolare riferimento a quanto statuito nel corpo degli artt. 5 c.c. e 579 e 580 c.p.) costituisce l’espressione della chiara volontà del legislatore di limitare al massimo la possibilità per il singolo di disporre della propria integrità fisica e della propria vita.
Se infatti, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 32 c. 2 Cost. (nella lettura fornitane dalla giurisprudenza nei casi Englaro e Welby) appare emergere un diritto a lasciarsi morire per mezzo del rifiuto di un trattamento sanitario, tuttavia il passaggio successivo non appare lecito.
Partendo dalla distinzione naturalistica sussistente tra la condotta di chi lascia che la natura faccia il suo corso – adottando al più terapie palliative e antidolorifiche – e chi attivamente anticipa il momento del decesso, deve ritenersi che partendo dalla premessa di cui sopra, non soltanto non possa ricavarsi un “diritto ad una morte dignitosa”, ma che anzi l’esistenza di un tale diritto sia certamente da escludersi, in quanto privo di un fondamento normativo positivo.
Né, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, appare possibile arguire la presenza di uno specifico obbligo di consentire pratiche di suicidio assistito dovendosi anzi ricostruire (secondo quanto individuato nella citata sentenza Pretty del 2002) la presenza, a livello europeo, di un divieto generalizzato, anche penalmente sanzionato, di aiuto al suicidio con la conseguenza di ritenere che la tematica in questione, anche alla luce del grande numero di Stati europei che prevede analoghi divieti, rientri certamente nel margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati dalla Corte.
La questione di legittimità costituzionale appare peraltro inammissibile.
La Consulta, infatti, ammette la possibilità di integrare la disciplina normativa per mezzo di una pronuncia additiva solo quando l’oggetto del petitum sia a rime obbligate, ossia quando dal dato costituzionale emerga un’indicazione chiara ed univoca circa il contenuto della “legge mancante”, che non lasci spazio alcuno a scelte discrezionali.
Un’eventuale accoglimento della questione porterebbe la Corte ad invadere lo spazio di discrezionalità che il dettato costituzionale lascia al legislatore ordinario, in aperta violazione del principio di divisione dei poteri e delle competenze che la Carta costituzionale attribuisce al giudice delle leggi.
Anche nel merito la censura sollevata dalla Corte appare prestarsi a profili di infondatezza.
Innanzitutto, il concetto di dignità della figura umana invocato quale diritto da bilanciare con il principio di indisponibilità della vita, non trova sufficiente copertura nella giurisprudenza della Consulta, nella quale invece si trovano numerosi richiami al principio di inviolabilità della vita umana.
Inoltre, sempre nell’interpretazione datane dal giudice, la ricostruzione operata nel corpo della questione di costituzionalità appare sollevare una distinzione tra vite “degne” e vite “indegne” che collide totalmente con la tutela incondizionata che tanto la Costituzione quanto la legge ordinaria accordano al bene giuridico vita.
Anche gli altri argomenti appaiono problematici: l’art. 32 c. 2 Cost., infatti, prevede unicamente il diritto a rifiutare ogni trattamento terapeutico, senza che ciò implichi in alcun modo l’esistenza di un diritto ad ottenere aiuto nel compimento del suicidio. Il richiamo alle norme CEDU del resto appare facilmente superabile con la rilevata insussistenza di un espresso diritto ad ottenere assistenza nel suicidio come forma di tutela dell’umana dignità.
Né infine appare possibile argomentale dalla radicale inoffensività di condotte analoghe a quella posta in essere dal Cappato.
Si sostiene infatti che l’art. 580 c.p. non sia volto a tutelare la vita in sé come bene indisponibile, quanto la posizione dei soggetti c.d. “deboli”, cioè esposti al rischio di abusi da parte di coloro che li hanno in custodia; sulla base di tale premessa, l’incriminazione della mera condotta di aiuto al suicidio posta in essere nei confronti di chi, pur gravemente menomato nel fisico, sia pur sempre nel pieno possesso delle sue capacità di giudizio e non sia esposto a condizionamenti o coercizioni sanzioni condotte non lesive del bene giuridico tutelato, e quindi contrasti con il principio di offensività.
E tuttavia deve ritenersi che l’art. 580 c.p. sia una norma volta a tutelare la vita quale bene indisponibile: in tale ottica, nessuna condotta di aiuto al suicidio può mai essere considerata non lesiva del bene giuridico protetto.
Né infine appare lecito dubitare della costituzionalità dell’art.580 c.p. in relazione alla mancata distinzione, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, tra condotte di mera agevolazione dell’esecuzione del suicidio, tali da non incidere sul processo deliberativo dell’aspirante suicida e le ulteriori condotte di istigazione.
Del resto proprio l’ampio spettro sanzionatorio desumibile dai considerevoli limiti edittali della fattispecie delittuosa contestata rende evidente la possibilità per il giudice, anche alla luce del trattamento circostanziale, di calibrare la dosimetria della pena all’effettiva gravità della condotta delittuosa oggetto di contestazione anche in relazione alla maggiore o minore incidenza della stessa sul processo deliberativo dell’aspirante suicida.
Deve infine rilevarsi come, aldilà delle perplessità sopra evidenziate circa le modalità con le quali la questione di costituzionalità è stata sollevata, sussistono argomenti di ordine generale i quali impongo di valutare, de iure condendo, con ancor maggiore perplessità la questione medesima:
- A) il principio di intangibilità della vita umana in quanto valore in sé, e ciò anche in relazione agli altrui interventi soppressivi, atteso che il male derivante dalla perdita del rispetto della vita umana è certamente superiore ai contingenti e fallaci vantaggi; indebolire, nella percezione sociale, il valore della vita, conseguenza diretta di scelte volte a rendere lecito un intervento soppressivo, non solo aprirebbe la via al verificarsi di tragici abusi ma ancor più potrebbe indurre, nel complesso, ad un disimpegno pubblico e più in generale della collettività nell’assistenza ai morienti;
- B) nello stesso senso militano problematiche di ordine pratico estremamente rilevanti atteso: – il rischio di un’ incontentabilità dell’eutanasia pietosa che, attraverso l’incedere di sempre ulteriori passi successivi, possa condurre a dilatare l’ambito di applicazione dell’istituto; – lo svilimento dei continui ed imponenti progressi e sviluppi della medicina palliativa, avvertiti con disinteresse dai movimenti pro eutanasici viceversa favorevoli a scorciatoie più comode e meno costose dell’eutanasia pietosa; – l’estrema difficoltà di accertare la reale consistenza, libera e definitiva, della volontà di morire cui, assai spesso, è sottesa una richiesta di vicinanza o di solidarietà; – una burocratizzazione delle pratiche eutanasiche;
- C) di notevole rilievo le argomentazioni di opportunità laddove si evidenzi che una legittimazione di pratiche eutanasiche condurrebbe, inevitabilmente, ad un intorpidimento della identità, morale e professionale del medico, categoria rispetto alla quale si incrementerebbe un pericoloso aumento di sfiducia;
- D) dal punto di vista fenomenologico-statistico, infine, l’eutanasia attiva, quale diritto al suicidio, appare essere, più che una esigenza sentita dalla collettività, l’espressione di una teorizzazione ideologica assai lontana dalle concrete problematiche della vita di tutti i giorni.
[1] Cfr. Corte cost. n. 471/1990.
[2] Cfr. Corte cost. n. 238/1996 in cui la Corte affermava che gli interventi dello stato in materia di salute coinvolgono «un diritto inviolabile, quello della libertà personale, rientrante tra i valori supremi, quale indefettibile nucleo essenziale dell’individuo, non diversamente dal contiguo e connesso diritto alla vita e alla integrità fisica, con il quale concorre a creare la matrice prima di ogni altro diritto costituzionalmente protetto dalla persona».
[3] Cfr. Corte Cass. sez. 3 n. 4211/2007 e Cass. n. 2367/2008 in cui è stato affermato che alla persona è riconosciuto il diritto «di indubbia rilevanza costituzionale, di non curarsi, anche se tale condizione la esponga al rischio della vita stessa»;
[4] Cfr. Corte EDU, sez. IV, sent. 29 aprile 2002, ric. n. 2346/02, Pretty c. Regno Unito.
[5] Cfr. Corte EDU, sez. I, sent. 20 novembre 2011, ric. n. 31322/07, Pres. Rozakis, Haas c. Svizzera.