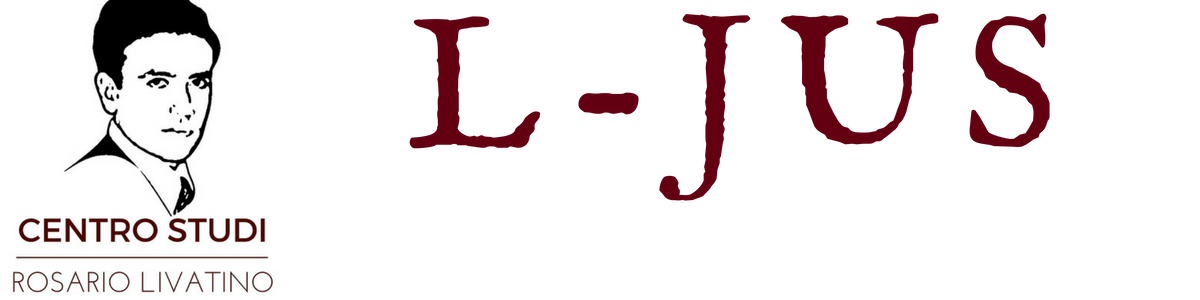Pietro Dubolino
Presidente emerito di sezione della Corte di Cassazione
Sommario: 1. Obiettivo dell’intervento ‒ 2. Che cos’è il “reato di opinione” ‒ 3. I “reati di opinione” nell’ordinamento italiano ‒ 4. La “rieducazione” di cui all’art. 27 Cost. e la sua estraneità rispetto al fine di far mutare i convincimenti ‒ 5. Ddl Zan, rieducazione e libertà di coscienza ‒ 6. Il tratto liberticida dell’art. 5 del ddl Zan.
- Obiettivo dell’intervento
Si cercherebbe invano, nella sterminata produzione dottrinale che ha per oggetto la funzione rieducativa della pena, quale prevista dall’art. 27, comma terzo, della Costituzione, una specifica e approfondita trattazione del problema di come tale funzione possa essere attuata nel caso dei reati c.d. “di opinione”. Lo scopo del presente scritto non è certamente quello di colmare, da solo, una tale lacuna, ma è solo quello di proporre dei motivi di riflessione critica sull’argomento, nella speranza che essi possano servire da stimolo per ulteriori sviluppi da parte di chi ne avverta l’interesse, anche in vista dell’eventuale riproposizione del ddl Zan sulla “omotransfobia”, pur dopo la decisione di non passaggio al voto da parte del Senato.
- Che cos’è il “reato di opinione”
Per affrontare il suddetto problema occorre in primo luogo interrogarsi su ciò che debba intendersi per “reato di opinione”[1]. Al riguardo sembra potersi ritenere, in via di prima approssimazione, che elementi rivelatori del “reato di opinione” siano, per un verso, la previsione come reato di una condotta costituita appunto dalla manifestazione di una “opinione”; per altro verso, il fatto che tale manifestazione sia punita solo ed esclusivamente per il suo intrinseco contenuto, volendosi dal legislatore impedire che esso, siccome ritenuto in sé e per sé inaccettabile rispetto a un determinato sistema di valori, pregiudizialmente assunto come proprio dell’ordinamento statuale, sia portato a conoscenza di altri soggetti i quali possano essere quindi essere indotti, per ciò solo, a condividerlo[2].
Ciò vale a distinguere tali reati da altri (pur comunemente ritenuti anch’essi “di opinione”), quali, ad esempio, l’istigazione a delinquere, prevista, in via generale, dall’art. 414 cod. pen. e, con specifico riguardo a pratiche di pedofilia, dall’art. 414 bis cod. pen. Questo perché in tali reati il disvalore è dato non dalla istigazione in sé, quale frutto di una determinata opinione nutrita dall’agente, ma dalla natura penalmente illecita, a prescindere dalle motivazioni, delle condotte materiali di cui, con l’istigazione, viene incoraggiata e promossa l’attuazione a opera di altri. Il che vale anche con riguardo all’istigazione di militari a disobbedire alle leggi, prevista dall’art. 266 cod. pen., giacché, dovendosi intendere, per “leggi”, quelle che stabiliscono gli obblighi alla cui osservanza i militari, in quanto tali, sono specificamente tenuti a prestare obbedienza, l’inosservanza, da parte loro, di tali obblighi dà luogo, generalmente, alla configurabilità di reati appositamente previsti dai codici penali militari.
Analogamente, non dovrebbe qualificarsi, a rigore, come “reato di opinione” neppure quello di istigazione a commettere «atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi» previsto dall’art. 604 bis, comma primo, lett. a), seconda parte, cod. pen., (riproduttivo dell’identica previsione già contenuta nell’abrogato art. 3 della legge n. 654/1975, quale riformulato dall’art. 1 del D.L. n. 122/1993 conv. con modif. in legge n. 205/1993), atteso che anche in questo caso assumerebbe rilievo la natura penalmente illecita della condotta materiale oggetto dell’istigazione, costituita dalla commissione degli atti di discriminazione[3].
In proposito vi è però da osservare che questi ultimi, qualora vengano posti in essere per motivi diversi da quelli sopraindicati, non costituiscono reato. Il che potrebbe indurre a ritenere che si sia in presenza di un illecito che, seppure non annoverabile fra i “reati di opinione” propriamente detti, sia tuttavia in una qualche misura a essi assimilabile, come reato, per così dire, “da opinione”, avuto riguardo alla peculiarità del fatto che, contrariamente alla regola per la quale i motivi che spingono l’agente a porre in essere una determinata condotta assumono rilievo solo ai fini dell’aggravamento o dell’attenuazione di un reato che, in presenza di quella condotta, è comunque configurabile (cfr. per esempio art. 61, n. 1, e 62 n. 1 cod. pen.) nel caso degli atti di discriminazione i motivi, quando siano quelli previsti dalla norma incriminatrice, assurgono, in modo del tutto anomalo, al rango di elementi costitutivi del reato, conferendo quindi a quest’ultimo la loro stessa connotazione puramente “ideologica” . E ad analoga conclusione sembra potersi giungere per il reato previsto dal secondo comma dell’art. 604 bis cod. pen., che vieta, prevedendo poi le relative sanzioni a carico di partecipi, promotori e dirigenti, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo che abbia tra i suoi scopi l’incitamento alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Il carattere di reati di opinione sembra pure da escludere, poi, con riguardo ai reati di offesa al capo dello Stato, di vilipendio delle istituzioni e delle forze armate (salvo quanto si dirà a proposito delle forze della Liberazione, ad esse equiparate nella tutela penale), come pure con riguardo ai reati di ingiuria (ora, peraltro, depenalizzato) e di diffamazione. Questi reati, infatti, pur essendo costituiti anch’essi, nella sostanza, dalla manifestazione di “opinioni”, sono caratterizzati dal fatto che tale manifestazione non è fine a sé stessa, come lo sarebbe se fosse diretta soltanto a esprimere il rifiuto di determinati valori astrattamente assunti come propri dall’ordinamento, ma comporta, come risultato la concreta lesione di beni giuridici che, per la loro oggettiva e riconoscibile importanza nell’ambito di una ordinata convivenza civile, il legislatore ha inteso espressamente tutelare.
Tali beni sono costituiti, in particolare, nelle ipotesi dell’offesa al Capo dello Stato e del vilipendio delle istituzioni e delle forze armate, dalla credibilità e dal prestigio di cui l’uno e le altre debbono essere circondati, sì da richiedere, per la loro stessa funzionalità, che nei loro confronti si osservi sempre e da parte di chiunque un doveroso rispetto; nelle ipotesi dell’ingiuria e della diffamazione, dall’onore, dal decoro e dalla reputazione delle persone offese, la cui lesione non può lasciare del tutto indifferente l’ordinamento statuale, a pena, altrimenti, dell’insorgere del pericolo che “cives ad arma veniant”. Resta salva, naturalmente, la possibilità che, con riguardo a tutti i suddetti reati, trovi applicazione la scriminante costituita dal legittimo esercizio del diritto di critica; scriminante che, invece, non è, ovviamente, invocabile quando, pur trattandosi ancora di vilipendio, questo abbia ad oggetto entità astratte (come la Repubblica o la Nazione italiana) ovvero oggetti-simbolo, quali la bandiera. Il che potrebbe rendere non troppo azzardata l’affermazione che, in linea di principio, la qualificazione di un reato come “reato di opinione” sia da escludere ogni qual volta, con riguardo ad esso, sia ipotizzabile l’operatività della scriminante in questione.
Parimenti, appare da escludere che possano essere ritenuti “reati di opinione” quelli di offesa ad una confessione religiosa mediante vilipendio di persone (art. 403 cod. pen.) o mediante vilipendio o danneggiamento di cose (art. 404 cod. pen.), come pure quello di turbamento di funzioni religiose (art. 405 cod. pen.). Ciò in quanto le condotte descritte nelle norme incriminatrici hanno a oggetto immediato persone o cose o situazioni concrete, la cui tutela giuridica da parte dell’ordinamento non si fonda sulla previa assunzione di una determinata confessione religiosa come propria dello Stato (diversamente da quanto si verificava con riguardo al reato di vilipendio alla religione dello Stato, previsto dall’art. 402 cod. pen. e dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 508/2000).
Essa appare piuttosto riconducibile al disposto di cui all’art. 19 della Costituzione, che garantisce a chiunque il «diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume»; garanzia, questa, che, al pari delle altre pure contenute nella Costituzione (a partire da quella riguardante, in generale, “i diritti inviolabili dell’uomo” , prevista dall’art. 2, per giungere a quelle riguardanti la libertà personale, il domicilio, la corrispondenza, la libertà di circolazione, di riunione, di associazione, previste dagli art. 13-18), non si pone soltanto come ostacolo ad ingiustificati interventi coercitivi o limitativi da parte dello Stato, ma giustifica, anche, o addirittura impone, che sia lo stesso Stato ad assumere su di sé il compito di impedire, anche mediante la previsione di sanzioni penali, che i diritti garantiti alla generalità dei cittadini siano, da qualcuno di essi, lesi o posti in pericolo.
- I “reati di opinione” nell’ordinamento italiano
Alla stregua delle suesposte considerazioni, dovrebbe quindi, in linea di principio, escludersi che in un ordinamento di tipo liberal-democratico, quale deve fondamentalmente ritenersi quello delineato nella Costituzione italiana (sia pure con le sue forti componenti di natura solidaristica), possano avere diritto di cittadinanza veri e propri “reati di opinione”[4].
In realtà, però, le cose stanno diversamente. Anche nell’ordinamento italiano, infatti, sono presenti figure di reato nelle quali la condotta punibile è costituita soltanto dalla pura e semplice manifestazione di opinioni, considerata dal legislatore di per sé pericolosa per il solo fatto che esse possano essere condivise, indipendentemente dalla riscontrata esistenza di condizioni nelle quali sia ragionevolmente prevedibile che, in concreto, dall’astratta condivisione si passi al compimento di azioni costituenti a loro volta reato. È il caso, in particolare, del reato di cui al già ricordato art. 604 bis cod. pen. (già art. 3 della legge n. 654/1975, riformulato dall’art. 1 del D.L. n. 122/1993 conv. con modif. in legge n. 205/1993), nella parte in cui, al comma 1, lett. a), prima ipotesi, si riferisce alla condotta di chi “propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico”. Appare evidente che, nella visione del legislatore, il fatto che tali idee vengano propagandate e, quindi, diffuse, genera di per sé solo una situazione di pericolo per prevenire la quale, quindi, si rende necessario ricorrere alla minaccia della sanzione penale.
Reati di opinione possono essere considerati, poi, per le ragioni dianzi accennate, quelli di vilipendio della Repubblica, della Nazione italiana e della bandiera nazionale, il cui oggetto viene ritenuto, dal legislatore, meritevole di tutela sulla sola base di determinate valutazioni politiche, da considerarsi, in quanto tali, per loro natura, opinabili. Del pari, può essere considerato reato di opinione quello di vilipendio delle forze della Liberazione, previsto dall’art. 290 cod. pen. unitamente a quello delle Forze armate, giacché, a differenza di queste ultime, le forze della Liberazione non svolgono, nell’attualità, alcuna funzione pubblica, per cui è soltanto la loro memoria storica quella che il legislatore ha inteso preservare da giudizi dissacratori.
Altri esempi di reati di opinione possono essere costituiti, inoltre, dai reati di apologia: apologia di reato, prevista dall’art. 414, comma terzo, cod. pen.; apologia del fascismo, prevista dall’art. 4, comma secondo, della legge n. 645/1952; apologia di genocidio, prevista dall’art. 8, comma secondo, della legge n. 962/1967. Con riguardo all’apologia di reato, per la verità, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che essa in tanto può ritenersi punibile in quanto la condotta posta in essere dall’agente abbia «la concreta capacità di provocare l’immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, la probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimo» (Cass. I, 17 novembre – 15 dicembre 1997 n. 11578, Rv 209140).
Con il che, in buona sostanza, l’apologia viene di fatto ricondotta alla figura dell’istigazione, come, del resto, era già stato affermato da Cass. I, 11 giugno – 3 dicembre 1986 n. 13541, secondo cui le due figure si distinguono soltanto per il fatto che «nell’ipotesi di “istigazione” la spinta al reato è diretta alla persona, mentre nell’ipotesi di “apologia” la spinta è indiretta, essendo affidata al contenuto apologetico, che può, peraltro, produrre i medesimi risultati dell’istigazione diretta».
Analogamente, con riguardo all’apologia del fascismo, si è affermato che essa può costituire reato soltanto «se posta in essere con una condotta idonea a favorire la concreta possibilità di riorganizzazione del partito fascista, vietata dalla Costituzione repubblicana» (Cass. II, 23 maggio – 22 dicembre 1979 n. 11106, Rv 143745).
Si tratta di interpretazioni all’origine delle quali può facilmente riconoscersi la preoccupazione di fugare quelli che altrimenti potrebbero essere fondati dubbi di illegittimità delle norme in questione per violazione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero garantito dall’art. 21 della Costituzione. Non a caso, infatti, esse trovano il loro antecedente nella fondamentale sentenza n. 65/1970 della Corte costituzionale, con la quale si dichiarava non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 414, ultimo comma, cod. pen., sulla base, nell’essenziale, della considerazione che l’apologia punibile è soltanto «quella che per le sue modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti».
Tali interpretazioni, tuttavia (ancorché, per la detta ragione, condivisibili) non possono valere ad escludere la qualificabilità dei reati di apologia come reati di opinione, atteso che, ai fini della configurabilità degli stessi, è necessario e sufficiente che l’agente manifesti una sua opinione con l’intento di farla conoscere ad altri perché la condividano, senza che egli debba anche proporsi, come ulteriore finalità, quella che dalla condivisione si generi poi l’impulso a porre in essere un determinato tipo di azioni; effetto, questo, che, se ed in quanto ritenuto necessario perché possa dirsi che il reato è stato realizzato, potrebbe in qualche modo farsi rientrare nel novero di quelle che, in dottrina, vengono definite come condizioni obiettive di punibilità.
- La “rieducazione” di cui all’art. 27 Cost. e la sua estraneità rispetto al fine di far mutare i convincimenti
Passando ora all’esame di ciò che, ai fini di cui all’art. 27, comma terzo, della Costituzione, deve intendersi per “rieducazione”, appare oggi generalmente condiviso il principio che la “rieducazione”, quale che sia la sua collocazione nell’ambito della nozione c.d. “polifunzionale” della pena (sostenuta, oltre che dalla dottrina dominante, anche dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità), non può avere come obiettivo quello di produrre un mutamento degli intimi convincimenti morali del soggetto, i quali siano o possano essere stati, in ipotesi, all’origine delle scelte delinquenziali, giacché una tale finalità si porrebbe in contrasto con il diritto di ciascuno, in un ordinamento democratico e ispirato al pluralismo come è quello italiano, al rispetto della propria libertà di coscienza.
L’obiettivo della “rieducazione”, quindi, in una tale visione, non potrebbe che essere quello di una “risocializzazione” del soggetto, intesa, tuttavia, non solo e non tanto come un suo reinserimento nel contesto sociale, quando la scelta delinquenziale sia dipesa da una situazione di emarginazione dovuta a cause di natura socio-economica (giacché in tal modo non vi sarebbe spazio per la rieducazione nel caso di condanna per reati commessi da chi sia già socialmente ed economicamente ben collocato), ma anche e soprattutto come acquisizione del convincimento che, in una ordinata e pacifica convivenza sociale, gli obblighi e i divieti previsti dalle norme penali debbono essere osservati per il solo fatto che esistono[5].
Al riguardo potrebbe però osservarsi, in primo luogo, che la radicale esclusione di ogni riferibilità della rieducazione a una revisione delle intime e personali visioni etiche del soggetto, solo perché altrimenti risulterebbe violato il dovuto rispetto alla sua libertà di coscienza, non considera che esiste un nucleo di regole morali tradizionalmente definite “naturali”, riassumibili nella nota definizione di Ulpiano honeste vivere, alterum non laedere, suum unicuique tribuere, la cui osservanza è stata ed è generalmente ritenuta imprescindibile nell’ambito di ogni consorzio civile, indipendentemente da qualsiasi scelta religiosa o politica del singolo soggetto. E alla violazione di tali regole è associata, a ben vedere, la configurabilità della maggior parte dei reati previsti dall’ordinamento giuridico, ivi compresi quelli tradizionalmente definiti da “colletti bianchi”, rimanendone esclusi, in ultima analisi, proprio i soli reati riconducibili, sulla base dei criteri precedentemente illustrati, alla categoria dei “reati di opinione” (da intendersi, peraltro, d’ora in avanti, come comprensiva anche di quei reati che, come si è visto, possono ritenersi ad essi, in qualche modo, assimilabili).
Ragion per cui, quando la rieducazione sia diretta a far sì che il soggetto resosi responsabile di un reato che non sia “di opinione” acquisti o riacquisti la consapevolezza dell’assoluta necessità che quelle regole siano rispettate non può in alcun modo ritenersi che ciò costituisca un tentativo di violazione della sua libertà di coscienza. Il rispetto dovuto a quest’ultima, infatti, deve comunque conciliarsi con le esigenze minime di sopravvivenza della convivenza sociale, fermo restando, com’è ovvio, il divieto che, anche quando l’obiettivo della rieducazione sia quello summenzionato, si faccia ricorso a metodi o strumenti lesivi della dignità del soggetto o della sua integrità fisio-psichica. E ciò a prescindere, naturalmente, dal discorso più generale e tutt’affatto diverso (che non è qui il caso di affrontare) circa la effettiva possibilità che un miglioramento delle qualità morali di un soggetto possa essere efficacemente perseguito mediante l’uso (quale che esso possa essere) di uno strumento come la pena, che, per sua natura, non può non essere, in maggiore o minore misura, necessariamente afflittiva.
Può osservarsi, in secondo luogo, che far consistere l’obiettivo della rieducazione, specie quando si tratti di soggetti già ben inseriti nel contesto socio-economico, nella pura e semplice acquisizione del convincimento che, in sostanza, “non conviene” violare la legge penale, significa che quell’obiettivo viene a coincidere, di fatto, con quello tradizionale della intimidazione, ottenuta mediante la implicita minaccia, con l’applicazione della pena, di una reiterazione di quest’ultima a fronte della eventuale reiterazione del reato[6]. Per ottenere un tale risultato non sarebbe stato certo necessario dettare l’art. 27, comma terzo, della Costituzione, se non (forse) nella parte in cui esso si limita a imporre il divieto di pene che siano contrarie al senso di umanità.
- Ddl Zan, rieducazione e libertà di coscienza
Venendo finalmente ad affrontare il problema della funzione rieducativa della pena con specifico riferimento ai soli reati qualificabili come “reati di opinione”, va anzitutto osservato che esso sembra potersi porre soltanto quando la pena prevista sia quella detentiva, atteso che appare assai arduo attribuire, in generale, alla pena pecuniaria (quale, ad esempio, attualmente prevista per la maggior parte dei reati di vilipendio) una funzione diversa da quella meramente afflittiva[7].
Ciò premesso, occorre partire dal seguente interrogativo di fondo: la rieducazione deve puntare a far sì che il soggetto si renda conto che le opinioni che hanno portato alla sua condanna “non sono giuste”, ovvero a far sì che si renda conto che “non conviene manifestarle”?
Nella prima ipotesi si salva la funzione precipua della “rieducazione”, ma sicuramente, stavolta, proprio a prezzo di quella stessa “libertà di coscienza”, il cui rispetto, come si è visto, la dottrina corrente ritiene ostativo a una concezione della rieducazione per la quale quest’ultima dovrebbe tendere a una modifica in meglio degli intimi convincimenti del condannato in materia morale e, a maggior ragione, ideologica e politica; ostatività, quella anzidetta, che non può certamente dirsi esclusa per il solo fatto che (sempre secondo la dottrina corrente) quello della rieducazione è solo un obiettivo “tendenziale” che deve quindi lasciar libero il soggetto di aderirvi o meno[8]. Di contro, infatti, sembra potersi affermare che, a rigore, già il solo tentativo di condizionare gli orientamenti morali, ideologici o politici di un soggetto sottoposto a privazione della libertà personale da parte della stessa autorità statale dalla quale quella privazione viene imposta ben può essere considerato come un attacco alla sua libertà di coscienza, quali che siano le modalità, più o meno “soft”, con le quali il medesimo tentativo viene attuato.
Nella seconda delle suddette ipotesi, come pure si è visto, la funzione della rieducazione si riduce a quella della intimidazione, annullandosi quindi in essa. E non sembri troppo azzardato dire che ciò potrebbe portare a un giudizio di incostituzionalità di tutti i “reati di opinione”, proprio a cagione della inapplicabilità “a priori”, con riguardo ad essi, di un principio che la Costituzione implicitamente prevede come insuscettibile di deroga alcuna, dal momento che non risulta in alcun modo contemplata l’eventualità che esistano reati per i quali, a parità del tipo di pena previsto, la rieducazione (in senso proprio) dei colpevoli non possa neppure essere tentata[9].
Così delineate quelle che, in astratto, appaiono le due possibili linee d’indirizzo interpretativo, deve però a questo punto osservarsi che esistono già chiari segni di una preoccupante tendenza del legislatore ad aderire alla prima di esse, almeno quando i “reati di opinione” (o ad essi assimilabili) siano di un certo tipo. Assai indicativo appare, infatti, al riguardo, il disposto di cui all’art. 1, comma 1 bis, lett. a), del D.L. n. 122/1993, conv. con modif. in legge n. 205/1993 (c.d. “legge Mancino”), in base al quale, nel caso di condanna per uno dei reati già previsti dall’art. 3 della legge n. 654/1975 (ora trasfuso, come si è visto a suo luogo, nell’art. 604 bis cod. pen.) o per uno dei reati previsti dalla legge n. 962/1967 (tra cui, in particolare, figura, come pure si è visto, quello di apologia di genocidio), può essere imposto al condannato, a titolo di “sanzione accessoria”, l’ «obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1 ter»; attività non retribuita che, secondo quanto stabilito, nella parte che appare di maggior interesse, dal successivo comma 1 quinquies (oltre che, pressoché negli stessi termini, dal D.M. 4 agosto 1994 n. 569, emanato ai sensi del citato comma 1 ter), può consistere in «prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da hiv, portatori di handicaps, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari».
Ora, appare di tutta evidenza che l’obbligo in questione, nella visione del legislatore, altro non è se non uno strumento di “rieducazione” del condannato nel senso proprio del termine, essendo volto a far sì che, mediante il contatto prolungato (e, per giunta, in posizione subordinata quale prestatore di lavoro), con organismi o enti necessariamente scelti in funzione del loro orientamento ideologico-politico opposto a quello del medesimo condannato, quest’ultimo si senta indotto a rimettere in discussione fino, possibilmente, a ripudiarli, i convincimenti che hanno dato luogo alla commissione del reato. E ciò trova conferma, in particolare, considerando che, fra gli organismi o enti in questione, sono specificamente indicati quelli che operano nei confronti degli extracomunitari. Gli stranieri extracomunitari, infatti, individualmente o come categoria, sono coloro che, quasi sempre, vengono assunti come occasione o pretesto per la propaganda di “idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale” o come oggetto di discriminazione per “motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Nulla di più naturale, quindi, che il colpevole di tali reati venga affidato, nella speranza che riveda il suo modo di pensare, a quanti si adoperano perché agli stranieri extracomunitari venga riservata generosa ed amichevole accoglienza.
- Il tratto liberticida dell’art. 5 del ddl Zan
Appare, peraltro, assai singolare e frutto, con ogni evidenza, di una ben precisa scelta ideologico-politica il fatto che tra tutti i reati qualificabili come “reati di opinione” o ad essi assimilabili, il legislatore abbia preso in considerazione soltanto quelli previsti dalla “legge Mancino” per predisporre uno specifico meccanismo sanzionatorio, aggiuntivo alla pena vera e propria e finalizzato, come si è appena visto, alla rieducazione dei colpevoli. Tale meccanismo dovrebbe, ovviamente, essere mantenuto, nelle intenzioni dei promotori del noto ddl Zan contro la c.d. “omotransfobia”, anche con riferimento alla proposta, nuova formulazione dell’art. 604 bis che dovrebbe prevedere, in aggiunta ai «motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi» che rendono attualmente punibile la commissione e l’istigazione a commettere atti di discriminazione, anche quelli «fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere».
L’operatività del medesimo meccanismo dovrebbe, inoltre, essere estesa (sempre secondo il suddetto ddl Zan), anche al caso di condanna per reati diversi da quelli previsti dall’art. 604 bis cod. pen, quando gli stessi siano aggravati i sensi dell’art. 604 ter (già art. 3 del D.L. n. 122/1993, conv. con modif. in legge n. 205/1993), essendo stati commessi, secondo l’attuale formulazione della norma, «per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità»; formulazione, questa, la quale dovrebbe essere integrata con l’aggiunta delle parole: «oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità».
E ancora, l’elenco delle organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato in favore delle quali andrebbe imposto al condannato l’obbligo di prestare un’attività non retribuita andrebbe completato con l’indicazione di quelle operanti «a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale». Con il che la finalità “rieducativa” dell’obbligo in questione risulterebbe, se possibile, ancor più accentuata, associandosi ad essa una sorta di anomala finalità risarcitoria in incertam personam, da realizzarsi mediante la forzata collaborazione con organismi ed enti i quali abbiano come loro obiettivo la riparazione, per quanto possibile, delle negative conseguenze patite da chiunque risulti essere stato vittima di taluno dei suddetti reati, indipendentemente dalla ascrivibilità dello stesso alla responsabilità del condannato o di altri soggetti.
Tutto questo, naturalmente, nelle intenzioni dei legislatori, a proposito delle quali, però, mai come in questo caso sembra potersi ripetere l’antico detto secondo cui di buone intenzioni (ammesso che tali possano essere ritenute quelle in discorso) “è lastricata la via dell’inferno”; un inferno che, a seconda dei punti di vista, potrebbe essere costituito o dal totale fallimento delle finalità rieducative (quale facilmente ipotizzabile in tutti i casi in cui esse siano perseguite con modalità sostanzialmente coercitive, non di rado produttive, in quanto tali, di risultati diametralmente opposti a quelli auspicati); ovvero proprio dalla realizzazione, almeno apparente, di quelle stesse finalità, ma a prezzo, necessariamente, di una lettura dell’art. 27, comma terzo, della Costituzione, da considerarsi pericolosissima, quando riferita ai “reati di opinione”, per le sue evidenti connotazioni liberticide.
* Contributo accettato dalla Direzione per il comprovato prestigio scientifico dell’Autore.
[1] Per una esauriente trattazione del tema, con ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, si veda, per tutti, fra gli AA. più recenti, A. Spena, Libertà di espressione e reati di opinione, Riv. it. dir. proc. pen., Milano, 2007, pp. 689-738.
[2] Analogo appare l’orientamento espresso da A. Spena, op. cit, p. 693, per il quale caratteristica dei reati di opinione è quella che «la condotta illecita è fatta consistere proprio nell’espressione di una certa opinione, a prescindere da ogni ulteriore proiezione esterna della condotta espressiva: le incriminazioni hanno ad oggetto il mero fatto dell’espressione di un contenuto valutativo, senza che sia richiesta, ai fini della punibilità, l’obiettiva capacità (della condotta) o la subiettiva intenzione (dell’agente) di provocare nel mondo esterno alcunché di diverso dalla mera ricezione del messaggio valutativo espresso. La condotta, da parte del legislatore, è assunta dal punto di vista del contenuto valutativo del messaggio espresso, e non degli eventuali ulteriori effetti che l’espressione del messaggio ha, o può avere, nel mondo esterno». Ed ancora, secondo lo stesso A., p. 696, «sono reati di opinione quelli in cui una condotta è presa in considerazione dal legislatore solo in quanto espressione, verbale o comportamentale, di un’opinione turbativa della sacralità concettuale di certi valori morali sovra-individuali o di una sensibilità collettiva rispetto a valori morali».
[3] Per atti di discriminazione debbono intendersi, secondo la definizione datane dalla Convenzione di New York del 7 marzo 1966, recepita in Italia con la legge n. 654 del 1975, quelli costituiti da «ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento , il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica».
[4] Ad analoga conclusione perviene anche A. Spena, op. cit., p. 724, secondo cui l’incriminazione per un reato di opinione sarebbe per sua natura in contrasto con l’art. 21 della Costituzione.
[5] Si vedano, in proposito, per tutti, F. Mantovani, Diritto penale, parte generale, 2020, p. 796 ss.; G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, parte generale, 1993, p. 521 ss.; G. Fiandaca, Commento all’art. 27, comma 3°, Cost., in Commentario alla Costituzione, a cura di Branca e Pizzorusso, Bologna, 1991, p. 277 ss., al quale ultimo, in particolare, si rimanda per la completezza, a tutt’oggi insuperata, della trattazione, in generale, dell’istituto in questione in tutti i suoi aspetti, con amplissime note di richiamo a dottrina e giurisprudenza.
[6] Tale appare, in effetti, la conclusione alla quale giungono, ad esempio, anche C.F. Grosso – M. Pelissero – D. Petrini – P. Pisa, Manuale di diritto penale, parte generale, Milano, 2017, p. 601, per i quali, quando trattisi di «soggetti che sono perfettamente inseriti nelle dinamiche sociali……la funzione rieducativa della pena si realizza attraverso l’intimidazione, in quanto l’intimidazione della pena deve servire di stimolo per il recupero del rispetto degli interessi lesi dal reato». Non dissimile, in un più remoto passato, la posizione di P. Nuvolone, voce Pena (dir. pen,) in Enc. Dir., Milano, 1982, p. 791, secondo cui: «anche lo stimolo all’emenda che può derivare dall’inflizione di una pena può essere considerato nella prospettiva della rieducazione. Bisogna tener conto, infatti, che il concetto di “rieducazione” non coincide con quello di “risocializzazione”».
[7] Al riguardo, mette conto richiamare quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 12/1966, nella quale, a sostegno della ritenuta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale della pena pecuniaria, proprio per la sua inidoneità a costituire strumento di rieducazione del condannato, si puntualizza che, con l’art. 27, comma III, della Costituzione, «si volle che il principio della rieducazione del condannato, per il suo alto significato sociale e morale, fosse elevato al rango di precetto costituzionale, ma senza con ciò negare la esistenza e la legittimità della pena là dove essa non contenga, o contenga minimamente, le condizioni idonee a realizzare tale finalità. E ciò, evidentemente, in considerazione delle altre funzioni della pena che, al di là della prospettiva del miglioramento del reo, sono essenziali alla tutela dei cittadini e dell’ordine giuridico contro la delinquenza, e da cui dipende la esistenza stessa della vita sociale». Con il che viene, sostanzialmente, ammesso che la pena pecuniaria non possa, per sua natura, avere, di regola, alcuna finalità rieducativa, senza per ciò, tuttavia, essere in contrasto con la Costituzione. Peraltro, è stato anche sostenuto, da autorevole dottrina (G. Fiandaca, Commento, cit., p. 314, che, rinunciando a «identificare la rieducazione col trattamento volto a risocializzare il condannato» e «assumendo, invece, il concetto di rieducazione nella accezione più generale di acquisita consapevolezza dei valori disattesi col comportamento trasgressivo, è difficile negare ‒ come, seppur timidamente, ammette la stessa Corte costituzionale ‒ che la stessa inflizione di una sanzione di natura pecuniaria può incidere sul reo nel senso di indurlo al rispetto dei beni protetti».
[8] Cfr. sul punto, fra gli altri: G. Fiandaca – E. Musco, op. cit., p. 523, secondo cui “l’obiettivo tendenziale” della rieducazione in tanto è perseguibile in quanto “il reo sia disposto a collaborare”; P. Pittaro, Art. 27 Cost., in Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole – R. Bin, Milano, 2008, p. 27, secondo cui, «nello stato sociale di diritto, laico e pluralista”, la rieducazione rappresenta un’opportunità di recupero sociale offerta al reo, che può accettarla o meno, ed il cui obiettivo non è l’adesione a concezioni particolari della convivenza, ma solo quello di fare il possibile perché costui, nel futuro, non violi nuovamente la legge penale».
[9] La prospettata ipotesi di incostituzionalità non si pone in contrasto con i presupposti sui quali si fonda la sentenza della Corte costituzionale richiamata nella precedente nota (7), atteso che un conto è ritenere non contrario alla Costituzione che esistano pene diverse da quelle detentive le quali, come la pena pecuniaria, senza essere contrarie al senso di umanità, non siano tali, tuttavia, da favorire la rieducazione del condannato; altro conto è ammettere che la stessa pena detentiva possa essere o non essere finalizzata alla rieducazione a seconda del tipo di reato per il quale sia stata inflitta.