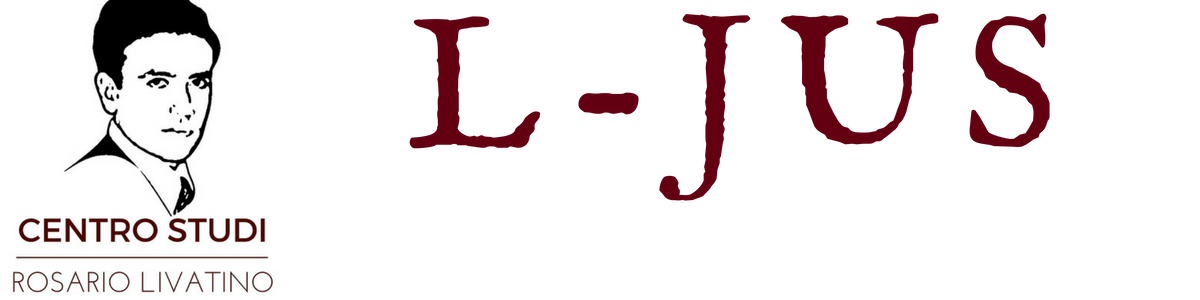Giacomo Rocchi
Consigliere della Corte di Cassazione
La tutela della vita
nell’ordinamento giuridico italiano.
La questione del fine vita*
Sommario: 1. Un lapsus rivelatore: i giudici negano la realtà naturale – 2. Il diritto lontano dalla realtà naturale nelle questioni di “fine vita” – 3. Formule giuridiche che nascondono la realtà – 4. La legge sul consenso informato: la morte procurata sottratta al mondo del diritto – 5. Il rifiuto libero e informato delle terapie salvavita: una finzione – 6. Vite “non degne” e legalizzazione dell’eutanasia dei soggetti deboli – 7. Rispettare il dato naturale e la Costituzione.
- Un lapsus rivelatore: i giudici negano la realtà naturale
«La concezione della vita come oggetto di tutela, da parte dell’ordinamento, in termini di ‘sommo bene’, di alterità normativa superiorem non recognoscens, (…) è percorsa da forti aneliti giusnaturalistici, ma è destinata a cedere il passo al raffronto con il diritto positivo.
Decisiva appare, difatti, la considerazione secondo cui, al momento stesso in cui l’ordinamento giuridico riconosce alla madre il diritto di abortire, sia pure nei limiti e nei casi previsti dalla legge, si palesa come incontestabile e irredimibile il sacrificio del ‘diritto’ del feto a venire alla luce, in funzione non soltanto della tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, ma dello stesso diritto alla salute fisica o anche soltanto psichica della madre. Mentre non vi sarebbe alcuno spatium comparationis se a confrontarsi fossero davvero, in una comprovata dimensione di alterità soggettiva, un superiore diritto alla vita e un (“semplice”) diritto alla salute mentale».
Prendo l’avvio da questo passo della motivazione di una nota sentenza della Cassazione civile (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16754 del 02/10/2012, Rv. 623595) che, contrapponendo la legge positiva agli “aneliti” giusnaturalistici e qualificando la vita degli uomini non più “sommo bene”, ma come valore nella misura in cui è permessa o negata dal legislatore, giunse a riconoscere il diritto al risarcimento da nascita indesiderata di una bambina down alla stessa bambina, danneggiata per essere nata, su questo punto successivamente smentita dalle Sezioni Unite.
Mi soffermo ancora un attimo su quella pronuncia – benché mi sia stato assegnato l’argomento del diritto alla vita nella fase conclusiva dell’esistenza, con riferimento al contenuto della legge 219 del 2017 sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento – in quanto in essa si rinviene un altro passaggio, apparentemente frutto di un lapsus: nel rammentare la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 1975, che aveva depenalizzato l’aborto volontario, ne riportava il passaggio fondamentale apportando, però, una significativa modifica. La Corte costituzionale aveva statuito: «non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare»; secondo la Cassazione, invece, sulla base del «magistrale insegnamento della Corte costituzionale», «sarà compito di un essere umano (la madre) già vivente assicurare tutela a chi essere umano deve ancora diventare».
L’abbandono degli “aneliti giusnaturalistici” a favore del diritto positivo porta rapidamente i giudici a non riconoscere più la realtà naturale sottostante e a negare l’esistenza stessa della vita umana e, di conseguenza, l’evento della sua soppressione.
- Il diritto lontano dalla realtà naturale nelle questioni di “fine vita”
Mi sembrano considerazioni legittime anche con riferimento all’ampio tema della tutela della vita nella fase finale dell’esistenza, in quanto la divaricazione tra la disciplina giuridica e la realtà naturale sottostante presenta aspetti eclatanti.
In effetti, non possiamo non chiederci come sia stato possibile proclamare, in una stessa pronuncia, che deve «essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa» e insieme autorizzare la soppressione di una disabile in stato di incoscienza sulla base della decisione di chi considerava lo stato in cui ella si trovava tale da “escludere la dignità umana”, così sostenendo che si doveva «escludere la ricorrenza della vita intesa nella sua portata minima imprescindibile»; e come un Tribunale amministrativo abbia potuto descrivere la fase in cui alla disabile sarebbero stati negati alimentazione e idratazione come possibilità per la stessa di «esercitare il proprio diritto assoluto a rifiutare il trattamento sanitario consistente nell’idratazione ed alimentazione artificiali», deducendone il sorgere del suo «diritto, a quel punto quale malata terminale, a che le siano apprestate tutte le misure, suggerite dagli standards scientifici riconosciuti a livello internazionale, atte a garantire un adeguato e dignitoso accudimento accompagnatorio della persona, durante tutto il periodo successivo alla sospensione del trattamento di sostegno vitale».
Ma ancora, è legittimo interrogarsi se sia un astratto e tralaticio riferimento quello che, alla negazione dell’attenuante dell’avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale (art. 62, comma 1, n. 1 c.p.) per chi aveva ucciso un congiunto gravemente sofferente, in quanto «nei confronti degli esseri umani operano i principi espressi dalla Carta costituzionale, finalizzati alla solidarietà e alla tutela della salute», con la conseguenza che «la nozione di compassione, cui il sentire comune riconosce un altissimo valore morale, rimane segnata dal superiore principio del rispetto della vita umana, che è il criterio della moralità dell’agire», affianca la considerazione secondo cui «del tutto distinto è il dibattito culturale sui limiti al trattamento di fine vita e sul rilievo del consenso del malato, fondato sul principio costituzionale del divieto di trattamenti sanitari obbligatori» (Cass., Sez. 1 pen., n. 50378 del 2018).
- Formule giuridiche che nascondono la realtà
In effetti, come ben sappiamo, la giurisprudenza di legittimità e di merito si è sviluppata e consolidata nell’affermare che «il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente non incontra un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita» e nel negare che «il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, possa essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte», sostenendosi che «tale rifiuto esprime piuttosto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale». (Sez. 1, Sentenza n. 21748 del 16/10/2007, Rv. 598963 – 01).
Ecco che attraverso l’esaltazione di un fatto giuridico – la prestazione o la negazione del consenso a terapie – una parte di realtà naturale viene forzatamente staccata dal tutto e inquadrata in una “realtà giuridica” che, inevitabilmente, fa velo all’evento che rimane tale: l’uccisione di un essere umano, che tale è anche se viene eseguita in ospedale da medici o infermieri, anziché esplodendo colpi di pistola. Benché ci si trovi di fronte ad una persona viva, fatta morire mediante la mancata somministrazione di terapie o sostegni vitali o anche mediante l’attiva rimozione di sostegni vitali, in questa realtà giuridica così costruita, la persona non viene “uccisa”, ma curata, anzi, curata al meglio, perché in conformità alla sua volontà; con l’ulteriore conseguenza che la valutazione penale su tale evento – che si risolve nell’applicazione della scriminante dell’adempimento del dovere (come nel caso Welby) o dell’esercizio del diritto (come nel caso Englaro) – è inevitabilmente destinata a scomparire, trattandosi di eventi “privati”, nei quali l’unico soggetto agente è colui che muore, anzi, è il soggetto la cui malattia segue il suo corso naturale.
- La legge sul consenso informato: la morte procurata sottratta al mondo del diritto
La legge n. 219 del 2017 in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento porta alle estreme conseguenze la divaricazione tra realtà naturale e realtà giuridica di cui si è detto.
Nel configurare come assolutamente vincolante il rifiuto di terapie, anche se espresso per situazioni future ed incerte, nonché nel prevederlo per scelte che determinano la morte del soggetto, la legge esplicitamente sottrae l’evento morte – che dal punto di vista naturale è morte procurata, per omessa erogazione di terapie salvavita, non iniziate o interrotte – al mondo del diritto, prevedendo che il medico che ottempera al rifiuto o alla rinuncia al trattamento sia “esente da responsabilità civile o penale” (art. 1, comma 6 legge 219 cit.), sia che ciò avvenga nell’attualità, sia in esecuzione di una DAT.
Il rifiuto alle terapie salvavita permesso dalla legge 219 ha due caratteristiche: in primo luogo può riguardare anche sostegni vitali, quali alimentazione, idratazione e ventilazione artificiale, cosicché la “platea” di soggetti che lo possono esprimere si espande dai malati gravi (anche se non in stato terminale) ai disabili che hanno necessità di tale forma di sostegno; in secondo luogo il rifiuto, cui deve essere data esecuzione, con la conseguente morte dell’interessato, può essere del tutto immotivato e sganciato da considerazioni di carattere sanitario concernenti l’utilità, la gravosità e i rischi delle terapie rifiutate.
Ecco che l’alleanza terapeutica, nella quale medico e paziente insieme valutano e adottano decisioni sulla migliore terapia possibile nel rispetto dei desideri del secondo, si trasforma: il medico non è più alleato, ma deve essere esecutore del rifiuto delle terapie e quindi è un potenziale nemico, un violatore della libertà personale, mentre la decisione del paziente ha per oggetto la vita e la morte e, quindi, può essere accostata a quella del potenziale suicida per motivi differenti da quelli relativi alla salute.
La legge 219, in sostanza, garantisce il diritto ad un “suicidio medicalmente assistito” a tutti coloro la cui permanenza in vita dipende da trattamenti o dispositivi medici. Non ci si può sorprendere, quindi, che solo dopo l’approvazione della legge – anzi: immediatamente dopo – sia stato possibile formulare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.
- Il rifiuto libero e informato delle terapie salvavita: una finzione
Ma la divaricazione tra la realtà naturale e una costruzione giuridica che fa ad essa velo non è senza conseguenza: se, per la validità del rifiuto, è sufficiente la manifestazione della volontà, tendenzialmente in forma scritta (obbligatoria per le DAT), nessuna effettiva garanzia viene approntata affinché l’interessato sia davvero “libero” e “informato” nell’esprimerla. Scopriamo, quindi, che la persona può essere fatta morire in esecuzione del rifiuto espresso da un delegato (art. 1, comma 3), ovvero da soggetto maggiorenne ma temporaneamente incapace di intendere e di volere (art. 1, comma 5); il rifiuto – e questo è evidente nel caso nelle DAT, consegnate anni prima ad un impiegato amministrativo – è valido anche se non vi è alcuna certezza che chi lo esprime o l’ha espresso sia informato; soprattutto, manca del tutto la garanzia di una piena libertà morale del soggetto, senza la quale la parola “autodeterminazione” (art. 1, comma 1) è una formula vuota. Come non ricordare la sentenza della Corte EDU Pretty contro Regno Unito, secondo cui il divieto di suicidio assistito tutela le persone più debole e vulnerabili, non in grado di prendere decisioni con coscienza di causa, proteggendole contro atti altrui miranti a porre fine alla loro vita?
- Vite “non degne” e legalizzazione dell’eutanasia dei soggetti deboli
Ho detto poco fa che il rifiuto a terapie salvavita e a sostegni vitali previsto dalla legge 219 del 2017 è efficace anche se privo di motivazione e sganciato da tematiche di tipo sanitario.
In realtà la legge indica un criterio: quello della dignità della persona; le ultime modifiche apportate all’art. 1, comma 1 hanno trasformato la “tutela della vita” in “tutela del diritto alla vita” e ad essa hanno affiancato il diritto “alla dignità”. Ecco che la vita diventa un diritto e non più un “sommo bene”, come tale disponibile e bilanciabile con altri diritti ed interessi; ecco che la dignità non è più caratteristica intrinseca alla vita umana, ma è anch’essa un diritto che può evidentemente essere graduato o addirittura negato con riferimento alla condizione della singola persona.
Si potrebbe argomentare che le conseguenze di tale impostazione sono facilmente prevedibili, ma non è necessario: è la stessa legge, all’art. 2, a permettere ai legali rappresentanti degli incapaci – minori, interdetti, soggetti ad amministrazione di sostegno – a rifiutare per essi terapie salvavita e sostegni vitali tenendo conto, appunto, non solo (o non tanto) della tutela della loro salute psicofisica, ma anche (e soprattutto) della loro dignità; essi potranno, quindi, valutare la vita degli assistiti “non degna” e decidere di farla cessare; e il giudice, se sarà adito dal medico, dovrà tenere conto di questo parametro.
Siamo, quindi, alla legalizzazione dell’eutanasia non consensuale dei soggetti deboli, basata sul presupposto che non tutte le vite umane sono dotate di dignità intrinseca e che, pertanto, è consentito – anzi è opportuno, o meglio ancora, per certe persone, è obbligatorio – interromperne il corso anticipatamente. Le esperienze di altri Paesi dimostrano che, ben presto, al criterio volontaristico si affiancano altri parametri: motivi eugenetici, ideologici, egoistici e, soprattutto, economici (riduzione della spesa sanitaria o sociale).
- Rispettare il dato naturale e la Costituzione
Questo sviluppo – prima giurisprudenziale e poi normativo – è stato permesso in evidente violazione dell’art. 2 della Costituzione, in base al quale quello alla vita è un diritto inviolabile e indisponibile, e dell’art. 32 della Costituzione, in base al quale la salute dell’individuo è un suo diritto fondamentale ma anche un interesse della collettività.
Occorre ripartire dal dato naturale, perché, come già aveva capito Cicerone, solo la norma o la sentenza che rispetta la natura è buona e giusta.
Ripartiamo, quindi, dalla dignità di ogni uomo; ricordiamoci che – come ricorda la sentenza della Prima Sezione penale che ho già menzionato – «la nozione di compassione è attualmente applicata con riguardo agli animali di compagnia, rispetto ai quali è usuale, e ritenuta espressione di civiltà, la pratica di determinarne la morte in caso di malattie non curabili».
Invece, ogni vita umana deve essere difesa.
Testo della relazione svolta dal Dott. Giacomo Rocchi, Magistrato della Corte Suprema di Cassazione, al Convegno La tutela della vita nell’ordinamento giuridico italiano. Sfide, problemi e prospettive poste dai ‘nuovi diritti’, organizzato dal Centro Studi Livatino e tenutosi a Roma il 16 novembre 2018 presso l’Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione.