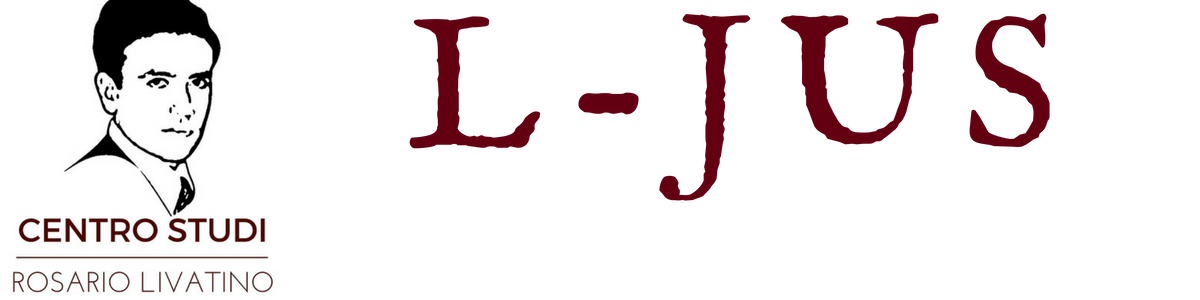REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La I CORTE d’ASSISE di MILANO
Composta dagli illustrissimi signori:
1.Dr. Ilio MANNUCCI PACINI Presidente
2.Dr. Ilaria SIMI Giudice
3.Sig. Lucia MALTESE Giud. Pop.
4.Sig. Anna CARRIERO ” ”
5.Sig. Daniela PALLARI ” ”
6.Sig. Mauro VAGHI ” ”
7.Sig. Viviano MAFFEZZOLI ” ”
8.Sig. Cecilia STRAZIOTA ” ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa penale a carico di:
CAPPATO Marco, nato a Milano il 25/05/1971, el.dom.to c/o Avv. Massimo ROSSI, piazza Sant’ Ambrogio, 16 Milano
libero-presente
Difensori: Avv. Massimo ROSSI, piazza Sant’ Ambrogio, 16 Milano
Avv. Francesco DI PAOLA, via Mezzacapo, 221/c Sala Consilina
IMPUTATO
Del reato p. e p. dall’ art. 580 c.p., per aver rafforzato il proposito suicidiamo di ANTONIANI Fabiano (detto Fabo), affetto da tetraplegia e cecità a seguito di incidente stradale avvenuto il 13 giugno 2014, prospettandogli la possibilità di ottenere assistenza al suicidio presso la sede dell’ associazione Dignitas, a Pfaffikon in Svizzera, e attivandosi per mettere in contatto i famigliari di ANTONIANI con la Dignitas fornendo loro materiale informativo; inoltre per aver agevolato il suicidio dell’ANTONIANI, trasportandolo in auto presso la Dignitas in data 25 febbraio 2017 dove il suicidio si verificava il 27 febbraio 2017
CONCLUSIONI
dei Pubblici Ministeri dott.ssa Tiziana SICILIANO e dott.ssa Sara ARDUINI:
assoluzione perché il fatto non sussiste;
in sub.
sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., per violazione degli articoli 2,3,13,32 c. 2 e 117 cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 2,3,8, CEDU.
In caso di condanna chiedono la trasmissione degli atti alla Procura perché proceda nei confronti di altri soggetti che avrebbero agevolato il suicidio di Fabiano ANTONIANI.
dei difensori Avv.ti Massimo ROSSI e Francesco DI PAOLA:
assoluzione perché il fatto non sussiste;
in sub.
sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.;
in sub.
concedere le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 1 e 62 bis c.p. con condanna adeguata al caso concreto.
La Corte d’Assise di Milano, all’esito dell’odierna camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Fatto
La Corte ritiene di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicidario, ritenendo tale incriminazione in contrasto e violazione dei principi sanciti agli art. 3,13, II comma, 25, II comma, 27, III comma della Costituzione, che individuano la ragionevolezza della sanzione penale in funzione dell’offensività della condotta accertata. Infatti, deve ritenersi che in forza dei principi costituzionali dettati agli artt. 2,13, I comma della Costituzione ed all’art 117 della Costituzione con riferimento agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, all’individuo sia riconosciuta la libertà di decidere quando e come morire e che di conseguenza solo le azioni che pregiudichino la libertà della sua decisione possano costituire offesa al bene tutelato dalla norma in esame.
Rilevanza della questione
La questione è rilevante per le seguenti ragioni.
A Marco Cappato, a seguito dell’ordinanza d’imputazione coatta pronunciata dal G.I.P. di Milano in data 10 luglio 2017, è stato contestato dalla Procura della Repubblica di Milano il reato di cui all’art. 580 c.p. per aver “rafforzato” il proposito suicidario di Fabiano ANTONIANI (detto Fabo), realizzato attraverso diverse condotte:
– prospettandogli la possibilità di ottenere assistenza al suicidio presso la sede dell’associazione Dignitas, sita nella cittadina di Pfaffikon;
– attivandosi per mettere in contatto i familiari di ANTONIANI con la suindicata associazione e fornendo loro materiale informativo.
Inoltre, gli è stato contestato di avere “agevolato” il suicidio di ANTONIANI, avendolo il 25 febbraio 2017 trasportato in auto da Milano (luogo ove ANTONIANI viveva) a Pfaffikon, presso la sede clinica della Dignitas, dove il suicidio si è verificato il 27 febbraio 2017.
Dall’istruttoria svolta dinanzi a questa Corte è emerso che Marco Cappato ha certamente realizzato la condotta di “agevolazione” contestata, avendo aiutato Fabiano ANTONIANI a recarsi in Svizzera presso la Dignitas, ma è stato escluso che l’imputato abbia compiuto alcuna delle condotte a lui ascritte di rafforzamento della decisione suicidaria.
Valeria Imbrogno, fidanzata di ANTONIANI, Carmen Carollo, madre dello stesso, e Carlo Lorenzo Veneroni, suo medico curante, hanno testimoniato che la decisione di Fabiano di rivolgersi alla citata associazione svizzera era intervenuta in modo autonomo ed in epoca antecedente ai suoi contatti con Cappato.
Più in particolare i testimoni hanno riferito che Fabiano ANTONIANI, a seguito di un incidente stradale avvenuto il 13 giugno 2014, era rimasto tetraplegico e affetto da cecità bilaterale corticale (che significa permanente). Non era autonomo nella respirazione (necessitando, seppur non continuativamente, dell’ausilio di un respiratore e di periodiche aspirazioni del muco), nell’alimentazione (era gravemente disfagico con deficit sia della fase orale sia di quella degluttitoria, e necessitava di nutrizione intraparietale) e nell’evacuazione[1].
Egli soffriva di ricorrenti contrazioni e spasmi (che, come illustrato dal consulente del P.M., l’anestesista-rianimatore dott.ssa Mari Cristina Marenghi, erano incoercibili e gli provocavano sofferenze che non potevano essere completamente lenite farmacologicamente, se non mediante sedazione profonda), ma aveva preservato le sue funzioni intellettive.
Dopo lunghi e ripetuti ricoveri, cure e infruttuosi tentativi riabilitativi (la sedute di fisioterapia dopo i primi tempi erano proseguite solo a scopo palliativo), nel dicembre 2015 ANTONIANI era stato accompagnato dalla fidanzata in India per tentare di migliorare le sue condizioni con il trapianto di cellule staminali. Tale terapia gli aveva procurato un beneficio molto limitato e solo temporaneo. L’insuccesso di questo tentativo e l’acquisita consapevolezza dell’inesistenza di cure per la sua malattia avevano determinato ANTONIANI a decidere di porre termine alla sua vita.
Nel marzo/aprile 2016 ANTONIANI aveva comunicato ai suoi cari (che continuavano ad assisterlo a casa, prestandogli ogni necessaria assistenza materiale, psicologica, relazionale) di aver deciso di non continuare la propria vita nelle condizioni di sofferenza continua sopra descritte, e aveva loro espresso la ferma volontà di morire. Valeria Imbrogno e la madre avevano tentato di dissuaderlo da tale decisione, chiedendogli di rimandare l’attivazione delle pratiche per realizzarla. Fabiano, però, per dimostrare la sua determinazione, aveva rifiutato per alcuni giorni di essere alimentato e di parlare (i testi hanno tutti riferito dello “sciopero” dell’alimentazione e della parola adottato da Fabiano per indurre i propri congiunti ad assecondare la propria irremovibile decisione).
Proprio a seguito della decisione assunta, ANTONIANI aveva anche chiesto a Jonny Enriquez Montecel, la persona che affiancava la madre e la fidanzata nel provvedere alle sue cure, di “lasciarlo morire”, in particolare di non provvedere ad aiutarlo quando aveva le sue ricorrenti crisi respiratorie (crisi particolarmente violente che vennero documentate nel filmato in cui ANTONIANI manifestò pubblicamente la sua volontà di morire) o comunque di commettere «qualche sbaglio» nell’assistenza medica. Enriquez Montecel ha riferito in dibattimento di avere rifiutato di aderire a tale richiesta.
Agli inizi di maggio 2016, reperite con l’ausilio di Valeria Imbrogno le informazioni sulle strutture svizzere ove era praticata l’assistenza al suicidio, sempre per il tramite della fidanzata, Fabiano contattò in Svizzera alcune di quelle organizzazioni, dapprima la Exit e poi la Dignitas. In quel periodo contattò anche l’Associazione Luca Coscioni, che sapeva svolgere attività informativa sulle decisioni del fine vita. Dopo aver pagato la quota associativa alla Dignitas, ANTONIANI entrò in contatto diretto con Marco Cappato.
Nello specifico di tale rapporto, dai documenti acquisiti al fascicolo dibattimentale risulta che il 31.5.2016 Fabiano si fece rilasciare dal medico curante un certificato che descriveva le sue condizioni di salute e attestava la sua piena capacità di intendere e volere. In quella stessa data Valeria Imbrogno inviò una mail a Marco Cappato nella quale, dopo essersi presentata come fidanzata di Fabiano ANTONIANI, ne illustrava le condizioni di salute e riferiva che lo stesso aveva chiesto a lei e a sua madre di occuparsi delle pratiche per il suicidio assistito. Affermava quindi che pur avendo già preso contatti con alcune strutture, voleva ora potersi confrontare per telefono con lui per «avere la possibilità di esporle alcune domande per serenità di Fabiano e di sua madre». Alcuni giorni dopo Cappato entrò in contatto con Fabiano ANTONIANI e nel corso di alcuni successivi incontri gli espose le possibilità di essere sottoposto in Italia alla sedazione profonda, con interruzione della respirazione e dell’alimentazione artificiale, lasciando che la malattia facesse il suo corso. Di fronte alla ferma richiesta di ANTONIANI di recarsi in Svizzera per porre fine alla sua vita presso una delle strutture che praticavano l’assistenza al suicidio, l’imputato accettò di accompagnarlo.
Fabiano, tramite la fidanzata, stava intanto continuando a seguire le pratiche per ottenere il “benestare” al suicidio assistito da parte della Dignitas (definito “semaforo verde”), presupposto perché la struttura fissasse la data nella quale quella decisione sarebbe stata attuata, e in quei mesi si lamentò frequentemente del lungo tempo necessario ad ottenerli.
La Dignitas, infine, a seguito della documentazione trasmessa dai familiari di ANTONIANI, rilasciò il benestare e fissò per il 27 febbraio 2017 il giorno in cui avrebbe fornito a Fabiano il farmaco per porre fine alla sua vita. In quei mesi, successivi alla fissazione della data, ANTONIANI ribadì sempre la sua scelta, che comunicò dapprima agli amici e poi pubblicamente (si veda il filmato già menzionato e l’appello al Presidente della Repubblica), manifestando di viverla come «una liberazione».
Due giorni prima del 27 febbraio ANTONIANI venne accompagnato in Svizzera a bordo dell’autovettura predisposta per il suo trasporto con la carrozzina, con alla guida Cappato, e, nella stessa vettura o in altra di accompagnamento, la madre, la fidanzata e la madre di quest’ultima. In Svizzera venne preso in consegna dal personale dell’Associazione Dignitas e vennero nuovamente verificate le sue condizioni di salute, il suo consenso, la possibilità o meno per lui di assumere in via autonoma il farmaco letale (pentobarbital sodium).
In quegli ultimi giorni i suoi familiari e Cappato continuarono a stare vicino a Fabiano ed a fargli presente, ciascuno di loro, che se avesse voluto avrebbe potuto decidere di non attuare il proposito di suicidarsi e che sarebbe stato da loro riportato in Italia.
Dall’istruttoria qui sinteticamente riassunta è emerso dunque che Cappato conobbe ANTONIANI e intervenne per discutere con lui della sua decisione dopo che lo stesso, in piena autonomia, con il costante sostegno dei suoi cari, dopo aver verificato con numerosi consulti medici l’impossibilità di cura della sua malattia, aveva deciso (manifestando tenacemente la sua ferrea intenzione, tanto da farla ritenere anche ai suoi familiari irrevocabile) di porre termine alle sue sofferenze incoercibili e di porre fine alla sua vita.
È stato altresì accertato che l’imputato non indirizzò o condizionò la decisione di Fabiano di procedere in Svizzera al proprio suicidio attraverso le modalità consentite in quello Stato, ma al contrario gli prospettò la possibilità di farlo in Italia interrompendo le terapie che lo tenevano in vita. Anche durante il soggiorno in Svizzera, Cappato verificò fino all’ultimo che ANTONIANI non volesse desistere dal progetto di suicidio, assicurandogli che in tal caso lo avrebbe riaccompagnato in Italia.
Per gli accertamenti svolti in dibattimento, deve quindi concludersi che la condotta di Marco Cappato non ha inciso sul processo deliberativo di Fabiano Antoniani in relazione alla decisione di porre fine alla propria vita e, pertanto, l’imputato deve essere assolto dall’addebito di averne rafforzato il proposito di suicidio.
È emerso d’altro canto che Cappato ha provveduto ad accompagnare Fabiano in Svizzera presso la Dignitas nella consapevolezza di portarlo dove avrebbe realizzato il suo progetto suicidario, che è poi avvenuto, per opera dello stesso Fabiano, con l’ausilio degli operatori della Dignitas, in conformità alla normativa svizzera. La condotta dell’imputato è stata condizione per il realizzarsi del suicidio e, di conseguenza, secondo l’interpretazione dell’art. 580 c.p. sostenuta dal diritto vivente, tale condotta risulterebbe per ciò solo integrare l’agevolazione sanzionata da detta disposizione.
Ad oggi l’unica sentenza della Corte di Cassazione che ha provveduto a definire le condotte di agevolazione incriminate dall’art 580 c.p., ha sottolineato che le stesse sono state previste come alternative a quelle di istigazione e per ciò sono punibili a prescindere dalla ricaduta sul processo deliberativo dell’aspirante suicida[2].
L’interpretazione proposta dalla Corte di Cassazione nella pronuncia appena citata appare conseguenza della considerazione del suicidio come fatto riprovevole e dell’individuazione della ratio della norma nella tutela “del bene supremo della vita”. Tali considerazioni, peraltro, sono ancora diffuse nella giurisprudenza di legittimità. Infatti, anche in una più recente sentenza della Corte di Cassazione è stato affermato che «il suicidio, pur non essendo punito in sé nel vigente ordinamento penale a titolo di tentativo, costituisce pur sempre una scelta moralmente non condivisibile, non giustificabile ed avversata dalla stragrande maggioranza dei consociati, a prescindere dalle loro convinzioni religiose e politiche, siccome contraria al comune modo di sentire, in quanto negatrice del principio fondamentale su cui si fonda ogni comunità organizzata e costituito dal rispetto e dalla promozione della vita in ogni sua manifestazione»[3].
Ed ancora la Corte di Cassazione, nella pronuncia sul caso Englaro[4], ha sostenuto che dalla Costituzione non deriva “il diritto a morire”, la facoltà “di scegliere la morte piuttosto che la vita”, confermando un orientamento che, ad avviso di questa Corte d’Assise, risulta contrario ai principi di libertà e di autodeterminazione dell’individuo sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che sono stati di recente richiamati e declinati nella legge n. 219/2017 sul fine vita.
L’interpretazione dell’art. 580 c.p. che risulta sostenuta dal diritto vivente, unitamente all’importanza dei diritti di cui si tratta, rende necessario, dunque, il ricorso alla Corte Costituzionale alla quale è possibile rivolgersi «allorquando il giudice remittente ha l’alternativa di adeguarsi ad un’interpretazione che non condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata»[5].
L’interpretazione dell’art 580 c.p. secondo il “diritto vivente”
L’art. 580 c.p. sanziona chi sia intervenuto nel processo di formazione della decisione suicidaria (nella forma dell’istigazione) e chi abbia contribuito alla realizzazione del suicidio sul piano materiale (l’agevolazione o aiuto). L’istigazione comprende sia la condotta di chi determini altri al suicidio, facendogli assumere un progetto e una decisione che prima non aveva, sia quella di chi rafforzi il proposito ancora non sicuro, non definito dell’aspirante suicida. L’aiuto è integrato dalle condotte di chi offra “in ogni modo” un’agevolazione alla realizzazione della decisione di auto sopprimersi dell’aspirante suicida. In entrambe le ipotesi, il suicidio deve essere in rapporto di derivazione causale con la condotta dell’agente, che non è perseguibile se il suicidio si verifica indipendentemente dal suo contributo. Dal punto di vista soggettivo occorre il dolo generico. La Corte di Cassazione, nella prima delle pronunce sopra citate[6] ha affermato che le condotte definite nella norma sono previste in via alternativa e che pertanto integra la fattispecie incriminatrice qualsiasi contributo materiale al suicidio, senza che debba avere anche una ricaduta psicologica sul soggetto passivo alterando il suo processo deliberativo.
Per questo motivo la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Assise di Messina in cui era stato affermato invece che l’art. 580 c.p. punisce la condotta agevolatrice del suicidio soltanto quando questa implica anche un rafforzamento del progetto suicidario, ritenendo che in caso contrario l’azione non sarebbe “idonea a ledere il bene giuridico tutelato” («nell’ipotesi di doppio suicidio, ove uno dei partecipanti sia morto e l’altro sia sopravvissuto, quest’ ultimo non è punibile ex art 580 c.p., quando il suicida si sia autonomamente determinato, senza essere da lui minimamente influenzato, giacché anche l’agevolazione al suicidio sul piano soltanto materiale va ricondotta al fenomeno istigativo ed una interpretazione della norme conforme a Costituzione impone di circoscrivere le condotte punibili a quelle nelle quali l’aiuto abbia esercitato un ‘apprezzabile influenza nel processo formativo della volontà della vittima, che ha trovato nella collaborazione dell’estraneo incentivo e stimolo a togliersi la vita»)[7].
La Corte di Cassazione per contro ha sostenuto non solo che l’incriminazione della condotta di favoreggiamento prescinde dalla verifica della sua influenza sulla decisione suicidaria, ma anche che la nozione di aiuto sanzionata dalla norma in esame deve essere intesa nella forma più ampia, comprendendo “qualsiasi” contributo materiale al progetto suicidario («La legge, nel prevedere, all’art 580 c.p., tre forme di realizzazione della condotta penalmente illecita…ha voluto …punire sia la condotta di chi determini altri al suicidio o ne rafforzi il proposito, sia qualsiasi forma di aiuto o di agevolazione di altri del proposito di togliersi la vita, agevolazione che può realizzarsi in qualsiasi modo: ad esempio, fornendo i mezzi per il suicidio, offrendo informazioni sull’uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o difficoltà che si frappongono alla realizzazione del proposito ecc, o anche omettendo di intervenire, qualora si abbia l’obbligo di impedire l’evento. L’ipotesi della agevolazione al suicidio prescinde totalmente dall’ esistenza di qualsiasi intenzione, manifesta o latente, di suscitare o rafforzare il proposito suicida altrui. Anzi, presuppone che l’intenzione di auto sopprimersi sia stata autonomamente e liberamente presa dalla vittima, altrimenti vengono in applicazione le altre ipotesi previste dall’art. 580 c.p. Perchè si realizzi l’agevolazione sanzionata dalla norma “è sufficiente che l’agente abbia posto in essere, volontariamente e consapevolmente, un qualsiasi comportamento che abbia reso più agevole la realizzazione del suicidio”»). L’interpretazione della norma proposta dalla Corte di Cassazione è stata sostanzialmente disattesa dal Tribunale di Vicenza[8], che, pur non contestandola apertamente, anzi richiamandosi alla stessa, ha ritenuto che, alla luce del tenore letterale della norma, l’aiuto al suicidio, definito come la condotta di “chi ne agevola l’esecuzione”, fosse integrato solo dal contributo materiale direttamente e funzionalmente incidente sulla “esecuzione” dell’atto anticonservativo.
Più in particolare il G.U.P. ha disatteso la questione di costituzionalità della norma prospettata dalla difesa dell’imputato con riferimento all’art. 3 della Costituzione in considerazione dell’identico trattamento sanzionatorio previsto per tutte le diverse condotte individuate dall’art. 580 c.p., affermando che l’effettivo disvalore della condotta di agevolazione al suicidio poteva cogliersi «selezionando le condotte punite alla luce del dettato letterale della norma, laddove la condotta tipica stigmatizzata è precisamente indicata come di agevolazione dell’esecuzione del suicidio». Quel giudice ha ritenuto, quindi, che le condotte di agevolazione incriminate fossero solo quelle «direttamente e strumentalmente connesse all’attuazione materiale del suicidio», condotte che si pongono «essenzialmente come condizione di facilitazione del momento esecutivo del suicidio stesso». Di conseguenza ha affermato che la condotta dell’imputato che aveva accompagnato l’aspirante suicida in Svizzera, non integrava “agevolazione” dell’esecuzione del suicidio, dovendosi riguardare solo come «agevolatrice della mera potenzialità di attuazione del programma …di auto sopprimersi, senza alcuna diretta connessione, se non sul piano soltanto motivazionale, con l’esecuzione del suicidio, la quale costituì (e va riguardata come) una fase finale a se stante».
La Corte di Appello di Venezia[9] ha aderito all’interpretazione della norma sostenuta dal G.U.P., affermando in primo luogo che i limiti individuati dall’ordinamento alla possibilità di interferire nelle scelte individuali relative alla salute (art. 32 Cost.) e nelle fondamentali scelte di vita delle persone, conducevano a respingere «qualsiasi ipotesi di lettura estensiva della norma incriminatrice in questione». Ha soggiunto che il preciso dettato letterale della norma imponeva di ritenere sanzionabili solo le condotte che, a prescindere dal dato meramente temporale, risultassero comunque «in necessaria relazione con il momento esecutivo del suicidio, ovvero direttamente e strumentalmente connesse a tale atto». Ha ritenuto pertanto che il comportamento dell’imputato, che si era limitato ad accompagnare l’aspirante suicida in Svizzera, fosse da considerare essenzialmente neutro (anche “perchè del tutto fungibile”, dal momento che la donna era nelle condizioni per procedere da sola al viaggio che l’aveva portata presso l’associazione che l’aveva assistita mentre metteva in atto la sua decisione di porre termine alla sua vita).
Sia l’interpretazione proposta dalla Corte di Assise di Messina, sia quella adottata dal G.U.P. di Vicenza e dalla Corte di Appello di Venezia, rivelano l’esigenza di evitare i profili di incostituzionalità che l’interpretazione ampia e indiscriminata delle condotte costitutive l’aiuto al suicidio incriminato sostenuta dalla Corte di Cassazione solleva sotto il profilo dell’offensività.
Il bene giuridico tutelato dall’art 580 c.p.
Le norme attualmente in vigore sull’omicidio del consenziente e sull’istigazione e aiuto al suicidio sono state introdotte nel 1930 con il codice Rocco.
All’origine dell’incriminazione prevista dall’art. 580 c.p. vi era stata la considerazione che il suicidio fosse una condotta connotata da elementi di disvalore perché contraria ai principi fondamentali della società, quello della sacralità/indisponibilità della vita in correlazione agli obblighi sociali dell’individuo ritenuti preminenti nel corso del regime fascista[10]. Solo per ragioni di politica criminale il legislatore aveva ritenuto inutile, se non dannoso punire, chi avesse tentato di realizzarlo[11]. Peraltro, il concorso nell’azione della volontà del soggetto passivo aveva fatto ritenere meno grave la condotta incriminata rispetto all’omicidio sotto il profilo dell’intensità del dolo e della personalità del reo.
Allo stato, però, la disciplina dettata dal Codice Rocco deve essere interpretata alla luce dei nuovi principi introdotti dalla Costituzione, che hanno comportato una diversa considerazione del diritto alla vita, che si evince dal complesso del dettato costituzionale, primariamente dal principio personalistico enunciato all’art. 2 e da quello dell’inviolabilità della libertà individuale enunciato all’art. 13.
Il diritto alla vita non è stato direttamente enunciato dalla Carta Costituzionale, ma costituisce il presupposto di ogni diritto riconosciuto all’individuo e si definisce attraverso questi. Principio cardine della Costituzione è quello personalistico, che pone “l’uomo” e non lo Stato al centro della vita sociale e afferma “l’inviolabilità dei suoi diritti” come valore preminente. Seppur sull’individuo incombano significativi obblighi (obblighi di solidarietà politica, economica e sociale come definiti all’art. 2 Cost.), proprio per la preminenza dell’individuo nella struttura sociale del Paese, la vita umana non può essere concepita in funzione di un fine eteronomo rispetto al suo titolare. A ciascun individuo è inoltre garantita la libertà personale rispetto a interferenze arbitrarie dello Stato (art. 13 Cost.) e da questo diritto primario deriva, per quanto rileva ai fini del decidere, «il potere della persona di disporre del proprio corpo»[12] e che «la persona non possa essere costretta a subire un trattamento sanitario non voluto in assenza di una norma che esplicitamente lo imponga»[13]. Da questi stessi principi costituzionali deriva la libertà per l’individuo di decidere sulla propria vita ancorché da ciò dipenda la sua morte. Che il diritto alla libertà non trovi un limite in funzione di considerazioni eteronome rispetto alla vita (a esempio, in funzione di obblighi solidaristici), si evince dall’assenza di divieti all’esercizio di attività per sé pericolose e dall’assenza nella nostra Carta costituzionale dell’obbligo di curarsi[14]. L’obbligo a sottoporsi a una determinata terapia può intervenire solo per legge e solo ai fini di evitare di creare pericolo per gli altri[15]. Solo in questi limiti può essere compresso il diritto alla libertà dell’individuo a decidere sulla propria vita.
Il diritto alla libertà e all’autodeterminazione, che è declinato nell’art. 32 della Costituzione con riferimento ai limiti dei doveri/poteri d’intervento dello Stato a tutela della salute delle persone, è stato affermato in modo chiaro dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di trattamenti terapeutici, riconoscendo in modo sempre più deciso il diritto del paziente all’autodeterminazione nell’individuare le cure a cui sottoporsi e l’obbligo di rispettarne la decisione, anche se da questo possa derivare la sua morte.
Per quanto riguarda la giurisprudenza di merito, può richiamarsi la nota sentenza pronunciata nel caso Welby[16], in cui correttamente si è osservato che «quando si riconosce l’esistenza di un diritto di rango costituzionale, quale è quello ali ‘autodeterminazione individuale e consapevole in materia di trattamento sanitario, non è poi consentito lasciarlo senza tutela, rilevandone, in assenza di una normativa secondaria di specifico riconoscimento, la sua concreta inattuabilità sulla scorta di disposizioni normative di fonte gerarchica inferiore a contenuto contrario, quali gli arti 5 c.c., che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo tali da determinare un danno permanente e 575, 576, 577, n3, 579 e 580 c.p., che puniscono in particolare l’omicidio del consenziente e l’aiuto al suicidio, nonchè quali gli art 35 e 37 del codice di deontologia medica… L’affermazione nella Carta costituzionale del principio che sancisce l’esclusione della coazione in tema di trattamenti sanitari (e quindi della necessità del consenso del malato) ha come necessaria consecuzione il riconoscimento anche della facoltà di rifiutare le cure o di interromperle, che a sua volta, non può voler significare l’implicito riconoscimento di un diritto al suicidio, bensì soltanto l’inesistenza di un obbligo a curarsi a carico del soggetto. Infatti la salute dei cittadini non può essere oggetto di imposizione da parte dello Stato, tranne nei casi in cui l’imposizione del trattamento sanitario è determinato per legge, in conseguenza della salvaguardia della salute collettiva e della salute individuale, come avviene ad esempio, nel caso delle vaccinazioni obbligatorie. Il diritto al rifiuto dei trattamenti sanitari fa parte dei diritti inviolabili della persona, di cui all’art 32 della Costituzione, e si collega strettamente al principio di libertà di autodeterminarsi riconosciuto all’individuo dall’art 13 della Costituzione». Il giudice ha dunque individuato correttamente nell’art. 13 della Costituzione il fondamento del diritto della persona a decidere della propria vita e del limite al diritto dello Stato a intervenire sulla salute (di cui è espressione l’art. 32 Cost). Ha inoltre sottolineato con chiarezza che detto diritto sussiste a prescindere «da una normativa secondaria di specifico riconoscimento».
Non si può peraltro omettere di riferire che, nella citata sentenza, il giudice ha rimarcato che dai principi costituzionali non deriva «un implicito riconoscimento del diritto al suicidio» e che «in ogni caso l’azione di interruzione di una terapia non può essere concettualmente assimilata all’ espletamento di un trattamento diretto a provocare la morte del paziente, poiché la prima costituisce mera cessazione di una terapia precedentemente somministrata, mentre il secondo è l’attivazione ex novo di un intervento terapeutico finalizzato al decesso del paziente».
Qualche mese dopo quella sentenza di merito, pronunciando nella vicenda Englaro, la Corte di Cassazione[17] ha riaffermato il diritto “all’autodeterminazione terapeutica” ed “il diritto di lasciarsi morire”, come correlati al principio personalistico che anima la Costituzione.
La Corte di Cassazione ha affermato che «il diritto alla salute, come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del suo risvolto negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità propri dell’interessato, finanche di lasciarsi morire».
Quindi, più nello specifico, ha rilevato che «…il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia, di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. Ciò è conforme al principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé, vieta ogni strumentalizzazione della medesima per alcun fine eteronomo ed assorbente, concepisce l’intervento solidaristico e sociale in funzione della persona e del suo sviluppo e non viceversa, e guarda al limite – del rispetto della persona umana – in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive.
Deve escludersi che il diritto all’autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegue il sacrificio del bene della vita. Benché sia stato talora prospettato un obbligo per l’individuo di attivarsi a vantaggio della propria salute o un divieto di rifiutare trattamenti o di omettere comportamenti ritenuti vantaggiosi o addirittura necessari per il mantenimento o il ristabilimento di essa, il Collegio ritiene che la salute dell’individuo non possa essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva. Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c’è spazio … per una strategia della persuasione, perché il compito dell’ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e sofferenza, e c’è, prima ancora, il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale. Ma allorché il rifiuto abbia tali connotati non c’è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico lo si ricava dall’art 32 della Costituzione, per il quale i trattamenti sanitari sono obbligatori nei soli casi espressamente prevista dalla legge, sempre che il provvedimento che li impone sia volto ad impedire che la salute del singolo possa arrecare danno alla salute degli altri e che l’intervento previsto non danneggi, ma sia anzi utile alla salute di chi vi è sottoposto (Corte Costituzionale, sentenze n 258 del 1994 e n 118 del 1996).
Soltanto in questi limiti è costituzionalmente corretto ammettere limitazioni al diritto del singolo alla salute, il quale, come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del risvolto negativo: il diritto di perdere la salute…di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umani propri dell’interessato, finanche di lasciarsi morire.
Il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale».
Anche in quest’ultima sentenza è stato dunque correttamente individuato il diritto di decidere della propria vita, finanche scegliendo la morte, correlandolo al principio personalistico che informa tutta la Costituzione, salvo poi declinarlo, visto il caso in esame, solo in rapporto agli interventi sanitari disciplinati dall’art. 32 della Costituzione.
Peraltro, come si era anticipato, in questa pronuncia, la Corte di Cassazione, pur non essendosi soffermata ad approfondire come si configura il diritto a porre fine alla propria esistenza al di fuori del rapporto terapeutico, ha fatto esplicito richiamo alla sentenza della CEDU nel caso Pretty vs Regno Unito del 29.4.2002, sostenendo di condividere l’affermazione che il riconoscimento del diritto alla vita non può essere interpretato come presupposto di «un diritto di morire, nè…può creare un diritto di autodeterminazione, nel senso di attribuire a un individuo la facoltà di scegliere la morte piuttosto che la vita».
La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha però subito una significativa evoluzione dalla pronuncia Pretty, citata nella sentenza della Corte di Cassazione sul caso Englaro.
La CEDU, che ha avuto modo di pronunciarsi più volte sul tema del suicidio[18], lo ha fatto riferendosi alle norme della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (stipulata nel 1950 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con la legge n 848 del 1955) che salvaguardano rispettivamente il diritto alla vita (art. 2) ed il diritto dell’individuo di fronte ad arbitrarie ingerenze delle pubbliche autorità nella sua vita privata (art. 8)[19], giungendo ad affermare il “diritto di un individuo di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà” e l’intervento repressivo degli Stati in questo campo può avere solo la finalità di evitare “rischi di abuso”, ovvero di “indebita influenza” nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili, come sono le persone che hanno perso interesse per la vita.
Analizzando in ordine cronologico queste pronunce, la prima sentenza è quella Pretty v. Regno Unito del 29.4.2002[20] in cui è stato affermato che, interpretando le disposizioni della CEDU, non può ritenersi riconosciuto il diritto di morire per mano di un terzo o con l’assistenza dello Stato e che gli Stati hanno il diritto di controllare, attraverso l’applicazione del diritto penale generale, le attività pregiudizievoli per la vita e la sicurezza dei terzi.
Più in particolare la Corte ha sostenuto che il “diritto alla vita” garantito dall’art. 2 non «può essere interpretato nel senso che comporti un aspetto negativo” ovvero il diritto di scegliere di continuare o cessare di vivere, “l’art. 2 non potrebbe, senza distorsione di linguaggio, essere interpretato nel senso che conferisce un diritto diametralmente opposto, vale a dire un diritto di morire; non potrebbe nemmeno far nascere un diritto all’autodeterminazione nel senso che darebbe ad ogni individuo il diritto di scegliere la morte piuttosto che la vita». La Corte ha dapprima osservato che le norme nazionali che sanzionino l’aiuto al suicidio non possono ritenersi violazione dell’art. 3 della Convenzione che prevede che «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti». Per quanto riguarda poi la pretesa violazione dell’art. 8 della Convenzione, la Corte di Strasburgo ha rilevato che «la nozione di autonomia personale rispecchia un principio importante sotteso all’interpretazione delle garanzie dell’ art. 8» e, richiamandosi a tale principio, ha anticipato le conclusioni adottate poi dalla Corte di Cassazione nel caso Englaro, sostenendo che «in ambito sanitario, -anche se- il rifiuto di accettare un trattamento particolare potrebbe, inevitabilmente, condurre ad un esito fatale, l’imposizione di un trattamento medico senza il consenso del paziente, se è adulto e sano di mente, costituirebbe un attentato all’integrità fisica dell’interessato che può mettere in discussione i diritti protetti dall’art. 8». Quindi, analizzando più specificatamente la fattispecie concreta al suo esame, in cui la ricorrente lamentava che le fosse stato impedito dalla legge di compiere una scelta per evitare ciò che, ai suoi occhi, costituiva “un epilogo della vita indegno e doloroso”, ha sostenuto che «la Corte non può escludere che ciò costituisca una lesione del diritto dell’interessata al rispetto della sua vita privata, ai sensi dell’art. 8, paragrafo 1, della Convenzione». Ha sottolineato inoltre che, per conciliarsi con il paragrafo 2 del suindicato articolo, l’interferenza dello Stato doveva essere non solo “prevista dalla legge”, ma anche “necessaria” (“rispondendo ad un bisogno sociale imperativo”) e “proporzionata allo scopo legittimamente perseguito”, bilanciando le considerazioni di salute e sicurezza pubblica con il principio concorrente dell’autonomia personale. La Corte ha rimarcato quindi che gli Stati hanno il diritto di controllare, tramite l’applicazione del diritto penale generale, le attività pregiudizievoli per la vita e la sicurezza dei terzi, individuando una disciplina idonea a «salvaguardare la vita, proteggendo le persone deboli e vulnerabili, specialmente quelle che non sono in grado di adottare decisioni con cognizione di causa- da atti volti a porre fine all’esistenza o aiutare a morire».
La decisione in commento appare significativa perché nel riconoscere il diritto di ciascuno Stato a vietare e sanzionare l’aiuto al suicidio, ha individuato espressamente la ratio di queste norme nell’esigenza di tutelare appunto le persone deboli e vulnerabili. Inoltre, nell’affermare che a fronte di detta necessità la disciplina inglese, che sancisce «la natura generale del divieto di suicidio assistito», «non è sproporzionata», ha sottolineato pure che il diritto inglese prevede la possibilità «di valutare in ciascun caso concreto tanto l’interesse pubblico ad avviare un ‘azione giudiziaria, quanto le esigenze giuste ed adeguate del castigo e della dissuasione».
Nella sentenza Haas v. Svizzera del 20.1.2011[21] è stato invece asserito espressamente che «il diritto di un individuo di decidere con quali mezzi ed a che punto la propria vita finirà, a condizione che egli o ella sia in grado di raggiungere liberamente una propria decisione su questa questione ed agire di conseguenza, è uno degli aspetti del diritto al rispetto della vita privata entro il significato dell’art 8 della Convenzione».
La Corte ha rilevato innanzitutto che nel caso Pretty era già stato affermato incidentalmente che la scelta della ricorrente di evitare quello che ai suoi occhi costituiva una fine indegna e dolorosa rientrava nel campo di applicazione dell’art. 8. Ha ribadito a sua volta che l’art. 2 della Convenzione impone agli Stati l’obbligo di proteggere «le persone vulnerabili, anche contro azioni con cui minaccino la loro stessa vita», attivandosi per evitare che «un individuo possa mettere fine alla sua vita quando la sua decisione non è intervenuta liberamente e con piena conoscenza». Nell’affrontare poi il caso al suo esame, la Corte da un lato ha dato riconoscimento alla «volontà del richiedente di suicidarsi in maniera sicura, degna e senza dolore e sofferenze superflue» e dall’altro lato ha sostenuto che la previsione di una prescrizione medica per il rilascio di un farmaco letale fosse giustificata perché finalizzata a «proteggere le persone dal prendere decisioni precipitose” e a prevenire possibili abusi. La Corte ha affermato quindi che gli Stati avevano il dovere di “evitare che un paziente privo di capacità di discernimento possa ottenere una dose mortale di pentorbital sodico»[22] e che in considerazione di tale dovere e della “necessità” di tutela della salute, della sicurezza pubblica e della prevenzione di illeciti penali, le restrizioni all’accesso al farmaco letale trovavano giustificazione, puntualizzando che «il diritto alla vita garantito dall’art. 2 della Convenzione obbliga gli Stati a predisporre una procedura appropriata a garantire che una decisione di mettere fine alla propria vita corrisponda alla libera volontà dell’interessato».
Infine, nella sentenza Gross c. Svizzera del 14.5.2013[23] la Corte ha dato atto del superamento della pronuncia Pretty con l’esplicito riconoscimento «del diritto di un individuo di decidere il mezzo ed il momento in cui la sua vita debba finire» a condizione che sia capace di adottare una decisione libera e consapevole. Ha rilevato quindi che nel caso al suo esame la richiesta della ricorrente si fondava «sul suo diritto al rispetto della vita privata», ribadendo che «lo scopo principale dell’art. 8 è quello di proteggere gli individui contro interferenze arbitrarie delle Pubbliche Autorità», interferenze che sono giustificate solo nel caso di “previsione di legge” e solo in forza di una delle “necessità” individuate nel secondo paragrafo di detta norma. Richiamandosi sempre a tali principi la Corte ha proceduto quindi a verificare se «lo Stato avesse fallito nell’indicare sufficienti linee guida che definissero se ed in quali circostanze il personale medico era autorizzato a rilasciare una prescrizione per persone nelle condizioni della ricorrente» ed ha rilevato che le linee guida adottate in Svizzera dall’Ordine dei medici riguardavano solo i casi relativi a pazienti terminali (la cui malattia li avrebbe portati a morte in poche settimane), ma non anche la condizione della ricorrente. La Corte ha affermato quindi che «la legge svizzera, pur offrendo la possibilità di ottenere una dose letale di pentobarbital su prescrizione medica, non offre linee guida che assicurino chiarezza sull’estensione di tale diritto» ed ha ritenuto in tal senso violata la Convenzione[24].
Anche nelle sentenze più recenti[25] è stato affermato che il diritto all’autodeterminazione, implicato e sotteso a tutta la Convenzione, si esplica nella facoltà per ogni individuo, che sia in grado di assumere determinazioni consapevoli e ponderate, di decidere “se e come porre termine alla sua vita”.
La legge n. 219 del 22.12.2017
Il diritto a morire, rifiutando i trattamenti sanitari, è stato di recente riconosciuto dal legislatore italiano con la legge n. 219 del 22.12.2017, nella quale vi sono espliciti richiami ai principi sanciti agli artt. 2,13 e 32 della Costituzione e agli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
La legge non ha introdotto solo la possibilità per ciascun individuo di disporre anticipatamente in ordine ai trattamenti sanitari a cui essere sottoposto, ma ha anche riconosciuto espressamente il diritto di rifiutare l’idratazione o l’alimentazione artificiale, ha vietato trattamenti terapeutici finalizzati a prolungare la vita ad ogni costo e ha riconosciuto al malato il diritto di scegliere di porre fine alla propria vita in stato di sedazione profonda nel caso di “sofferenze refrattarie alle cure”.
La legge, nella sua premessa programmatica, ha fatto richiamo ai “principi di cui agli art 2,13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”, indicandoli come principi cardine nella «tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona», che si può esprimere anche con la volontà di porvi fine.
Ha stabilito poi che:
- ogni persona ha diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo;
- ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso;
- ai fini della presente legge sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e la idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici;
- qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta le conseguenze di questa decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica;
- il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo;
- il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali; a fronte di queste richieste il medico non ha obblighi professionali.
All’art. 2 ha previsto che «il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico».
Ha sancito inoltre espressamente “il divieto” di ostinazione irragionevole nelle cure ed ha individuato come oggetto di tutela da parte dello Stato «la dignità nella fase finale della vita». «In presenza di sofferenze refrattarie a trattamenti sanitari» il medico, con il consenso del paziente, può di fatto sospendere anche l’idratazione e l’alimentazione e procedere alla terapia del dolore con sedazione profonda.
La legge peraltro non ha in alcun modo limitato i casi in cui il paziente ha “diritto” di “rifiutare trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza” e tra questi ha incluso anche quelli tesi a fornire nutrimento alla persona (idratazione e alimentazione artificiali), prevedendo inoltre al primo comma dell’art. 2 che al paziente sia in ogni caso garantita un’appropriata terapia del dolore. Dai lavori preparatori della legge e dalle discussioni parlamentari emerge che il Parlamento era consapevole che il prevedere per il paziente la possibilità di rifiutare la nutrizione artificiale comportava di fatto riconoscere il suo diritto di scegliere di morire non già a causa della malattia, ma per la privazione di sostegni vitali (ovvero per una cosiddetta eutanasia indiretta omissiva). Nonostante ciò, anche questa decisione, come tutte quelle in campo terapeutico, è stata prevista come insindacabile. La norma prevede solo che, nel caso il paziente rifiuti un trattamento “salva vita”, ovvero scelga in pratica di morire, debbano essergli prospettate da un medico le conseguenze della sua decisione e le possibili alternative alla stessa, nonché che sia promossa ogni azione di sostegno, anche psicologico, in suo favore.
La legge ha addirittura vietato interventi sanitari che, al fine di proteggere “la sacralità della vita”, appaiano, alla luce delle condizioni del paziente, intrinsecamente inutili e sproporzionati. Ha altresì ribadito che i trattamenti devono rispettare le decisioni del paziente nel tutelarne “la dignità nella fase finale della vita”.
Nel caso di malattia, dunque, il diritto a decidere di “lasciarsi morire” è stato espressamente riconosciuto, a prescindere dalle motivazioni sottese a tale decisione, a tutti i soggetti capaci. Il fatto che non sia possibile sindacare le ragioni per cui una persona addiviene a questa scelta, è chiaro riconoscimento dei principi stabiliti dagli artt. 2 e 13 della Costituzione, in forza dei quali la libertà di ogni persona a disporre della propria vita non può essere limitata per fini eteronomi.
La legge in esame, peraltro, non ha riconosciuto il diritto al “suicidio assistito” secondo le modalità scelte dai singoli. Anzi all’art. 1 ha specificato che non è possibile richiedere al medico trattamenti contrari a norme di legge o alla deontologia professionale. Allo stato, pertanto, non è possibile pretendere dai medici del Servizio pubblico la somministrazione o la prescrizione di un farmaco che procuri la morte.
Peraltro, il mancato riconoscimento/regolamentazione da parte del Legislatore del diritto “al suicidio assistito” non può portare a negare la sussistenza della libertà della persona di scegliere quando e come porre termine alla propria esistenza, libertà che, come sopra esposto, trova fondamento nei principi cardine della Costituzione dettati agli artt. 2 e 13.
Il mancato riconoscimento del diritto “al suicidio assistito” porta solo ad escludere che si possa richiedere al Servizio Sanitario Nazionale un trattamento diverso da quello previsto nella L. n. 219/2017 (può richiamarsi in proposito la sentenza della Corte costituzionale n 185 del 2.5.98 che nell’affermare la illegittimità costituzionale di alcune norme contenute nel D.L. 17 febbraio 1998 n 23 – disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico ed altre misure in materia sanitaria – ha ribadito la libertà dell’individuo nella scelta delle cure a cui sottoporsi, sostenendo però che «non possono ricadere sul Servizio Sanitario Nazionale le conseguenze delle libere scelte individuali circa il trattamento terapeutico preferito, anche perché ciò disconoscerebbe il ruolo e la responsabilità dello Stato che le esercita attraverso i suoi organi tecnico scientifici»).
Le condotte sanzionate dall’art. 580 c.p.
I principi costituzionali che hanno ispirato, solo alcuni mesi fa, la formulazione e l’approvazione della legge n.219/17 devono presidiare, ad avviso di questa Corte di Assise, anche l’esegesi della norma in esame orientando l’interprete nell’individuazione del bene giuridico tutelato e, di conseguenza, delle condotte idonee a lederlo. E il riconoscimento del diritto di ciascuno di autodeterminarsi anche in ordine alla fine della propria esistenza porta a ritenere sanzionabili ai sensi dell’art 580 c.p. solo le condotte che “in qualsiasi modo” abbiano alterato il percorso psichico del soggetto passivo, impedendogli di addivenire in modo consapevole e ponderato a tale scelta (che, lo si ribadisce rappresenta l’espressione più radicale, ma anche la più significativa della libertà dell’individuo).
Il diritto penale, alla luce dei principi costituzionali ed Eurounitari più volte richiamati, deve intervenire a sanzionare, e nel modo più severo, le aggressioni da parte di terzi al bene della vita altrui ed è per ciò giustificato l’intervento repressivo anche quando questo avvenga con il “concorso” della volontà della vittima, se tale volontà sia stata in qualche modo alterata. Si avrà addirittura un «omicidio nel caso in cui l’altrui determinazione volitiva si sostituisca a quella della vittima, si da far apparire il suicidio come il frutto dell’altrui volontà e non di quella cosciente e libera della vittima»[26]. Inoltre il II comma dell’art. 580 c.p. prevede come aggravante il fatto che la persona istigata o aiutata abbia meno di 18 anni o sia inferma di mente, o versi in condizioni di deficienza psichica per altra malattia o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti (malattia mentale e deficienza psichica che devono ritenersi parziali, dal momento che se la persona fosse priva della capacità di intendere e volere, ricorrerebbe, così come nel caso di minori di anni 14, l’omicidio). E anche ciò rivela come il focus della norma sia la tutela della libertà e consapevolezza della decisione del soggetto passivo.
D’altra parte, il riconoscimento del diritto di ciascun individuo di autodeterminarsi anche su quando e come porre fine della propria esistenza, rende ingiustificata la sanzione penale nel caso in cui le condotte di partecipazione al suicidio siano state di mera attuazione di quanto richiesto da chi aveva fatto la sua scelta liberamente e consapevolmente. In quest’ultima ipotesi, infatti, la condotta dell’agente “agevolatore” si pone solo come strumento per la realizzazione di quanto deciso da un soggetto che esercita una sua libertà e risulta di conseguenza non lesiva del bene giuridico tutelato dalla norma in esame, salvo poter essere altrimenti sanzionata[27].
In ogni caso di suicidio si impone una indagine particolarmente rigorosa sul percorso deliberativo del soggetto passivo, in primo luogo sul suo stato di salute mentale, nonché sulle condizioni in cui ha vissuto e su tutti i fattori, tra cui il contributo di terzi, che possono aver inciso sulla sua decisione.
Comportamenti che alterano il processo di formazione della volontà dell’aspirante suicida possono essere realizzati non solo mediante la persuasione diretta verso questo gesto estremo, ma anche mediante interventi che pregiudichino il suo esame di realtà, che impediscano che alla persona vengano fornite tutte le informazioni, prospettate tutte le alternative del caso, attivati tutti i supporti per farlo riflettere ed eventualmente desistere dal suo progetto auto lesivo[28].
L’azione di chi interviene a supportare il proposito suicidario può d’altra parte consistere, così come si è verificato nel caso in esame, in interventi diretti nei confronti di una persona non isolata, non in stato di abbandono, in grado di attingere sostegno in tante altre persone per ponderare bene le proprie decisioni, e costretta a far ricorso ad un soggetto terzo solo perché impossibilitata fisicamente a realizzare da solo quanto deciso.
Inoltre, interpretando la norma nel modo più ampio, si dovrebbe punire, fra gli altri, anche chi abbia fornito contributi materiali al suicidio consistenti, così come esemplificato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 1998 citata, nell’aiutare l’aspirante suicida a trovare tutte le informazioni e le soluzioni per porre termine alla sua vita, interventi, quali quelli posti in essere da Valeria Imbrogno, che si erano accompagnati a tentativi di dissuadere Fabiano e che si erano tradotti di fatto in un aiuto a ponderare bene la sua scelta.
Si nota infine che, anche seguendo l’interpretazione restrittiva della norma, la possibilità di una indagine sul percorso deliberativo del suicida e la pluralità delle condotte che possono essere ritenute idonee ad alterarlo, appaiono elementi sufficienti a preservare la funzione preventiva dell’art. 580 c.p., proteggendo “le persone vulnerabili, anche contro azioni che minaccino la loro vita”.
La pena prevista dall’art. 580 c.p.
Gli artt. 3,13,25, II comma e 27, III comma della Costituzione impongono che la libertà dell’individuo possa essere sacrificata solo a fronte della lesione di un bene giuridico altrimenti non pienamente tutelabile, che la sanzione sia proporzionata alla lesione provocata così da prevenire la violazione e provvedere alla rieducazione del reo. In forza di questi canoni di offensività, ragionevolezza e proporzione della pena interviene il controllo della Corte Costituzionale rispetto alle scelte di politica criminale che sono riservate al Legislatore.
Ed è in relazione a questi principi che questa Corte di Assise, per tutti i motivi sopra esposti, ritiene che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, non siano sanzionabili. E tanto più che non possano esserlo con la pena della reclusione da 5 a 10 anni prevista dall’art. 580 c.p. senza distinzioni tra le condotte di istigazione e quelle di aiuto, nonostante le prime siano certamente più incisive anche solo sotto il profilo causale, rispetto a quelle di chi abbia semplicemente contribuito al realizzarsi dell’altrui autonoma deliberazione e nonostante del tutto diversa risulti nei due casi la volontà e la personalità del partecipe.
Un’esegesi dell’art. 580 c.p. che non distingua fra le condotte di aiuto sanzionate e quelle invece lecite appare pertanto in contrasto con la finalità rieducativa della pena che impone una costante «proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra»[29].
A rafforzamento di queste considerazioni appare utile richiamare la sentenza della CEDU nel caso Pretty che nell’affermare che per prevenire il rischio di abuso, la disciplina inglese, che sancisce «la natura generale del divieto di suicidio assistito, non è sproporzionata», ha tuttavia sottolineato che la stessa prevede la possibilità «di valutare in ciascun caso concreto tanto l’interesse pubblico ad avviare un’azione giudiziaria, quanto le esigenze giuste ed adeguate del castigo e della dissuasione». Illuminante in questo senso appare infine la diversificata disciplina sanzionatoria dettata la legge n. 194/78 relativa all’interruzione volontaria di gravidanza, una legge posta a tutela della donna e nel contempo del diritto alla vita (all’art. 1 è sancito che lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore della maternità e tutela la vita umana sin dal suo inizio), una legge che, così come l’art. 580 c.p., sanziona l’intervento del terzo in un atto che a certe condizioni è lecito[30].
Conclusioni
Sulla base di tutte le precedenti argomentazioni, questa Corte ritiene pertanto che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sulla legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e quindi a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio.
La norma è così interpretata dal diritto vivente in funzione del dato letterale dell’art. 580 c.p., del suicidio come un fatto in sé riprovevole e del diritto alla vita come tutelabile a prescindere dalla volontà dell’individuo. Questa interpretazione risulta però in violazione degli artt. 2,13,1 comma e 117 della Costituzione in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in forza dei quali il diritto a por fine alla propria esistenza costituisce una libertà della persona, facendo quindi ritenere non lesiva di tale bene la condotta di partecipazione al suicidio che però non pregiudichi la decisione di chi eserciti questa libertà.
Per questi motivi la sanzione indiscriminata di tutte le condotte di aiuto al suicidio e la previsione della stessa pena prevista per le condotte di istigazione, risulta in violazione dei principi di cui agli art.3, 13, II comma, 25, II comma, 27, III comma della Costituzione, che individuano la “ragionevolezza” della pena in funzione dell’offensività del fatto.
Pertanto, ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 87 del 11.5.1983 dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso.
PQM
Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. nei termini che seguono:
– nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio, per ritenuto contrasto con gli artt. 3,13,1 comma e 117 della Costituzione in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;
– nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, per ritenuto contrasto con gli artt. 3,13, 25, II comma e 27, III comma della Costituzione.
Sospende il presente procedimento a carico di Marco Cappato.
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale affinché, ove ne ravvisi i presupposti,
voglia dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., nella parte indicata.
Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Milano, 14 febbraio 2018
Il Giudice a latere Il Presidente
[1] Cfr. per la diagnosi, la sintesi anamnestica e le condizioni alla dimissione, quanto esposto nella relazione alla dimissione dall’Ospedale di Niguarda dell’8.9.2016.
[2] Cass. pen. Sez 1, n. 3147 del 6.2.1998.
[3] Cass. sez. I pen., n. 33244 del 9.5.2013.
[4] Cass. sez. I pen., n. 217748 del 16.10.2017.
[5] C. Cost. n. 240/2016.
[6] Cass. Sez. I pen., n. 3147 del 6.2.1998.
[7] Corte di Assise di Messina del 10.6.1997, imputato Munaò.
[8] G.U.P. del Tribunale di Vicenza 14.10.2015, imputato Tedde.
[9] Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 9/2017, pronunciata il 10.5.2017.
[10] Nella relazione introduttiva del Presidente della Commissione Ministeriale Appiani, si afferma «Non vi è dubbio, per ragioni che non è qui luogo a diffusamente ripetere, ma che si ricollegano con la prevalenza dell’interesse statuale e sociale sull’egoismo individuale, che la vita umana e l’integrità fisica siano beni, di cui non si può liberamente disporre» (vedi in lavori preparatori 1929 pt 1, 478).
[11] La Relazione al Re che aveva accompagnato il progetto definitivo del codice penale Rocco nel 1930 sottolineava la ratio della norma, che vedeva nel suicidio un atto inutilmente perseguibile ma che voleva sanzionare chiunque concorresse in qualsiasi modo nel fatto altrui, «il principio che l’individuo non possa liberamente disporre della propria vita, intesto in senso assoluto e rigoroso, indusse taluno ad affermare la penale incriminabilità del suicidio Prevalenti considerazioni politiche, ispirate a ragioni di prevenzione, ossia precisamente allo scopo di contribuire alla conservazione del bene giuridico della vita, impedendo che di essa si faccia scempio con più meditata preordinazione dei mezzi e con più ponderata esecuzione per tema di incorrere negli errori della legge penale, hanno indotto le legislazioni più recenti ad escludere il suicidio dal novero dei reati, limitando la punizione ai casi di partecipazione all’altrui suicidio».
[12] Corte Cost. n. 471/1990.
[13] La Corte Costituzionale, già nella sentenza n. 238/96 ha infatti affermato che gli interventi relativi alla salute coinvolgono «un diritto inviolabile, quello della libertà personale, rientrante tra i valori supremi, quale indefettibile nucleo essenziale dell’individuo, non diversamente dal contiguo e connesso diritto alla vita ed alla integrità fisica, con il quale concorre a creare la matrice prima di ogni altro diritto costituzionalmente protetto dalla persona».
[14] Come è stato più volte ribadito con riferimento al rifiuto alle emotrasfusioni espresse dai testimoni di Jeova, cfr. Cass. Sez. 3 n. 4211/07 e Cass. N. 2367 del 15.9.2008 in cui è stato affermato che alla persona è riconosciuto il diritto «di indubbia rilevanza costituzionale, di non curarsi, anche se tale condizione la esponga al rischio della vita stessa».
[15] Cfr. le diverse decisioni sulle vaccinazioni obbligatorie fra tutte Corte Cost. n. 307/1990.
[16] Sentenza del GUP di Roma del 23.7.2007.
[17] Cass civ. sez. I, 16.10.2007 n. 21748.
[18] In forza dell’art 117 della Costituzione “è da respingere l’idea che l’interprete non possa applicare la CEDU se non con riferimento ai casi che siano già stati oggetto di puntuali pronunce da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Al contrario, l’applicazione e l’interpretazione del sistema di norme della Cedu è attribuito in prima battuta ai giudici degli Stati membri, il cui dovere di evitare violazioni della Cedu li obbliga ad applicarne le norme, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte di Strasburgo, specie quando il caso sia riconducibile a precedenti della giurisprudenza del giudice Europeo. In tale attività interpretativa, che gli compete istituzionalmente ai sensi dell’art. 101, secondo comma Cost, il giudice comune incontra il solo limite costituito dalla presenza di una normativa nazionale di contenuto contrario alla CEDU. In tal caso, la disposizione interna va censurata innanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost, ove non sia in alcun modo interpretabile in senso convenzionalmente orientato” (Corte Cost. n. 68 del 2017).
[19] L’art. 2 della Convenzione prevede, sotto la rubrica diritto alla vita, che «il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale…». L’art. 8 sancisce, sotto la rubrica diritto al rispetto della vita privata e familiare, che «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine o alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».
[20] La sig.ra Pretty, paralizzata e affetta da una malattia neurodegenerativa (la SLA), presentò ricorso alla Corte di Strasburgo avverso il rifiuto del rappresentante della Pubblica accusa inglese di accordare un’impunità penale al marito qualora l’avesse aiutata a suicidarsi e contro la proibizione dell’aiuto al suicidio prevista dal diritto britannico, che a suo parere violava i diritti garantiti dagli artt. 2, 3, 8, 9 e 14 della Convenzione.
[21] Il ricorrente, cittadino svizzero, affetto da circa vent’anni da un disturbo bipolare, che aveva compiuto negli anni precedenti due tentativi di suicidio e subito più ricoveri in cliniche psichiatriche, e che dal 2004 era divenuto membro della Dignitas, si era rivolto invano a diversi psichiatri e presso diverse Autorità per ottenere l’autorizzazione a procurarsi, tramite detta associazione, il pentobarbital, per garantirsi la possibilità di morire senza dolore e rischio di insuccesso.
[22] Nell’affermare questo principio la Corte faceva riferimento espresso alle restrizioni relative all’interruzione volontaria della gravidanza.
[23] La ricorrente, un’anziana signora di ottant’anni, che non era affetta da una malattia invalidante, caratteristiche, ma voleva porre fine alla sua vita non riuscendo ad accettare il decadimento delle sue capacità fisiche e mentali legato all’invecchiamento, lamentava di non aver potuto ottenere dalle Autorità svizzere l’autorizzazione a procurarsi una dose letale di farmaco per suicidarsi. Sosteneva quindi la lesione del suo diritto di decidere il momento ed il modo di morire, in violazione all’art. 8 della Convenzione.
[24] Il codice penale svizzero si limita a punire l’aiuto o l’istigazione al suicidio, quando siano attuati «per motivi egoistici» (art. 115 c.p.). A sua volta l’omicidio del consenziente (art. 114 c.p.) è costruito come ipotesi penale attenuata sulla base dei motivi («chiunque, per motivi stimabili, e soprattutto per compassione, cagiona la morte di un uomo a seguito di una sua richiesta seria e pressante, è punito con pena detentiva sino a tre anni o con la pena pecuniaria»).
Nel diritto svizzero, le condizioni alle quali le sostanze letali possono essere prescritte sono contenute nelle linee guida dell’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, che fungono da codice deontologico per i sanitari, ma non provengono da una fonte governativa. Nelle stesse si ammette la possibilità di aiutare il suicidio dei pazienti nella fase terminale della loro malattia -e quindi anche di prescrivere la somministrazione di sostanze letali- quando la sofferenza sia diventata intollerabile ed il malato esprima una volontà in tal senso.
[25] Appare opportuno richiamare incidentalmente anche un’altra sentenza in materia di suicidio, quella relativa al caso Koch contro Germania (provvedimento del 19.7.2012), in cui è stato stabilito che il rifiuto dei giudici nazionali di esaminare nel merito la domanda del ricorrente, svolta in proprio, di ottenere l’autorizzazione all’acquisto di un farmaco letale per far conseguire una morte dignitosa alla propria consorte, anch’essa ricorrente prima del decesso intervenuto in corso di causa, integrava una violazione del diritto del ricorrente alla tutela della propria vita privata. Nella sentenza non veniva analizzato il diritto della donna ad ottenere il farmaco letale, ma solo quello del marito a vedere verificata detta istanza alla luce dei principi della Convenzione. Nella pronuncia, peraltro, veniva menzionata come premessa la giurisprudenza della Corte con riferimento ai casi Pretty e Haas ed è interessante la sintesi (o interpretazione autentica) di dette decisioni soprattutto con riguardo a quest’ultima causa in cui, si rileva, «la Corte ha ulteriormente sviluppato questa giurisprudenza -in tema di tutela della “autonomia personale” – riconoscendo il diritto di un individuo di decidere come e quando dovrebbe finire la propria vita, purché questi fosse in grado di formarsi una volontà libera».
Occorre infine far cenno a due recenti pronunce della CEDU con riguardo all’obbligo di rispettare lo sciopero della fame posto in essere da alcuni detenuti in cui si è affermato, in un caso, che la scelta degli organi dello Stato di non alimentare forzosamente il detenuto non poteva essere criticata essendo conseguenza dell’aver accettato il suo chiaro rifiuto di permettere qualsiasi intervento, benché le sue condizioni di salute comportassero un pericolo per la sua vita (cfr. Horoz v. Turchia del 14.8.2014) e, nell’altro caso, che l’alimentazione forzata che era stata praticata doveva ritenersi lecita, in quanto lo sciopero della fame -poi peraltro interrotto- era stato posto in essere dal detenuto non già per por fine ai suoi giorni, ma per far pressione sulle autorità nazionali per ottenere un cambio nella legislazione sugli stupefacenti ed una riduzione della pena, circostanza che “esclude la rilevanza dell’art 8 CEDU” (cfr. Rapaz v Svizzera del 26.3.2013).
[26] Cfr. la sentenza della Corte di Assise di Messina citata.
[27] Si potrebbero peraltro configurare altri reati, quale la violazione della legge sugli stupefacenti o sulle armi, la ricettazione di farmaci illegittimamente commercializzati, reati di pericolo per la collettività ecc.
[28] Seppure non sussista un dovere di dissuasione e siano limitati i casi in cui vige l’obbligo di impedire il suicidio, comunque le condotte che possono alterare il processo decisorio del soggetto passivo, così come osservato da autorevole dottrina, possono essere le più varie, come per esempio la rappresentazione falsa, esagerata o tendenziosa di mali o pericoli, le esortazioni, l’eccitazione… Nell’individuare la condotta che integra il reato di “concussione per induzione” di cui all’art. 317 c.p. la Corte di Cassazione ha affermato che “l’induzione” può assumere svariate forme (più blande della costrizione) quali «l’inganno, la persuasione, la suggestione, l’allusione, il silenzio o l’ostruzionismo, anche variamente ed opportunamente combinati tra di loro». Cfr. C. Cass. sez. 6 pen. n. 4958 dell’1.10.2003, nonché Cass. sez. 6 pen. 17285/2013.
[29] Cfr. tra le altre le sentenze della Corte Costituzionale n. 251 del 2012 e n. 341 del 1994.
[30] La disciplina relativa all’interruzione volontaria di gravidanza è significativa sia perché indica gli strumenti adottati dallo Stato per tutelare il diritto alla vita e per garantire che le scelte della donna siano coscienti e responsabili, sia perché prevede pene diverse nelle differenti situazioni, rivelando l’esigenza di una diversificazione del regime sanzionatorio nel punire le condotte che incidono sul diritto di autodeterminazione della donna, rispetto a quelle che non garantiscono la tutela del suo diritto alla salute, rispetto infine a quelle che violano i presupposti per l’esercizio della sua scelta Gli artt. 18 e 19 della legge n. 194/78, sanzionano “chi cagiona l’interruzione volontaria di gravidanza” rispettivamente senza il consenso della donna, ovvero con il suo consenso, ma senza l’osservanza delle disposizioni previste dalla legge. In questo secondo caso, il legislatore ha stabilito sanzioni diverse, a seconda delle norme violate (una pena fino a tre anni se è violato l’art 5 che prevede un insieme di attività demandate alla struttura socio sanitaria o al medico dirette ad informare compiutamente la donna ed a rimuovere le cause che la porterebbero all’interruzione della gravidanza, ed all’art. 8 che indica chi è autorizzato a praticarla; una pena da uno a quattro anni se è violato l’art. 6 e 7 norme che individuano i casi in cui l’interruzione di gravidanza può essere praticata; un aumento delle pene citate, fino alla metà, se la donna è minore di diciotto anni o interdetta o se non sono state osservate le previsioni dell’art 12 o 13 che disciplinano come garantire la libertà della volontà espressa e la consapevolezza per le donne infra diciottenni o interdette).