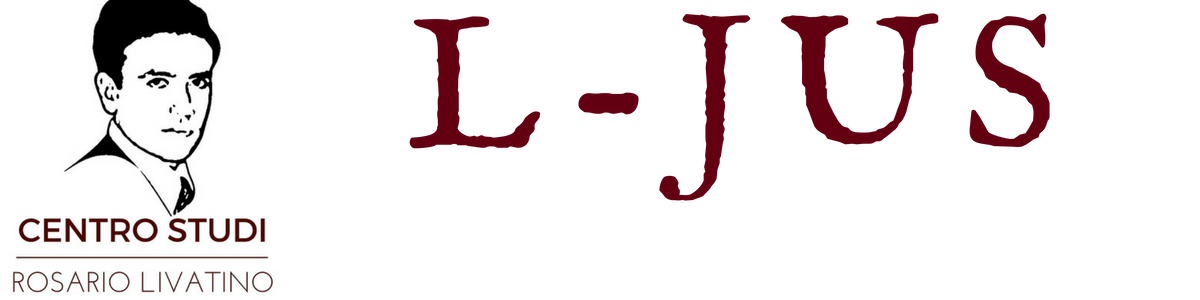TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
ORDINANZA PER LA FORMULAZIONE DELL’IMPUTAZIONE
A SEGUITO DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE NON ACCOLTA
Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Luigi Gargiulo, nel procedimento penale in epigrafe indicato, in cui è soggetto sottoposto alle indagini: MARCO CAPPATO, nato a Milano il 25/05/1971, difeso di fiducia dall’avv. Francesco di Paola del foro di Lagonegro e dall’avv. Massimo Rossi del foro di Milano, con studio in Milano P.za Sant’Ambrogio 16 presso cui è domiciliato In ordine al reato p. e p. dall’art. 580 c.p. commesso in data 27.2.2017 in Milano e Pfaffikon (CH).
RILEVATO
che il Pubblico Ministero procedente, con richiesta datata 02.05.2017 e pervenuta a quest’ufficio il successivo 04.05.2017, ha domandato l’archiviazione dei procedimento in epigrafe indicato;
che questo Giudice, con decreto del 10.05.2017, non ha accolto la richiesta di archiviazione e ha fissato udienza in camera di consiglio ex art. 409, co. 2, c.p.p. per il 06.07.2017;
che in data 30.06.2017 è stata depositata memoria da parte dei difensori dell’indagato;
che in data 04.07.2017 è stata depositata memoria da parte del PM;
che, all’udienza del 06.07.2017, udite le parti, il Giudice ha riservato la decisione.
A scioglimento della riserva, assunta all’udienza del 6.07.2017, il Giudice, per mezzo della presente ordinanza, dispone, ai sensi dell’art. 409, co. 5, c.p.p. l’imputazione coatta dell’indagato, in ragione dei motivi che seguono.
Una tale determinazione è frutto di un’attenta analisi del dato normativo nazionale, nonché delle fonti sovranazionali già richiamate dal PM e dalla difesa dell’indagato. Essa rifugge da qualsiasi pregiudizio assiologico sui delicati temi che il fatto pone in rilievo, bensì si fonda, come si vedrà di seguito, su un’analisi tecnica degli istituti giuridici sottesi alla vicenda in esame.
- IL FATTO
il 13 giugno del 2014 Fabiano Antoniani (detto Fabo) rimaneva coinvolto in un grave incidente stradale nel quale riportava lesioni midollari a due vertebre; da ciò derivava la paralisi totale e la cecità, pur rimanendo inalterate le sue facoltà intellettive.
Le cure, pur tempestive e prestate in centri altamente specializzati, non ottenevano la sperata guarigione, né si registrava alcun miglioramento delle condizioni di vita del paziente. Dopo diversi ricoveri e oltre un anno trascorso nell’unità spinale dell’Ospedale Niguarda, l’équipe medica dimetteva il paziente, il quale sarebbe stato poi curato ed accudito a casa propria, e, contestualmente, formulava un giudizio di irreversibilità di questa condizione. La situazione clinica viene attestata dal medico curante, dott. Ve., escusso a SIT in data 4.4.2017, nonché dalla cartella clinica che questi ha depositato in occasione della propria audizione.
Così il medico descrive la situazione di ANTONIANI: «Ho verificato le sue condizioni, cioè di persona tetraplegica, quindi immobilizzato e completamente insensibile, dal collo in giù, cieco a seguito di danno cerebrale, che si nutriva con dispositivo per la nutrizione enterale (p.e.g.) e respirava grazie ad un ventilatore inserito tramite un foro nella trachea (tracheostomia). Aveva un’incontinenza vescicale e la necessità di un supporto per lo svuotamento intestinale. Era affetto da sindrome dolorosa cronica con delle acutizzazioni periodiche di diversa intensità, tenute sotto controllo, da una terapia di fondo e dalla somministrazione aggiuntiva all’occorrenza. Era in grado di respirare senza il ventilatore per alcune ore durante il giorno e di parlare senza ventilatore, anche se in modo impastato a causa del danno cerebrale subito (…) Tutte le volte che ho visitato l’ANTONIANI, l’ho sempre riscontrato vigile, cosciente, lucido ed adeguato alle circostanze della comunicazione, non l’ho mai visto depresso» (verbale di SIT del 4.4.2017).
Di tale condizione si trae piena conferma dalle SIT della dott.ssa Marenghi, consulente del PM nominata in data 17.4.2017 ed escussa in pari data: «il paziente era affetto da una lesione neurologica gravissima e irreversibile, condizionante la cecità e una tetraplegia spastica Quest’ultima condizione determina, oltre all’impossibilità di movimento, un’insufficienza dei muscoli respiratori tale che la respirazione per essere efficace doveva essere supportata, almeno parzialmente, da un ventilatore. (…) Il dolore centrale, come quello di cui soffriva il paziente, nel suo parossismo può raggiungere intensità insopportabile. Per controllare il dolore di base e gli attacchi acuti è assolutamente necessaria la somministrazione di una terapia cronica con farmaci diversi (…) Difficile dire quanto avrebbe potuto sopravvivere senza supporti respiratori».
Dopo un infruttuoso ricorso ad un’ulteriore terapia in India[1] – tra fine 2015 e inizio 2016 – ANTONIANI faceva ritorno a Milano, di fatto nelle medesime condizioni in cui già in precedenza versava, nonostante le premurose cure prestategli da apposito personale e l’affetto dei propri cari.
Nel giro di pochi mesi, ANTONIANI maturava il proposito di porre fine alla propria esistenza[2] e, una volta vinte le resistenze della madre CAROLLO Carmela e della fidanzata IMBROGNO Valeria, quest’ultima entrava in contatto con l’odierno indagato, CAPPATO Marco, soggetto attivo nell’ambito dell’associazione “Soccorso Civile”, che si occupa di fornire assistenza ai soggetti che desiderano porre fine alla loro vita[3].
CAPPATO, dopo aver appreso, tramite IMBROGNO Valeria, la vicenda e la volontà di ANTONIANI, decideva di incontrare personalmente quest’ultimo: tra settembre e ottobre 2016 l’indagato fece più volte visita ad ANTONIANI, trovando «una persona esasperata dalla propria condizione, che ha espresso un’urgenza di porre fine alla propria vita. Tutte le volte che ci siamo visti sono servite a conoscerci»[4]. In tutti i dialoghi, peraltro resi assai complicati dalle evidenti difficoltà respiratorie di ANTONIANI, l’indagato ha sempre riconosciuto che “Fabiano era lucido e molto determinato nel suo proposito”[5].
CAPPATO, avendo ormai contezza del pieno, irremovibile proposito di ANTONIANI, provvedeva ad informare lo stesso che, per dar esecuzione ad un simile intendimento, si poteva ricorrere alla «strada svizzera, ma c’era anche la strada italiana, che avrebbe potuto consistere nell’interruzione di qualsiasi trattamento accompagnato dalla sedazione profonda»[6].
Scartata da ANTONIANI l’ipotesi di rinunciare ai trattamenti in corso, in conformità al diritto italiano, a causa dei patimenti che questa via avrebbe comportato, veniva presa invece in considerazione l’ipotesi di rivolgersi ad una struttura in Svizzera, segnalata da CAPPATO stesso, ovvero la Dignitas[7], con cui furono presi contatti. In particolare, segnala la fidanzata IMBROGNO che «previo interessamento del CAPPATO giunse via posta presso l’indirizzo di Fabiano un libretto Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari della Dignitas, ove venivano descritte le esatte procedure già narrate dallo stesso Cappato ed uno lista di documenti medici da presentare»[8].
Su insistenza di ANTONIANI, ad ottobre 2016 tutta la documentazione medica richiesta dalla Dignitas veniva spedita alla predetta associazione, dalla quale veniva ottenuto il “via libera” alla procedura richiesta; lo stesso ANTONIANI individuava nel 27.2.2017 la data in cui avrebbe voluto procedere alla realizzazione del proprio proposito[9].
In data 25.2.2017, attorno al mezzogiorno, CAPPATO, ANTONIANI, la madre (CAROLLO Carmela) e la fidanzata (IMBROGNO Valeria, quest’ultima su un diverso autoveicolo, insieme alla propria madre) si mettevano in viaggio verso la Svizzera.[10] L’odierno indagato si poneva alla guida dei veicolo di proprietà di ANTONIANI (e appositamente strutturato per poter accogliere quest’ultimo).
Una volta giunti in territorio elvetico, presso la clinica della associazione Dignitas, in data 26.2.2017 ANTONIANI veniva sottoposto ad alcune visite, volte ad accertare la volontà e le sue condizioni psico-fisiche[11], con esito favorevole.
L’indomani ANTONIANI veniva sottoposto ad un’ulteriore visita medica – anch’essa dava esito favorevole alla realizzazione dell’intento suicidario – al cui termine risultava perfezionato l’iter richiesto dalla Dignitas per accedere all’iniezione letale.
Nello stesso giorno, ANTONIANI, assistito dal personale della clinica, si toglieva la vita: mediante un apposito dispositivo che egli ha morso[12], ANTONIANI stesso ha dato corso all’iniezione del farmaco letale che lo ha condotto dapprima al coma profondo, quindi alla morte[13].
Il giorno successivo, 28.2.2017, CAPPATO Marco si recava presso i Carabinieri di Milano per esporre la vicenda di cui sopra.
- LA GIURISDIZIONE ITALIANA.
In via preliminare, è opportuno sgombrare ogni dubbio circa la sussistenza della giurisdizione italiana.
In primo luogo, si deve osservare che la condotta rimproverata a CAPPATO si è articolata in una serie di azioni, parte delle quali si sono evidentemente realizzate in Italia. Per quanto nel reato contestato la condotta si sia configurata in un ambito spaziale non unitario, si ritiene che debba trovare applicazione l’art. 6, co. 2, c.p., che prevede la sussistenza della giurisdizione nazionale quando «l’azione (…) che costituisce (il reato) è avvenuta in tutto o in parte (nel territorio dello Stato)». Tale norma è interpretata dalla Suprema Corte in modo estremamente ampio, in quanto si ritiene sufficiente che nel territorio nazionale si sia verificato «anche solo un frammento della condotta, (…) seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo» (Cass. Pen., sez. IV, sent. 20 gennaio 2017, n. 6376).
Il codice penale, nel libro Ti, titolo XII, capo I – all’interno, cioè, del novero di fattispecie poste a presidio della vita e dell’incolumità – punisce, all’art. 579 c.p., l’omicidio del consenziente e, al successivo art. 580 c.p., l’istigazione o l’aiuto al suicidio.
Si tratta di precetti che proteggono il bene giuridico vita in situazioni del tutto peculiari, ovvero qualora vi sia il consenso dei soggetto passivo a farsi uccidere per mano dell’agente (art. 579 c.p.) o quando vi sia, invece, l’istigazione o l’agevolazione dell’altrui suicidio (art. 580 c.p.).
L’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) punisce il fatto di colui che cagiona la morte di un uomo, con il consenso di questi. L’unico elemento specializzante rispetto all’art. 575 c.p. – e che, quindi, connota in modo palese questa ulteriore fattispecie – si deve rinvenire appunto nella manifestazione del consenso da parte del soggetto passivo: la mitigazione del trattamento sanzionatorio deriva, infatti, dalla minore gravità del gesto omicidario, sia sul piano soggettivo – essendovi il proposito non di aggredire il bene giuridico altrui, bensì di assecondare la volontà di un’altra persona – sia sul versante oggettivo, poiché non v’è alcuna ingerenza nell’esercizio della libertà della vittima. Ovviamente, ciò che deve essere valutato con particolare rigore ed attenzione è, appunto, il valido consenso formulato da parte del soggetto passivo: questo dev’essere serio, esplicito, inequivocabile e perdurante sino al momento finale (così, da ultimo, Cass. Pen., sez. I, n. 32851/2008).
L’art. 580 c.p., invece, si configura quale autonoma e specifica forma tipizzata di concorso. In primo luogo, giova osservare che tale fattispecie punisce condotte (la determinazione, il rafforzamento dell’altrui proposito, l’agevolazione dell’esecuzione) che si collocano in rapporto di funzionalità rispetto ad un gesto, quello suicidario, che rimane (ovviamente) impunito dall’ordinamento. Inoltre – altro elemento di particolarità, oggetto di ampia critica da parte della dottrina – questo precetto punisce allo stesso modo condotte profondamente differenti, poiché sanziona da un lato il fatto di chi determina taluno a togliersi la vita (istigazione o determinazione al suicidio), dall’altro, invece, il sostegno (morale o materiale che sia) nella realizzazione di una decisione già autonomamente deliberata da parte del soggetto. Delle tre condotte punite dalla norma, due rientrano nel perimetro del c.d. concorso morale (la determinazione al suicidio ovvero il rafforzamento di tale proposito), l’ultima, invece, formulata in termini assai ampi, sanziona il fatto di chi in qualsiasi modo, agevoli l’esecuzione dell’intento suicidario (concorso materiale).
Ovviamente, quale che sia la condotta incriminata nel singolo caso di specie, non si può prescindere da una rigorosa verifica del nesso di causalità tra l’azione (o l’omissione) posta in essere dal soggetto attivo e l’evento morte: id est; sarà fonte di penale responsabilità soltanto quel fatto senza il quale quel suicidio non sarebbe avvenuto (o non sarebbe avvenuto in quel momento e con quelle modalità).
Da queste brevi analisi, discende ictu oculi l’elemento discriminante tra le fattispecie in esame: nel primo caso, l’azione determinante la morte della vittima si riconduce ad un soggetto terzo rispetto ad essa; nel secondo, al contrario, è il suicida a compiere in persona quel gesto da cui discende il fatale esito. Illuminante, a questo proposito, un passaggio di un fondamentale pronunciamento della Suprema Corte in materia: «si avrà istigazione o agevolazione al suicidio tutte le volte in cui la vittima abbia conservato il dominio della propria azione, nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazione o di aiuto alla realizzazione del suo proposito, e lo abbia realizzato, anche materialmente, di mano propria» (Cass. Pen., sez. 1, n. 3147/1998).
Tale distinzione, che pure appare tanto palese, risulta fondamentale per una corretta qualificazione dei fatti ove ci si trovi in una di quelle vicende che, spesso con indebita approssimazione, si riconducono sotto l’ampia e generica nozione di eutanasia.
- LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA CONDOTTA DI Marco Cappato NELL’ALVEO DELL’ART. 580 C.P.
Sulla scorta delle considerazioni operate in precedenza, merita condivisione (salvo quanto si dirà tra breve) l’approdo del PM secondo cui «la condotta posta in essere da Marco CAPPATO, come sopra ricostruita, deve essere inquadrata all’interno della fattispecie di cui all’art. 580 c.p., ed in particolare tra le condotte di partecipazione materiale al suicidio»[14].
Se si osserva la dinamica dei fatti, si ricorderà che la morte di ANTONIANI è stata determinata dall’iniezione di un farmaco letale che è stata direttamente causata da un gesto del suicida: a tale scopo, infatti, era stato costruito un apposito dispositivo che quest’ultimo ha potuto azionare con l’unica attività motoria consentitagli dalla propria condizione, ovvero un morso. Di talché, pare evidente come la morte sia derivata quale diretta conseguenza dell’autonomo, consapevole e desiderato gesto di Fabiano Antoniani.
L’analisi della vicenda, per come innanzi ricostruita, di svela la natura morale (sotto il profilo dei rafforzamento del proposito suicidario) e materiale dell’ausilio fornito da CAPPATO. Egli, infatti, non solo ha solo agevolato materialmente l’esecuzione del suicidio, ma anche rafforzato l’altrui proposito.
Si noti, infatti, che, in interrogatorio, l’indagato ha asserito, in ordine alla possibilità di ANTONIANI di rinunciare alle terapie: «io ho fatto qualcosa di più. Almeno in tre occasioni gli ho spiegato che c’era la strada svizzera, ma c’era anche la strada italiana, che avrebbe potuto consistere nell’interruzione di qualsiasi trattamento accompagnato dalla sedazione profonda (…) io ho fornito i contatti, ma poi li hanno contattati loro. Io ho indicato la Dignitas, e non altri centri della Svizzera italiana, perché so che sono più affidabili e lavorano in modo più serio» (cfr. fogli nn. 6 e 7 de) l’interrogatorio del 3.4.2017).
Sul punto, la sig.ra IMBROGNO ha riferito che «previo interessamento del CAPPATO, giunse via posta presso l’indirizzo di Fabiano, un libretto della Dignitas, ove venivano descritte le esatte procedure già narrate dallo stesso CAPPATO ed una lista di documenti medici da presentare per avviare il procedimento» (cfr. foglio n. 2 SIT di IMBROGNO Valeria).
In effetti, il desiderio di morire, già espresso dal malato, era – in considerazione delle condizioni fisiche dello stesso – privo di effettive possibilità di attuazione; soltanto grazie all’intervento e al successivo consulto con l’indagato, si è trasformato in una possibilità concreta, cosicché è evidente che tale decisione si è evoluta e rafforzata: Fabiano Antoniani voleva morire, prima di conoscere CAPPATO; dopo i colloqui avuti con lo stesso, voleva suicidarsi con le modalità offerte dalla Dignitas, la cui “serietà” gli era stata garantita dall’indagato.
Il rafforzamento della altrui volontà e l’agevolazione dell’altrui suicidio – ovvero le condotte di CAPPATO – attengono ad una fattispecie concreta, ineriscono a “quel suicidio”, non già alla generica volontà di morire: infatti soltanto rispetto al singolo fatto verificatosi si debbono valutare il rafforzamento della volontà e l’agevolazione. Quindi: ANTONIANI fu consapevole e libero di suicidarsi, ma questa sua libertà fu esercitata dopo essere stato corroborato e guidato nella sua volontà.
Esaminato l’aspetto inerente il rafforzamento del proposito suicidario, è necessario interrogarsi circa la portata semantica dell’ultima parte dell’art. 580 c.p.: «chiunque (…) agevola in qualsiasi modo l’esecuzione (dei suicidio)».
Si tratta, invero, di una norma di scarsa ricorrenza all’interno della giurisprudenza, sia di merito, sia di legittimità.
In materia costituisce significativo precedente la già citata sentenza della Sezione I della Corte di Cassazione n. 3147/1998. In uno degli snodi dell’iter argomentativo del Supremo Collegio, si scorgono alcune sottolineature davvero meritevoli di attenzione. «La legge, nel prevedere, all’art. 580 c.p., tre forme di realizzazione della condotta penalmente illecita (…) ha voluto quindi punire sia la condotta di chi determini altri al suicidio o ne rafforzi il proposito, sia qualsiasi forma di aiuto o di agevolazione di altri del proposito di togliersi la vita, agevolazione che può realizzarsi in qualsiasi modo: ad esempio, fornendo i mezzi per il suicidio, offrendo istruzioni sull’uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o difficoltà che si frappongono alla realizzazione del proposito ecc., o anche omettendo di intervenire, qualora si abbia l’obbligo di impedire la realizzazione dell’evento. L’ipotesi della agevolazione al suicidio prescinde totalmente dalla esistenza di qualsiasi intenzione, manifesta o latente, di suscitare o rafforzare il proposito suicida altrui. Anzi presuppone che l’intenzione di autosopprimersi sia stata autonomamente e liberamente presa dalla vittima, altrimenti vengono in applicazione le altre ipotesi previste dal medesimo art. 580».
Il significato della terza delle condotte incriminate dall’art. 580 c.p., quindi, può essere delineato grazie alle limpide parole della Corte di Cassazione.
In primo luogo, l’impiego del verbo agevolare denota già, in sé, l’intenzione del legislatore di sanzionare ogni condotta che materialmente renda possibile l’altrui convincimento. Anche facendo riferimento ad un qualunque dizionario della lingua italiana, al fine di cogliere il comune significato del verbo in questione, il termine in analisi viene spiegato come “rendere facile qualcosa, favorire qualcuno, assistere”: agevolare, in altre parole, non vuol dire altro che aiutare (come, peraltro, dice la stessa rubrica dell’art. 580 c.p.) consapevolmente un soggetto nella realizzazione di un proposito già consolidato. E, trattandosi di un reato a forma libera – come ribadisce la locuzione avverbiale successiva, “in ogni modo” – il concetto di “aiuto” riassume in sé ogni condotta che sia compiuta dal soggetto terzo e senza la quale l’esito mortale non si sarebbe verificato.
La seconda nozione che rileva è quella di “esecuzione”. Nella richiesta di archiviazione, il PM ne ha fornito una interpretazione particolarmente restrittiva, ritenendo di doversi limitare l’esecuzione a quella che viene definita come “fase esecutiva”: soltanto l’aiuto reso negli ultimi e decisivi frangenti che precedono il gesto finale potrebbero assumere rilevanza penale. Ogni altra condotta precedente, quali, ad esempio, il reperimento di mezzi o il trasferimento fisico della persona incapace di muoversi verso il luogo prescelto, sarebbe, adottata quest’impostazione, irrilevante, in quanto mero atto preparatorio.
Questo Giudice ritiene di dissentire dall’esegesi fornita dal PM.
In primo luogo, la formulazione della norma in esame appare evidentemente orientata a riassumere in sé – e quindi a punire – ogni condotta che abbia dato un apporto causalmente apprezzabile ai fini della realizzazione del proposito suicidario. Restringere l’applicazione alla soia fase che immediatamente precede l’evento mortale (nel caso di specie, alla predisposizione dell’iniezione letale in Svizzera) comporterebbe quindi togliere ogni rilevanza a condotte che, invece, hanno agevolato in modo palese la concretizzazione dei suicidio.
Una tale impostazione non risulta affatto convincente, come si può cogliere da un illuminante passaggio della già richiamata sentenza n. 3147/1998 del Supremo Collegio, secondo cui «si avrà agevolazione al suicidio se l’agente si limita a fornire alla vittima, su richiesta di quest’ultima e conoscendo l’uso che ne farà, l’arma che poi essa utilizzerà contro se stessa». Ancora, la Corte, nel prosieguo della medesima sentenza, esemplifica alcune condotte frequenti nell’ambito dell’art. 580 c.p.: «ad esempio, fornendo i mezzi per il suicidio, offrendo istruzioni sull’uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o difficoltà che si frappongono allo realizzazione del proposito ecc.».
Declinando i principi offerti dalla Corte di Cassazione al caso in esame, si potrebbe delineare il seguente quadro.
Si immagini il caso di un soggetto, Tizio, che desideri togliersi la vita mediante l’assunzione di una sostanza venefica, ma non ne disponga e, impossibilitato all’autonoma deambulazione, ne faccia reperire una dose letale tramite una persona di fiducia, Caio, e se la faccia consegnare. Congedato quest’ultimo, a distanza di qualche tempo, avviene il suicidio di Tizio, il quale assume il veleno messogli a disposizione da Caio, tuttavia in assenza di quest’ultimo. Secondo l’impostazione promossa dalla Procura della Repubblica, non vi sarebbe alcuna agevolazione del gesto mortale.
Invece, qualora Caio avesse anche aiutato Tizio ad ingerire il veleno, ad esempio mescolandolo su richiesta del suicida, ad un’altra bevanda, Caio risponderebbe di agevolazione al suicidio, per il sol fatto che il suo contributo rientra nell’immediatezza della condotta suicidarla stricto sensu intesa.
Ciò che non persuade, a ben vedere, è il dispari trattamento da riservare a condotte che si pongono tutte come validi, necessari antecedenti causali del suicidio. Nella prima ipotesi, il gesto di Tizio non si sarebbe mai potuto compiere se non vi fosse stato l’intervento di Caio, poiché al primo non sarebbe pervenuto il veleno mediante il quale si è realizzato il proposito mortale. Se si ricorre al consueto schema logico per provare il nesso di causalità, è evidente come i risultati siano gli stessi e, quindi, come entrambe le condotte – vigente l’attuale art. 580 c.p. – meritino essere sanzionate.
Infatti, secondo la teoria condizionalistica, una condotta può essere considerata come causa di un evento se non può essere mentalmente esclusa senza che venga meno anche l’evento. Un antecedente può configurarsi come condicio sine qua non soltanto ove esso rientri nel novero delle cause che, sulla base di una successione regolare conforme ad una legge generale di copertura, portino ad un evento pari a quello concretamente verificatosi (sul punto, cfr. Cass., sez. IV pen., n. 7214/2004; Cass., sez. IV pen., 4793/1990). Ovviamente, onde evitare che tale meccanismo consenta un regresso all’infinito, l’ambito di rilevanza degli antecedenti viene ben delineato grazie all’elemento soggettivo (dolo/colpa), che consente di sceverare quelle condotte che assumono rilevanza rispetto alla fattispecie incriminatrice considerata.
La lettura restrittiva dell’art. 580 c.p. promossa nella richiesta di archiviazione si pone in chiara antitesi con una simile impostazione. Trattandosi di una fattispecie a forma libera, in cui numerose condotte possono sussumersi, l’adozione di una interpretazione così restrittiva finirebbe non solo per tradire la lettera stessa della norma, bensì per collidere anche con la teoria della causalità intesa come sopra: infatti, si toglierebbe (almeno potenziale) rilievo penale ad una condotta che sembra potersi inquadrare come antecedente rispetto all’evento finale.
Da tutte queste considerazioni, in tema di interpretazione e chiarificazione dei significato da riconoscersi al precetto penale in esame, si deve ricavare che qualsiasi condotta materialmente funzionale al proposito auto – soppressivo, purché l’agevolatore sia consapevole di tale progetto, è punibile ai sensi dell’art. 580 c.p., previa valutazione del nesso di causalità.
Tracciate queste coordinate, data per valida premessa la configurazione dei fatti entro l’art. 580 c.p., si deve ritenere che le condotte di CAPPATO non meritano essere archiviate, ma dovranno essere sottoposte all’attento scrutinio di un giudice di merito.
Come appare dalla ricostruzione dei fatti, l’odierno indagato ha, in piena consapevolezza:
* individuato l’associazione Dignitas, le cui strutture, in Svizzera, avrebbero consentito ad ANTONIANI una morte scevra dalle sofferenze che altrimenti avrebbe incontrato in Italia;
* offerto ad ANTONIANI la possibilità di suicidarsi utilizzando quelle strutture, in alternativa rispetto al ricorso alla terapia della “sedazione profonda” praticabile in Italia;
* fatto in modo che giungesse alla famiglia ANTONIANI materiale informativo in materia (cfr. SIT di Imbrogno Valeria);
* trasportato ed accompagnato personalmente, ponendosi alla guida del mezzo Fabiano Antoniani presso la clinica dell’associazione Dignitas;
* assistito alle procedure preparatorie del successivo suicidio.
L’intervento di CAPPATO nella vicenda di ANTONIANI è determinante: egli stesso è stato contattato in ragione della ampia conoscenza che aveva delle modalità con cui il proposito suicidarlo poteva essere concretizzato. Se si sottrae, nel quadro della vicenda, la condotta di CAPPATO, l’esito finale non sarebbe certo stato quello occorso lo scorso 27 febbraio: egli ha rafforzato il proposito suicidario e agevolato l’esecuzione dell’intento auto – soppressivo di ANTONIANI in primo luogo suggerendo la struttura dove ciò poteva accadere (in sostanza, egli ha permesso di trovare il mezzo tramite cui realizzare il suicidio), poi trasportandovi in concreto ANTONIANI stesso.
Sono certamente condotte che chiunque altro avrebbe potuto realizzare, con medesimo risultato: ciò che conta, tuttavia, è che senza di esse, non sarebbero state rimosse quelle difficoltà che impedivano ad ANTONIANI di perseguire il fine fortemente e liberamente voluto.
- LO STATO ATTUALE DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA IN PUNTO DI FINE VITA
Un approfondimento è altresì necessario quanto alle modalità con cui l’ordinamento italiano protegge e tutela il bene vita: è questo il punto di partenza necessario per vagliare se, nel nostro Paese, possa dirsi sussistente – almeno a certe condizioni – un diritto, esigibile dallo Stato, ad una “morte dignitosa”.
Per quanto la Costituzione repubblicana non menzioni expressis verbis la vita tra i diritti fondamentali di cui ogni persona gode, è pur evidente che la giurisprudenza (costituzionale e di legittimità) e la legislazione ordinaria hanno sempre inteso affermare la centralità dell’esistenza umana, quale indefettibile pre – condizione per il godimento di ogni altro diritto ed interesse dell’individuo.
La Corte costituzionale, in ogni caso in cui s’è trovata ad indagare il fondamento del diritto alla vita, ha sempre ritenuto che questo scaturisce, in prima battuta, dall’art. 2 della nostra Carta fondamentale, in quanto presupposto necessario per la piena manifestazione dell’individuo come singolo e come parte integrante della società. Ulteriore argomentazione è stata spesso ricavata dalla lettura dell’art. 27, co. 4, Cost., il quale vieta tassativamente il ricorso alla pena di morte, neppure di fronte al più deprecabile e riprovevole dei delitti.
La Consulta, nella propria attività di esegesi della Costituzione, ha affermato che «il diritto alla vita, inteso nella sua estensione più lato, sia da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono – per usare l’espressione della sentenza n. 1146 del 1988 – “all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana” (Corte Cost., sent. n. 35/1997)”». Con sentenza n. 223/1996, inoltre, la Corte ha ribadito, come già illustrato in precedenza, che «il divieto contenuto nell’art. 27, quarto comma, della Costituzione, e i valori ad esso sottostanti – primo fra tutti il bene essenziale della vita – impongono una garanzia assoluta».
Ancora, il Giudice delle leggi, con sentenza n. 238/1996, ha affermato che il diritto alla vita rappresenta «un indefettibile nucleo essenziale dell’individuo», in quanto il «diritto alla vita ed all’integrità fisica (…) concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona».
L’analisi di queste pronunce manifesta il chiaro intendimento di proteggere in modo particolarmente intenso il bene – vita e, in tale ottica, vi sono talune disposizioni di legge che ne ribadiscono la prioritaria rilevanza.
In tal senso, spicca l’art. 5 c.c., il quale vieta ogni atto di disposizione del proprio corpo, ove esso causi una diminuzione permanente della integrità fisica o quando sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Per consolidata tradizione, da questo articolo dei codice civile si fa discendere la natura irrinunciabile ed indisponibile del diritto all’integrità fisica: per quanto ciascun individuo sia libero di determinarsi, l’ordinamento vieta che l’esercizio di tale diritto possa condurre ad una menomazione definitiva dei proprio corpo, salvo che la legge lo consenta espressamente. Donde, ovviamente, il divieto di ogni atto dispositivo della propria persona tale da comprometterne l’esistenza stessa.
Anche sul versante penalistico, come già osservato, la tutela della vita si estende fino ad incriminare – e punire severamente – l’omicidio del consenziente e l’istigazione od agevolazione al suicidio (artt. 579 e 580 c.p.).
Si tratta, certo, di disposizioni risalenti, dettate in un contesto storico e sociale profondamente diverso da quello attuale, ma che, tuttavia, non sono mai stati oggetto di una rivisitazione, di talché dispiegano tuttora la loro piena efficacia, pur a fronte dell’evoluzione del pensiero, della percezione di numerosi fenomeni, delle tecniche medico – sanitarie.
Non deve altresì negarsi come, nel corso del tempo, anche il diritto – bene vita abbia trovato qualche bilanciamento: la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 27/1975, ad esempio) ne ha ammessa una ponderazione nella materia dell’interruzione volontaria della gravidanza. Ancora, nella nota vicenda Englaro, la Corte di Cassazione ha stabilito che «deve escludersi che il diritto all’autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita» (Cass. Civ., Sez. I, n. 21748/2007).
Di conseguenza, è lecito interrogarsi se, a fronte di un diritto che può essere in qualche modo bilanciato, esista un eguale e contrario diritto a “morire” in condizioni dignitose, qualora la conservazione della vita possa risultare, per sofferenze fisiche e/o patimenti morali, un onere insopportabile.
Va preliminarmente chiarito che, sul punto, non esiste alcuna disposizione normativa vigente nell’ordinamento italiano: questa lacuna – quanto mai evidente ed acuita dai numerosi casi di cronaca che si susseguono in terna di “fine – vita” – rende particolarmente complesso il compito di ogni Giudice che si trovi ad esercitare il proprio ufficio in questioni così delicate, poiché come scandisce l’ari. 101 Cost. – egli soggiace soltanto alla legge, e di essa sola può far applica: ione nei caso concreto.
Può, in tal senso, essere utile ripercorrere brevemente i casi Welby ed Englaro, ovvero gli ultimi due di fronte ai quali vi era stata un forte coinvolgimento mediatico e su cui, a vario titolo, erano intervenute le competenti autorità giudiziarie.
Eluana Englaro nel gennaio 1992 rimase vittima di un grave incidente stradale; a causa delle lesioni cerebrali estese ed irreversibili, fu dichiarata in stato vegetativo, condizione che esclude la coscienza di sé e dei mondo circostante e la possibilità di comunicare o interagire in alcun modo con l’ambiente esterno. Ella restava quindi relegata in una condizione tendenzialmente perpetua di totale incoscienza, alimentata artificialmente per poter rimanere in vita. Facendo leva su alcune testimonianze di amici e conoscenti che avevano udito Eluana esprimersi in favore della rinuncia ai trattamenti sanitari in casi simili, i genitori della ragazza avviarono l’iter giudiziario necessario ad ottenere l’autorizzazione alla sospensione delle cure in corso, posto che la ragazza non poteva, ovviamente, manifestare in via personale il proprio diniego. Dopo una complessa serie di pronunce, la Corte Cassazione civile, adita dal padre, con la sentenza n. 21748/2007 sancì che «in tema di attività medico – sanitaria, il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente non incontra un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita. Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c’è spazio – nel quadro dell’alleanza terapeutica che tiene uniti il malato ed il medico nella ricerco, insieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno – per una strategia della persuasione, perché il compito dell’ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza; e c’è, prima ancora, il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale. Ma allorché il rifiuto abbia tali connotati non c’è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico. Né il rifiuto delle terapie medico – chirurgiche, anche quando conduce alla morte, può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, giacché tale rifiuto esprime piuttosto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale». Ancora, «su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice – fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente – può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario, in sé non costituente, oggettivamente, una forma di accanimento terapeutico, unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione». Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte d’Appello di Milano, cui la Suprema Corte rimise la decisione, autorizzò la sospensione dei trattamenti, con la conseguenza della morte di Eluana Englaro, sopravvenuta in data 9.2.2009 (dopo 17 anni circa di sopravvivenza nelle circostanze suesposte).
Ben diversa la vicenda di Piergiorgio Welby: affetto da distrofia muscolare in forma progressiva sin dalla giovane età, nel 1997, a causa di una grave crisi respiratoria, fu sottoposto ad una tracheotomia. A Welby, dopo tale intervento, risultava inibito qualsiasi movimento di tutto il corpo, ad eccezione di quelli oculari e labiali, e la sua sopravvivenza era assicurata esclusivamente per mezzo di un respiratore automatico. La tipologia del morbo era tale che, sulla base delle attuali conoscenze medico – scientifiche, i trattamenti sanitari praticabili non erano in condizione di arrestarne in nessun modo l’evoluzione e, quindi, avevano quale unico scopo quello di differire nel tempo l’ineludibile e certo esito infausto, semplicemente prolungando le funzioni essenziali alla sopravvivenza biologica ed il gravissimo stato patologico in cui versa il ricorrente. Questa condizione lo spinse a chiedere più volte che gli venisse “staccata la spina”. Rifiutato il ricorso da parte dei legali di Welby con cui si chiedeva l’autorizzazione alla sospensione delle cure, in data 20.12.2006 veniva interrotta la respirazione artificiale e, previa sedizione da parte del medico anestesista, il paziente decedeva. Il dott. Riccio, che prestò la propria opera al servizio di Welby e che materialmente aveva provveduto a distaccare il respiratore, fu tratto a giudizio penale ma nei suoi confronti fu poi disposto, dal GUP di Roma, il non luogo a procedere, in quanto la sua azione fu scriminata dall’adempimento del dovere, ovvero il rispetto del rifiuto al trattamento palesemente e consapevolmente manifestato da parte di Welby stesso. Il GUP, nel proprio pronunciamento, dopo avere osservato la portata e il contenuto dell’art. 32, co. 2, Cost., rilevò che «rientrerà, ad esempio, nella previsione dell’art. 32, comma 2, Cost. l’ipotesi, volendo rimanere in tema, del distacco dal respiratore artificiale effettuato da un medico e non da un familiare o da un altro soggetto, poiché l’interruzione di una terapia, consentita dalla norma costituzionale, è quella che si pone all’interno di un rapporto terapeutico o comunque in stretta relazione con un trattamento sanitario. In ragione di ciò, gli attori del rapporto terapeutico instaurato sono, quindi, unicamente il medico ed il paziente. D’altra parte la lettera della norma è chiara “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario”» (GUP Roma, sent. 23.7.2007, imp. Riccio).
Dall’analisi dello stato della legislazione, nonché di due paradigmatici esempi (affini, ma profondamente dissimili per aspetti fondamentali rispetto a quello in trattazione), emerge con tutta evidenza come nel contesto attuale esista certamente un diritto a lasciarsi morire per mezzo del rifiuto di un trattamento sanitario, in ossequio al combinato disposto degli artt. 13 e 32 Cost.: se, infatti, nessuno può essere sottoposto ad una forma di terapia non voluta, discende immediatamente che il personale medico (ed ogni altra persona) dovrà accettare, senza opporsi od intervenire diversamente, la normale evoluzione delle patologie o delle condizioni che affliggono il paziente. In un simile caso, vi è l’esercizio di un diritto costituzionalmente protetto da parte del soggetto, mentre per tutti coloro che prestano la propria opera (od omettono di prestarla, poiché si astengono dall’effettuazione del trattamento non voluto) scatta, come correttamente osservato dal GUP di Roma nel procedimento a carico di Riccio, l’esimente di cui all’art. 51 c.p., con ciò scriminando una condotta che altrimenti risulterebbe de plano ricompresa nell’alveo dell’art. 579 c.p.
Giova evidentemente osservare che, in tali vicende, la risorte del paziente è sopravvenuta non già, per l’apporto di un elemento esterno, ad esempio un farmaco letale, bensì per la naturale evoluzione delle patologie, resa possibile dall’interruzione dei funzionamento dei dispositivi che consentivano la protrazione dell’esistenza e che sopperivano all’incapacità del corpo dell’individuo di adempiere ad una (o più) delle funzioni vitali indefettibili. Una volta acquisito il consenso – o ricostruito giudizialmente, come nel caso Englaro – del paziente, si è poi provveduto al distacco dei macchinari, in attesa che le condizioni dell’individuo ne conducessero il corpo ai fatale esito.
Tuttavia, nel caso oggetto di odierna analisi, dovrebbe ammettersi – sulla base di quanto chiesto dal Pubblico Ministero – la sussistenza di un altro e ulteriore diritto, rispetto a quello esercitato nei casi Welby ed Englaro: non quello al rifiuto di un trattamento sanitario (ipotesi che, peraltro, ANTONIANI rifiutò, poiché la sua condizione lo avrebbe portato ad una morte dolorosa e lenta), ma quello a “morire o suicidarsi con dignità”, con conseguente esclusione dell’antigiuridicità penale del comportamento di chi abbia coadiuvato il suicida.
Per quanto lo stesso art. 2 Cost. costituisca il fondamento della dignità della persona, non pare possibile fondare una lettura – quella proposta dal PM – dei medesimo articolo della Carta repubblicana che sancisca il diritto “alla morte dignitosa”. Il diritto a “lasciarsi morire”, infatti, si ricostruisce a partire da una disposizione della Costituzione, l’art. 32, co. 2, che esprime in modo palese la libertà di esprimere il rifiuto ad un trattamento sanitario, salvi i (rari) casi in cui sia la legge ad imporlo in via coattiva. La morte del paziente subentra, in questi casi, come conseguenza dell’esercizio (insindacabile) di questo diritto, purché il dissenso sia consapevole, manifesto e permanente.
Al contrario, la ricostruzione del presunto “diritto alla morte dignitosa”, ipotizzato dal PM, incontra un insormontabile ostacolo nell’assenza di una previsione normativa che facoltizzi una simile scelta.
La ricostruzione del PM risulta altresì aporetica nel momento in cui postula un diritto ad una morte dignitosa nei soli casi in cui vi siano «vite percepite, da chi le vive, come indegne, inumane, troppo dolorose per essere sopportate»[15]: qualora questo Giudice decidesse l’archiviazione sulla base di un simile argomento, sì ergerebbe, in modo totalmente vietato dall’ordinamento, a legislatore, poiché introdurrebbe nell’ordinamento un diritto inedito (con relativo accesso alla conseguente esimente) e, soprattutto, ne filtrerebbe l’esercizio, limitandolo ai casi in cui sussistano taluni requisiti, peraltro meritevoli di una formulazione generale, astratta e rispettosa del canone di precisione che una simile materia esige.
Si tratterebbe peraltro di un’interpretazione chiaramente contraria allo spirito e al tenore della legislazione penale vigente, poiché condurrebbe all’abrogazione (quanto meno parziale) degli artt. 579 e 580 c.p.
Ma v’è di più: una simile interpretazione, inoltre, in assenza di un quadro normativo chiaro ed univoco, introdurrebbe un concreto pericolo. Se, infatti, l’ordinamento appronta una forte tutela della vita, tale scelta appare orientata ad evitare che le persone in condizione di fragilità e debolezza (psicologica e fisica) possano essere indotte a comportamenti autolesivi senza un’accurata riflessione e ponderazione delle proprie scelte. Ammettendo il diritto ad una morte dignitosa (per mano propria, previa altrui agevolazione, o direttamente per mano altrui) per coloro che percepiscono la loro esistenza come troppo dolorosa, il rischio di un eccessivo, incontrollato accesso a tale opzione sarebbe assai concreto: si pensi ai casi di persone che percepiscono l’indegnità della propria vita a causa di patologie depressive, il cui giudizio sulla propria esistenza è pesantemente inficiato da tale condizione.
Pur rifuggendo qualsiasi approccio confessionale o di carattere “paternalistico”, pare evidente che l’affermazione di un diritto ad una morte dignitosa si porrebbe in palese contrasto con lo spirito della Carta costituzionale e con diverse norme della legislazione vigente.
5.1 IL DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
Come noto, in data 20.4.2017 la Camera dei Deputati ha approvato, con 326 voti favorevoli e 37 contrari, un Disegno di Legge in materia di Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, onde porre – almeno parziale – rimedio al vuoto normativo sussistente nella legislazione italiana in punto di fine vita. Si è infatti osservato in precedenza come lo stesso diritto a “lasciarsi morire” sia stato affermato attraverso una complessa ricostruzione a partire dalla Carta costituzionale, in assenza di una disciplina che stabilisca una procedura univoca per l’accertamento della volontà del malato e per ottemperare alla di lui decisione di interrompere i trattamenti. Inoltre, le norme oggi al vaglio del Senato dovrebbero istituire, sotto il nome di DAT (disposizioni anticipate di trattamento) quello che è, nei linguaggio comune, designato come “testamento biologico”.
L’analisi della volontà legislativa attuale costituisce un utile termine di confronto per saggiare quale sia l’estensione della tutela della vita umana e quali possano essere i margini per bilanciare il bene – vita con la libertà di auto – determinazione.
Il testo, oggi al vaglio del Senato della Repubblica, esprime, all’art. 1, il fondamento costituzionale (artt. 2,13 e 32 Cost.) e pone al centro un chiaro principio, quello del consenso informato, che costituisce l’indefettibile presupposto di ogni trattamento sanitario (o rifiuto dei medesimo). Il personale sanitario deve informare il paziente nel modo più adeguato e scrupoloso possibile, poiché il requisito per l’esercizio di ogni scelta è la piena consapevolezza delle proprie condizioni. In particolare, ai sensi dell’art. 1, co. 5, rientrano nel novero dei trattamenti sanitari la nutrizione e l’idratazione artificiale; quando il paziente manifesti il rifiuto di una cura necessaria alla propria sopravvivenza, sul medico grava un preciso onere informativo quanto alle conseguenze, ma questi (co. 6) è chiamato a rispettare la volontà altrui. A fronte della decisione del paziente, il sanitario è immune da ogni responsabilità civile e penale.
La legge, inoltre, al successivo art. 2, introduce il dovere del medico di adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche ove questi abbia rifiutato un trattamento proposto dal medico. Pertanto, qualora un soggetto dovesse rifiutare una cura “salva – vita”, avrebbe quantomeno garantita la possibilità di essere accompagnato alla morte con una terapia farmacologica che renda meno severa la sofferenza fisica.
L’art. 4 prevede che ogni persona maggiorenne e capace d’intendere e volere può, in previsione di una futura incapacità di autodeterminazione, esprimere le proprie volontà in materia di trattamento sanitario attraverso le cd. “DAT”. Esse, se assunte secondo i requisiti di legge, potranno essere disattese solo in caso di non corrispondenza della situazione clinica rispetto a quella prefigurata nelle disposizioni personali ovvero ove siano divenute possibili cure non prevedibili in precedenza, idonee a migliorare le condizioni dì vita. È altresì possibile, sulla base dell’art. 5, in caso di patologie croniche e invalidanti con prognosi infausta, provvedere ad una pianificazione delle cure tra paziente e medico, in vista di una eventuale futura incapacità del paziente di autodeterminarsi.
Se questo disegno normativo approdasse a buon esito, in Italia subentrerebbe una disciplina sulla cui base sarebbe pienamente legittimo (come già era: ma con un fondamento normativo ora stabile) il rifiuto di qualsiasi trattamento sanitario, anche “salva-vita”, purché il consenso sia validamente prestato. A tal fine, si risolverebbe il problema sussistente nei casi simili a quello di Eluana Englaro, soltanto a condizione che vi siano le DAT dei paziente (o una cura concordata anzitempo). Inoltre, si introdurrebbe una pacifica clausola di esclusione della responsabilità penale del medico che provveda all’interruzione del trattamento su specifica istanza del paziente: ciò al fine di evitare vicende giudiziarie analoghe a quelle in cui era incappato l’anestesista Riccio nel caso Welby.
Resterebbe, in ogni caso, impregiudicata la piena responsabilità penale per chi agevolasse o istigasse l’altrui suicidio, nonché per chi provvedesse a causare la morte di una persona consenziente. In altre parole, sarebbe pienamente possibile “lasciarsi morire, in modo dignitoso, previo consenso valido” in forza di un valido rifiuto, ma mai “farsi uccidere” o “farsi aiutare al suicidio”: per queste ultime due condotte, resterebbero vigenti ed applicabili le disposizioni di cui agli artt. 579 e 580 c.p.
La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) costituisce, nel panorama giuridico europeo, un fondamentale punto di riferimento quanto alla tutela dei diritti degli individui: di talché, le previsioni di tale Carta, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, debbono essere attentamente considerate ed analizzate, pur ricordando che «In mancanza di una specifica previsione costituzionale, le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), rese esecutive nell’ordinamento interno con legge ordinaria, ne acquistano il rango e quindi non si collocano a livello costituzionale» (così Corte Cost., sent. n. 349/2007).
La predetta Convenzione, stipulata nel 1950 e, in Italia, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955 n. 848, prevede due articoli che, nell’interpretazione poi fornita da parte della Corte EDU, possono venire in rilievo nella vicenda in esame. Segnatamente, l’art. 2 Convenzione prevede, sotto la rubrica “diritto alla vita”, che «Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena». L’art. 8, invece, rubricato “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”, sancisce che «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di tino autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».
Come già anticipato, le previsioni convenzionali assumono concreta forma attraverso la giurisprudenza della Corte EDU: il case law della Corte, infatti, stabilisce l’esatta portata ed estensione dei diritti tutelati dalla Convenzione, mediante l’individuazione di quei (singoli) casi in cui essi si assumono, o meno, violati. Questa considerazione merita particolare attenzione: la giurisprudenza EDU, infatti, si plasma sempre sulle peculiarità del caso di specie. Circostanza, questa, che rende difficile estrarre, dalla giurisprudenza della Corte, massime o principi tralatizi, in grado di applicarsi in futuro se non a casi esattamente sovrapponibili.
In ogni caso, il significato e il valore degli artt. 2 e 8 CEDU, in riferimento alla tematica qui in esame – ovvero, l’esistenza di un diritto al suicidio “in forma assistita” – si possono comprendere a fondo soltanto con una attenta disamina delle pronunce della Corte.
Un vero e proprio leading case – i cui approdi, seppur approfonditi in successive pronunce, sono tuttora incontroversi – è costituito dal caso Pretty v. Regno Unito (sentenza 29 aprile 2002, n. ric. 2346/2002), in cui la Corte EDU ha stabilito che la disciplina inglese che vieta il ricorso al suicidio assistito non si pone in violazione con gli artt. 2 e 8 CEDU. La vicenda, peraltro, aveva connotazioni assimilabili al caso di specie: la signora Diane Pretty completamente paralizzata a causa di una malattia neurologica, desiderava porre fine alla propria esistenza, tramite l’aiuto del marito. Poiché la legislazione inglese condannava l’aiuto al suicidio, la signora Pretty si rivolgeva alle autorità britanniche per ottenere un’attestazione della volontà di non procedere penalmente nei confronti del marito, nel caso in cui egli l’avesse aiutata nella commissione di questo atto. Poiché tale attestazione veniva negata, la signora Pretty si rivolgeva alla Corte di Strasburgo denunciando la legislazione inglese che impediva la sua scelta, invocando una violazione del diritto alla vita di cui all’art. 2 CEDU, di cui, secondo la sua prospettazione, il diritto a morire costituirebbe un corollario.
Si riportano direttamente taluni passaggi della sentenza, che ben manifestano l’itinerario argomentativo dei giudici di Strasburgo.
Testo in lingua originale
- 37: The Court’s case-law accords pre-eminence to Article 2 as one of the most fundamental provisions of the Convention (…). I safeguards the right to life, without which enjoyment of any of the other rights and freedoms in the Convention is rendered nugatory.
- 39: The consistent emphasis in all the cases before the Court has been the obligation of the State to protect life. The Court is not persuaded that “the right to life” guaranteed in Article 2 can be interpreted as involving a negative aspect.
- 40: The Court accordingly finds that no right to die, whether at the hands of a third person or with the assistance of a public authority, can be derived from Article 2 of the Convention.
- 62: The Court would observe that the ability to conduct one’s life in a manner of one’s own choosing may also include the opportunity to pursue activities perceived to be of a physically or morally harmful or dangerous nature far the individual concerned. The extent to which a State can use compulsory powers or the criminal law to protect people from the consequences of their chosen lifestyle has long been a topic of moral and jurisprudential discussion, the face that the interferente is often viewed as trespassing on the private and personal sphere adding to the vigour of the debate.
- 65: The very essente of the Convention is respect for human dignity and human freedom. Without in any way negating the principle of sanctity of life protected under the Convention, the Court considera that it is under Article 8 that notions of the quality of life take on significante. In an era of growing medical sophistication combined with longer life expectancies, many people ore concerned that they should not be forced to tinger on in old age or in states of advanced physical or mentol decrepitude which conflict with strongly held ideas of self and personal identity.
- 74: The Court finds (…) that States are entitled to regolate through the operation of the general criminal law activities which are detrimental to the life and safety of other individuals (…). The more serious the harm involved the more heavily will weigh in the balance considerations of public health and safety against the countervailing principle of personal autonomy. The law in issue in this case, section 2 of the 1961 Act, was designed to safeguard life by protectiog the weak and vulnerable and especially those who are not in a condition to take informed decisions against acts intended to end life or to assist in ending life. Doubtless the condition of terminally ill individuals will vary. But many will be vulnerable and it is the vulnerability of the class which provides the rationale far the law in question. It is primarily for States to assess the risk and the likely incidente of abuse if the general prohibition on assisted suicides were relaxed or if exceptions were to be created. Clear risks of abuse do exist, not withstanding arguments as to the possibility of safeguards and protective procedures.
- 76: The Court does not consider therefore that the blanket nature of the ban on assisted suicide is disproportionate. (…)
- 78: The Court concludes that the interferente in this case may be justified as “necessary in a democratic society” far the protection of the rights of others and, accordingly, that there has been no violation of Article 8 of the Convention.
Traduzione in Italiano[16]
La Corte, nella propria giurisprudenza, attribuisce la preminenza all’art. 2. L’art. 2 protegge il diritto alla vita, senza il quale il godimento di qualsiasi altro diritto e libertà garantiti dalla Convenzione sarebbe illusorio.
In tutti i casi che ha trattato, la Corte ha posto l’accento sull’obbligo per lo Stato di proteggere la vita. Non è convinta che il “diritto alla vita” garantito dall’art. 2 possa essere interpretato nel senso che comporti un profilo negativo.
La Corte ritiene, dunque, che non è possibile dedurre dall’art. 2 della Convenzione un diritto di morire, per mano di un terzo o con l’assistenza di una pubblica autorità.
La Corte osserva che la facoltà per ognuno di condurre la propria esistenza come vuole può anche includere la possibilità di dedicarsi ad attività fisicamente o moralmente pregiudizievoli o pericolose per la propria persona. La misura in cui uno Stato può ricorrere alla coercizione o al diritto penale per salvaguardare gli individui dalle conseguenze dello stile di vita scelto è da lungo tempo dibattuta, sia sotto il profilo morale sia in giurisprudenza, e il fatto che l’ingerenza venga spesso percepita come un’intrusione nella sfera privata e personale aggiunge vigore al dibattito.
La dignità e la libertà dell’uomo sono l’essenza stessa della Convenzione. Senza negare in nessun modo il principio della sacralità della vita protetto dalla Convenzione, la Corte rileva che è sotto il profilo dell’art. 8 che la nozione di qualità della vita si riempie di significato. In un’epoca in cui si assiste ad una crescente sofisticazione della medicina e ad un aumento delle speranze di vita, numerose persone temono di non avere la forza di mantenersi in vita fino ad un’età molto avanzata o in uno stato di grave decadimento fisico e mentale agli antipodi della forte percezione che hanno di loro stesse e della loro identità personale.
La Corte rileva tuttavia che gli Stati hanno il diritto di controllare, attraverso l’applicazione del diritto penale generale, le attività pregiudizievoli per la vita e la sicurezza dei terzi (…). Più grave è il danno subito e maggiore sarà il peso che avranno sulla bilancia le considerazioni di salute e di sicurezza pubblica di fronte al principio concorrente dell’autonomia personale. La disposizione legislativa contestata nella fattispecie, vale a dire all’art. 2 della legge del 1961, è stata concepita per salvaguardare la vita, proteggendo le persone deboli e vulnerabili – specialmente quelle che non sono in grado di adottare decisioni con cognizione di causa – da atti volti a porre fine all’esistenza o ad aiutare a morire. Certamente la condizione delle persone che soffrono di una malattia in fase terminale varia da caso a caso. Ma molte di tali persone sono fragili ed è proprio la vulnerabilità della categoria a cui appartengono che fornisce la ratio legis della disposizione in oggetto. Spetta, in primo luogo, agli Stati valutare il rischio di abuso e le probabili conseguenze degli abusi eventualmente commessi che implicherebbe un’attenuazione del divieto generale di suicidio assistito o la creazione di eccezioni al principio. Esistono rischi manifesti di abuso, nonostante le argomentazioni sviluppate in merito alla possibilità di prevedere barriere e procedure di protezione. Anche la Corte considera che la natura generale del divieto di suicidio assistito non è sproporzionata.
La Corte conclude che l’ingerenza in contestazione può essere considerata giustificata in quanto “necessaria, in una società democratica” per la protezione dei diritti altrui. Pertanto, non vi è stata violazione dell’art. 8 della Convenzione.
Nel caso Haas c. Svizzera (sentenza 20.1.2011, ric. N. 31322/07), il sig. Haas, affetto da sindrome affettiva bipolare, aveva tentato più volte di suicidarsi, ma aveva ricevuto ripetuti rifiuti dagli psichiatri ai quali si era rivolto per ottenere la prescrizione di pentobarbitale sodico; inoltre, si era visto respingere numerosi ricorsi proposti in sede amministrativa, in quanto non era ritenuto tale da trovarsi in condizioni di urgenza, che potessero giustificare il rilascio del farmaco senza prescrizione medica. A fronte di questa situazione, allora, Haas si rivolge alla Corte di Strasburgo, eccependo che l’impossibilità di trovare uno specialista disposto a effettuare la perizia psichiatrica ha reso il suo diritto di autodeterminazione del tutto illusorio e contestando la mancanza di giustificazioni di sanità pubblica nella norma che richiede la prescrizione medica per il rilascio del pentobarbitale.
Si riportano, anche per questa pronuncia, alcuni passaggi di spiccato interesse.
Testo in lingua originale
- 51: the Court considers that an individuat’s right to decide by what means and at what point his or her life will end, provided he or she is capable of freely reaching a decision on this question and acting in consequence, is one of the aspects of the right to respect for private life within the meaning of Article 8 of the Convention.
- 53: The Court considers that it is appropriate to examine the applicant’s request to obtain access to sodium pentobarbital without a medical prescription from the perspective of a positive obligation on the State to take the necessary measures to permit a dignified suicide. This presupposes a weighing of the different interests at stake, an exercise in which the State is recognised as enjoying a certain margin of appreciation (…), which varies in accordante with the nature of the issues and the importance of the interests at stake. For its part, the Court has jurisdiction to review in fine whether the domestic decision complies with the requirements of the Convention
- 55 (…) It must be noted that the vast majority of member States seem to give more weight to the protection of the individual’s life than to his or her right to terminate it. It follows that the States enjoy a considerable margin of appreciation in this area.
- 58: In particular, the Court considers that the risks of abuse inherent in a system that facilitates access to assisted suicide cannot be underestimated. (…) it is of the opinion that the restriction on access to sodium pentobarbital is designed to protect public health and safety and to prevent crime.
Testo tradotto liberamente, non essendo disponibili traduzioni ufficiali o pubblicate:
La Corte considera che il diritto di un individuo di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà, ammesso che egli o ella sia in grado di raggiungere liberamente una decisione su questa questione ed agire di conseguenza, è uno degli aspetti del diritto al rispetto della vita privata entro il significato dell’art. 8 Convenzione.
La Corte ritiene che è corretto esaminare la richiesta del ricorrente di ottenere pentobarbital di sodio senza una prescrizione medica entro la prospettiva di un obbligo positivo dello Stato di prendere le necessarie misure per permettere un suicidio dignitoso. Ciò presuppone una ponderazione dei differenti interessi in gioco, esercizio nel quale agli Stati è riconosciuto un certo margine di discrezionalità, che varia in base alla natura delle questioni e all’importanza degli interessi in gioco. Per suo compito, la Corte ha giurisdizione quanto alla valutazione se le decisioni interne si conformino ai requisiti posti dalla Convenzione.
Deve notarsi che la vasta maggioranza degli Stati membri sembra dare maggior peso alla protezione del diritto alla vita individuale piuttosto che al diritto di porvi fine. Segue che gli Stati godono di un considerevole margine di discrezionalità su questo punito.
In particolare, la Corte considera che i rischi di abuso insiti in un sistema che facilita l’accesso al suicidio assistito non Possono essere sottostimati. È opinione che la restrizione nell’accesso al pentobarbital di sodio è tesa a proteggere la salute e la sicurezza pubblica e a prevenire il crimine.
Nel caso Koch c. Germania (sentenza 19.7.2012, ric. N. 497/09), il ricorrente era Ulrich Koch, cittadino tedesco, la cui moglie, quasi completamente paralizzata a seguito di un incidente e costretta ad un trattamento di ventilazione artificiale e di cura infermieristica continua, aveva espresso la volontà di morire. In base alla valutazione medica, ella aveva un’aspettativa di vita di almeno quindici anni. I ricorsi amministrativi interni contro questa decisione, ed altresì quello costituzionale, si rivelarono infruttuosi. La sig.ra Koch aveva richiesto un’autorizzazione all’Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici al fine di ottenere una dose ‘letale’ di pentobarbital di sodio; l’Istituto però si era rifiutato di accordarla. Il 12 febbraio 2005, dunque, la signora Koch si suicidò in Svizzera, assistita dall’organizzazione Dignitas.
In questa sentenza, dopo aver ampiamente analizzato il profilo relativo alla legittimazione al ricorso da parte del marito (essendo la moglie defunta), la Corte dà ampio conto della propria precedente giurisprudenza (i già visti casi Pretty e Haas) e, in particolare, specifica (§ 71) che: Comparative research shows that the majority of Member States do not allow any form of assistance to suicide (compare paragraph 26, above and Haas, cited above, § 55). Only four States examined allowed medical practitioners to prescribe a lethal drug in order to enable a patient to end his or her life. It follows that the State Parties to the Convention are far from reaching a consensus in this respect, which points towards a considerable margin of appreciation enjoyed by the State in this context (also compare Haas, cited above, § 55). [Traduzione libera: La ricerca comparativa mostra come la maggioranza degli Stati Membri non consenta alcuna forma di assistenza al suicidio (si vedano il par. 26, sopra, e Haas, citata sopra, par. 55). Solo quattro stati esaminati permettevano ai medici di prescrivere un farmaco letale allo scopo di consentire al paziente di porre fine alla propria vita. Segue che gli Stati Parti della Convenzione sono lontani dal raggiungimento di un consenso sotto questo aspetto, il che indica il considerevole margine di discrezionalità di cui godono gli Stati in questo contesto].
Nel caso Gross c. Svizzera (sentenza 14.5.2013, ric. N. 67810/2010), invece, la ricorrente, la signora Alda Gross, nata nel 1931 e residente in Svizzera, non era affetta da alcuna particolare malattia. Tuttavia, la signora Gross aveva manifestato più volte la propria angoscia per il suo decadimento fisico e psichico ed aveva tentato il suicidio. Non essendo riuscita nel proprio intento, la signora Gross si era rivolta a diversi medici, per ottenere la prescrizione richiesta dalla legge svizzera sull’eutanasia per acquistare una dose letale di farmaci. Le sue richieste non erano tuttavia state accolte, poiché essa non poteva considerarsi malata terminale o affetta da una patologia tale da giustificare la prescrizione. La ricorrente si rivolgeva quindi al Comitato per la salute del Canton Ticino, ma anche in questo caso la sua domanda veniva rigettata. A nulla valevano le azioni giudiziarie intraprese successivamente nei confronti di detto provvedimento.
La signora Gross ricorreva quindi a Strasburgo, lamentando che le autorità svizzere, negandole la possibilità di acquistare la dose letale di medicine che le avrebbero provocato la morte, avevano violato il suo diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU.
Di seguito alcuni passaggi rilevanti.
Testo in lingua originale della sentenza
- 58: Without in any way negating the principle of the sanctity of life protected under the Convention, the Court has considered that, in an era of growing medical sophistication combined with longer life expectancies, many people are concerned that they should not be forced to finger on in old age or in states of advanced physical or mental decrepitude which conflict with strongly held ideas of self and personal identity (…). In the Pr. case, the Court was “not prepared to exclude” that preventing the applicant by law from exercising her choice to avoid what she considered would be an undignified and distressing end to her life constituted an interferente with her right to respect far her private life as guaranteed under Article 8 § 1 of the Convention (see Pr., cited above, § 67).
- 59: In the Ha. case, the Court further developed this case-law by acknowledging that an individual’s right to decide the way in which and at which point his or her life should end, provided that he or she was in a position to freely form his or her own judgment and to act accordingly, was one of the aspects of the right to respect for private life within the meaning of Article 8 of the Convention.
- 60: Having regard to the above, the Court considers that the applicant’s wish to be provided with a dose of sodium, pentobarbital allowing her to end her life falls within the scope of her right to respect for her private life under Article 8 of the Convention.
- 61. The Court further reiterates that the essential object of Article 8 is to protect the individual against arbitrary interferente by public authorities. Any interferente under the first paragraph of Article 8 must be justified in terms of the second paragraph, namely as being “in accordante with the law” and “necessary in a democratic society” for one or more of the legitimate aims listed therein.
- 62: Turning to the circumstances of the instant case, the Court observes at the outset that in Switzerland, pursuant to Article 115 of the Criminal Code, inciting and assisting suicide are punishable only where the perpetrator of such acts is driven to commit them by “selfish motives”. Under the case-law of the Swiss Federal Supreme Court, a dottor is entitled to prescribe sodium pentobarbital in order to allow his patient to commit suicide, provided that specific conditions raid down in the Federal Supreme Court’s case-law ore fulfilled.
- 65 The Court observes that the Federal Supreme Court, in its case-low on the subject, has referred to the medical ethics guidelines on the care of patients at the end of their life, which were issued by a non-governmental organization and do not have the formal quality of law. Furthermore, the Court observes that these guidelines, according to the scope of application defined in their section 1, only apply to patients whose dottor has arrived at the conclusion that a process has started which, as experience has indicated, will lead to death within a matter of days or a few weeks.
- The foregoing considerations ore sufficient to enable the Court to conclude that Swiss law, while providing the possibility of obtaining a lethal dose of sodium pentobarbital on medical prescription, does not provide sufficient guidelines ensuring clarity as to the extent of this right. There has accordingly been a violation of Article 8 of the Convention in this respect.
Testo tradotto liberamente, non essendo disponibili traduzioni ufficiali o pubblicate
Senza in alcun modo negare il principio della sacralità della vita protetto dalla Convenzione, la Corte ha considerato che, in un’epoca di progresso della scienza medica, combinato con aspettative di vita maggiori, molte persone sono preoccupate di non vedersi costrette a vivere fino a tarda età ovvero in condizioni di avanzato deperimento fisico e mentale che confliggono fortemente con le radicate idee di sé e della propria identità. Nel caso Pretty, la Corte “non era preparata ad escludere” che impedire, da parte della legge, al richiedente di esercitare la propria scelta di evitare quello che ella considerava potesse essere un indignitoso e doloroso termine della propria vita costituisse un’interferenza con il suo diritto al rispetto della vita privata, come garantito dall’art. 8.1 CEDU.
Nel caso Haas, la Corte sviluppava oltre questa giurisprudenza, mediante il riconoscimento che il diritto di un individuo di decidere il mezzo e il momento in cui la propria vita debba finire, ammesso che egli o ella fosse in una posizione di formare liberamente il proprio giudizio e fosse in grado di agire di conseguenza, era uno degli aspetti del diritto al rispetto della propria vita, all’interno del significato dell’art. 8 Conv.
Avendo riguardo a quanto sopra, la Corte considera che il desiderio della richiedente di essere dotata di una dose di pentobarbital, così consentendole di terminare la propria vita, ricade all’interno del diritto al rispetto della vita privata, entro l’art. 8 Conv.
La Corte inoltre ribadisce che l’obiettivo essenziale dell’art. 8 è la protezione degli individui di fronte ad arbitrarie ingerenze delle pubbliche autorità. Ogni ingerenza, ai sensi dell’art. 8 Conv., dev’essere giustificata nei termini del par. 2, cioè “secondo la legge” e “necessaria in una società democratica” per uno o più degli scopi legittimi ivi elencati.
Volgendo ora alle circostanze dei caso di specie, la Corte osserva, in esordio, che in Svizzera, secondo l’art. 115 codice penale, istigare o assistere al suicidio è condotta punibile soltanto ove l’autore di simili atti sia indotto a commetterli per “motivi egoistici”. Nella giurisprudenza della Suprema Corte Federale Svizzera, un dottore è abilitato a prescrivere il pentobarbital al fine di consentire al proprio paziente di suicidarsi, verificato che specifiche condizioni dettate dalla giurisprudenza della Corte Suprema svizzera siano pienamente rispettate.
La Corte osserva che la Suprema Corte, nella giurisprudenza sul punto, ha fatto riferimento a linee guida della deontologia medica in punto di cura dei pazienti alla fine della loro vita, che erano state varate da una organizzazione non governativa e non avevano la qualifica formale di legge in aggiunta, la Corte osserva che queste linee guida, in accordo con lo scopo della domanda definito nella propria sezione 1, si applicano soltanto a pazienti il cui medico sia arrivato alla conclusione che sia iniziato un processo che, sulla base dell’esperienza, condurrà alla morte nel giro di giorni o poche settimane.
Le suesposte considerazioni sono sufficienti per far ritenere alla Corte di concludere che la legge svizzera, mentre offre la possibilità di ottenere una dose letale di pentobarbital su prescrizione medica, non offre linee guida che assicurino chiarezza, come invece prevede il diritto. C’è stata una violazione della Convenzione sotto quest’aspetto.
Dai quattro pronunciamenti della Corte di Strasburgo fin qui osservati – gli unici noti sul punto – si possono trarre fondamentali indicazioni.
In primo luogo, la Convenzione tutela il bene vita in modo espresso e ne accentua la rilevanza in continuazione, tanto da esprimersi nei termini di sanctity of life.
Già dalla sentenza Pretty c. Regno Unito la Corte EDU ha sancito che, per quanto la vita privata non debba subire alcuna ingerenza da parte dell’autorità pubblica, «non è possibile dedurre dall’art 2 della Convenzione un diritto di morire, per mano di un terzo o con l’assistenza di una pubblica autorità» (§ 40). Se, quindi, ciascuno può disporre della propria vita in modo libero, ricorrendo – in modo autonomo – a gesti autolesivi o addirittura auto-soppressivi, non esiste alcun diritto al suicidio “assistito”: ciò si trae dal fatto che non è stata contestata alcuna violazione degli artt. 2 e 8 CEDU a quei Paesi che incriminino l’agevolazione o l’aiuto alla condotta suicidaria. Anzi: è costante, nella Corte, l’affermazione di esigenze di protezione di quei soggetti deboli che, per la malattia, la sofferenza, l’anzianità o simili cause, potrebbero essere portati a disporre in modo avventato o non lucido della propria esigenza. Nella stessa sentenza Gross, talvolta (erroneamente) indicata come la pronuncia che fonderebbe un presunto “diritto al suicidio assistito”, la violazione dell’art. 8 CEDU contestata alla Svizzera deriva non dal fatto che la legislazione elvetica subordini l’accesso al farmaco letale a certe condizioni, bensì dalla circostanza che tali requisiti siano definiti con rinvio ad una fonte non normativa. Quindi, ancora una volta, si deve trarre come è ben possibile, stante il margine di apprezzamento lasciato ai paesi membri (tra cui, peraltro, solo pochissimi lasciano spazio al suicidio “assistito” tout court), che uno Stato ammetta, soltanto a certe e chiare condizioni, pratiche di assistenza alla morte: ma non sarebbe mai censurabile, rebus sic stantibus, una legislazione che conservasse un totale divieto in tal senso (ovvero, conservasse le sanzioni penali per l’assistenza al suicido o per l’omicidio con consenso).
A conferma di tale orientamento, si può fare cenno alla Risoluzione n. 1859 del 25.1.201.2 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa che, avendo ad oggetto “la tutela dei diritti umani e della dignità in base alle volontà in precedenza espresse dai pazienti”, ha sancito, al proprio § 5: «This resolution is not intended to deal with the issues of euthanasia or assisted suicide. Euthanasia, in the sense of the intentional killing by act or omission of a dependent human being for his or her alleged benefit, must always be prohibited». [trad. libera: «Questa risoluzione non riguardo i temi dell’eutanasia o del suicidio assistito. L’eutanasia, nel senso dì un’intenzionale uccisione mediante un atto o un’omissione di un essere umano non indipendente, in vista di un suo presunto beneficio, deve sempre essere proibita»]. Questo atto – per quanto, ovviamente, non vincolante nei confronti degli Stati – ribadisce una volta di più l’orientamento seguito, sul punto, nell’ambito del Consiglio d’Europa: pieno rispetto della libertà di autodeterminazione, ivi inclusa la possibilità di scegliere se sottoporsi (o meno) ai trattamenti sanitari, ma totale rifiuto per tutte quelle pratiche attive volte a porre fine all’esistenza di un singolo, in quanto esse siano ritenute preferibili rispetto alla prosecuzione della vita in certe condizioni. Tale divieto, come già visto nella giurisprudenza CEDU, sorge dalla necessità di proteggere la vita specie ove i pazienti si trovino in condizioni di debolezza e vulnerabilità tali da esporsi a facili abusi del proprio consenso.
- SULLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ
La richiesta di archiviazione del PM si conclude con la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale «della stessa [norma, ovvero l’art. 580 c.p.] al fine di verificarne la compatibilità con i principi fondamentali di dignità della persona umana e di libertà dell’individuo, garantiti tanto dalla Costituzione italiana quanto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sulla base delle argomentazioni svolte in precedenza»[17].
Ad una simile richiesta, il PM addiviene sulla base delle seguenti argomentazioni. In primo luogo, il diritto alla vita, pur godendo di una tutela “ampia e pervasiva”, dev’essere ritenuto «bilanciabile con altri interessi parimenti fondamentali»; inoltre, il rispetto ai diritto della dignità umana, assume un “ruolo centrale”, poiché caratterizza l’essenza stessa del nostro ordinamento[18].
Nella misura in cui l’ordinamento, pur intendendo tutelare la dignità dell’individuo, non ammette forme di suicidio assistito in casi affini a quello di ANTONIANI, arriverebbe, secondo la ricostruzione dei Pubblico Ministero, a porre in crisi l’essenza stessa della dignità umana, poiché obbligherebbe un soggetto a vivere in condizioni ritenute «lesive della sua dignità umana». Il principio della dignità umana, in altre parole, imporrebbe, in aggiunta al diritto a “lasciarsi morire”, di riconoscere un vero e proprio «diritto al suicidio (…) in via diretta, mediante l’assunzione di una terapia finalizzata allo scopo suicidario»[19].
Ciò sulla base dell’assunto che «la giurisprudenza, anche di rango Costituzionale e sovranazionale, ha certamente inteso affiancare al principio del diritto alla vita tout court il diritto alla dignità della vita, inteso come sinonimo dell’umana dignità. In presenza di tale principio, dunque, (…) non si può negare il (…) diritto ad accedere a pratiche di suicidio assistito, tanto più se effettuate in un Paese membro del Consiglio d’Europa che ne riconosce la legittimità e disciplina rigorosamente i requisiti per accedervi»[20].
Di conseguenza, se si riconoscesse la presenza, nell’ordinamento, di un diritto a “morire dignitosamente”, in ragione di tale approccio, la condotta di CAPPATO sarebbe non (più) penalmente rilevante, poiché il suicidio sarebbe un diritto esigibile, quindi la condotta dell’indagato sarebbe non più offensiva di alcun bene giuridico. Ancora, sarebbe non sanzionabile in quanto egli concorrerebbe nell’esercizio di un diritto costituzionalmente protetto.
Con memoria depositata il 4.07.2017 il Pubblico Ministero ha precisato il dubbio di legittimità costituzionale di cui innanzi, chiedendo che la Corte Costituzionale sia investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., in relazione agli artt. 2,3,13,25 co. 2 e 3,32 co. 2 e 117 Cost., in riferimento agli artt. 2,3,8,14 CEDU, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi partecipa fisicamente o materialmente al suicidio di un “malato terminale o irreversibile” quando il malato stesso ritenga le sue condizioni di vita lesive della sua dignità.
Anche i difensori dell’indagato hanno chiesto che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art 580 c.p. con riferimento agli artt. 2,3,13,32 co. 2 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, nella parte in cui non esclude la punibilità di colui che agevola l’esecuzione del suicidio quando le circostanze di fatto lo configurano come diritto “in ragione di condizioni di vita ritenute non più dignitose”.
Entrambe le parti, quindi, chiedono che la Corte costituzionale introduca nell’art. 580 c.p., attraverso una pronuncia additiva, una causa di esclusione della punibilità che determini l’irrilevanza penale della condotta di agevolazione al suicidio quando tale condotta corrisponda al diritto del malato terminale o irreversibile di porre fine a una vita considerata non più dignitosa.
Come noto, perché si possa ricorrere alla Corte Costituzionale, occorre che sussistano due requisiti, ai sensi dell’art. 23, Legge 11 marzo 1953, n. 87, ovvero la rilevanza della norma di cui si sospetta l’incostituzionalità e la non manifesta infondatezza del contrasto con una previsione (o più d’una) della Costituzione.
La rilevanza dell’art. 580 c.p., nel caso di specie, risulta di palese evidenza, poiché è proprio sul significato e sul tenore della norma che si fonda la richiesta del PM e, poi, il vaglio di questo Giudice.
Non è tuttavia possibile rimettere la questione alla Consulta per manifesta infondatezza della questione: giova infatti premettere che, per costante interpretazione, tale filtro è posto allo scopo di evitare la prospettazione alla Corte di quesiti che appaiano sforniti di una solida base. Il giudice di merito deve rivolgersi alla Consulta solo in presenza di un dubbio sulla legittimità costituzionale della norma: questione che, in un ordinamento costruito sul controllo accentrato di costituzionalità, non può, né deve, essere sciolta autonomamente dal giudice a quo.
Ebbene, se questo giudice rimettesse alla Corte Costituzione le questioni di legittimità proposte dalle parti indurrebbe la Consulta ad una inevitabile pronuncia di inammissibilità.
Le pronunce additive, quali quella invocata, sono quelle con cui la Corte Costituzionale dichiara l’incostituzionalità di una determinata disposizione “nella parte in cui non prevede” qualcosa che dovrebbe costituzionalmente prevedere, supplendo a un’illegittima omissione del legislatore. Sono definite sentenze a rime obbligate, perché «una decisione additiva è consentita soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere il frutto dì una valutazione discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio di legittimità, sì che la Corte in realtà procede a un’estensione logicamente necessaria e spesso implicita nella potenzialità interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la disposizione impugnata» (C. Cost., 109/1986).
L’intervento additivo della Corte è quindi consentito solo quando il legislatore trascura di positivizzare un contenuto normativa che gli è imposto a tutela di diritti costituzionalmente garantiti.
Sono, viceversa, non consentite dall’ordinamento costituzionale le questioni con le quali si chiedono pronunce “creative” in presenza di pluralità di scelte normative possibili, in quanto volte a provocare decisioni additive o sostitutive a contenuto discrezionale, tali da far assumere alla Corte Costituzionale una funzione normativa che non le spetta e ad invadere la sfera di discrezionalità legislativa.
Già solo la lettura delle due richieste di remissione alla Corte Costituzionale, quella del PM e quella della difesa, dimostra che non è ipotizzabile una sentenza a “rime obbligate”: la difesa ritiene che l’art. 580 c.p. sia costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude la punibilità di colui che agevola l’esecuzione del suicidio quando le circostanze di fatto lo configurano come diritto «in ragione di condizioni di vita ritenute non più dignitose», mentre il PM circoscrive l’ipotizzata illegittimità costituzione ai casi di suicidio assistito del solo “malato terminale o irreversibile” quando il malato stesso ritenga le sue condizioni di vita lesive della sua dignità.
Invero, chiunque decide di porre fine alla propria vita giunge a quella conclusione dopo un lungo travaglio interiore che può essere provocato da sofferenze fisiche indicibili o da sofferenza morali inconsolabili. La scelta suicidaria, presuppone, per sua natura, una valutazione, da parte dell’individuo, del senso della propria vita nei termini dell’indegnità (ad es. il rimorso per un gesto compiuto) o dell’eccessivo peso (ad es. un lutto non rielaborato, la solitudine, la sofferenza fisica o una sopravvenuta menomazione fisica, ecc.).
Gli esempi di suicidi compiuti da persone non rientranti nella categoria dei malati terminali o irreversibili è amplissima e non per questo la sofferenza di tali persone dovrebbe essere ritenuta meno meritevole di attenzione.
Tali considerazioni, lungi dal voler avere carattere sociologico, sono la premessa di una conclusione obbligata: ovvero, non può essere rimessa alla Corte Costituzionale la scelta discrezionale di stabilire in quali situazioni l’agevolazione al suicidio non sia penalmente rilevante.
Già solo per questa ragione le questioni di legittimità sollevate sono manifestamente infondate.
Questo giudice, tuttavia, a prescindere da quanto appena esposto e da come la questione di legittimità costituzionale gli è stata posta, intende valutare se sussiste comunque un dubbio di legittimità costituzionale della norma in esame e quindi, se i principi della “dignità umana” o il diritto all’autodeterminazione possano costituire la base di tale dubbio.
Il PM ritiene che, qualora si acceda ad un’interpretazione estensiva dell’art. 580 c.p., tale da sanzionare penalmente la condotta agevolatrice del suicidio altrui in casi affini a quello di ANTONIANI – malattia irreversibile, accompagnata da profonde sofferenze fisiche e psicologiche, tali da rendere la prosecuzione stessa della vita un vero e proprio calvario – si entrerebbe in collisione con il diritto alla dignità umana, ricavato dagli art. 2 e 3 Cost., intesi questi ultimi anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU.
Una tale interpretazione riposa, tuttavia, su alcuni aspetti censurabili.
In primo luogo, la giurisprudenza costituzionale menzionata in punto di «dignità della figura umana»[21] non risulta del tutto persuasiva ai fini invocati. Si tratta peraltro di pronunce fra loro eterogenee per contenuti e per profili analizzati (con la Sentenza 471/1990 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell’istante; con la Sentenza 218/1994 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, terzo e quinto comma, della legge 5 giugno 1990, n.135 nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell’assenza di sieropositività all’infezione da HIV come condizione per l’espletamento di attività che comportano rischi per la salute dei terzi; con la Sentenza 194/1996 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 187, comma 2, del Codice della Strada che configura come reato il rifiuto di sottoporti all’accertamento del tasso alcolemico); inoltre, in nessuna di tali sentenze si può rinvenire un qualsiasi spunto od argomentazione che legittimi un’interpretazione della “dignità della vita umana” nel senso dì “diritto a morire in modo dignitoso” attraverso l’intervento di un’altra persona.
La Consulta, invece, ha sempre riconosciuto la centralità della vita umana, che – pur, a certe limitate condizioni, bilanciabile con altri diritti costituzionalmente sanciti – assume, nella complessità dell’ordinamento, una collocazione prioritaria indefettibile ed irrinunciabile.
La ricostruzione offerta dal PM pare inoltre aporetica sotto un ulteriore aspetto. Quand’anche si ammettesse che, a certe condizioni (malattie terminali o irreversibili, dolore fisico insopportabile, percezione dell’indegnità dell’esistenza), la vita possa essere interrotta perché la sua prosecuzione viola la dignità umana, si introdurrebbe un’evidente sperequazione nella tutela della vita umana, in quanto vi sarebbero vite meritevoli di essere vissute ed esistenze non meritevoli. Le prime, mai sacrificabili, e protette sempre ed in ogni caso da qualsiasi ingerenza esterna; le seconde, invece, rinunciabili in quanto indecorose, laddove, però, una simile valutazione andrebbe riconosciuta soltanto in presenza di requisiti non particolarmente limpidi e, soprattutto, di difficile accertamento (che cosa si intende per malattia irreversibile? come viene accertata la volontà suicidaria successivamente al decesso per le persone sole il cui unico affetto è quello della persona che lo ha aiutato a togliersi la vita?).
Un tale approdo, quindi, non solo colliderebbe con la già osservata centralità del bene vita, ma andrebbe ad indebolire la tutela proprio in quelle situazioni di fragilità e debolezza in cui il rischio di altrui ingerenze è particolarmente evidente: le norme di cui agli artt. 579 e 580 c.p., infatti, sono orientate proprio ad evitare si disponga di una “vita” in modo avventato o irrispettoso della stessa.
Non può inoltre dirsi che, l’intervento additivo sia reso necessario dall’asserita lesione dell’art. 32 Cost.
Tale disposizione, infatti, tutela il diritto all’autodeterminazione terapeutica anche qualora possa comportare il decesso dei paziente che scientemente decide di sospendere un trattamento terapeutico (c.d. eutanasia passiva), e non il diritto a essere assistiti nel suicidio quando si ritenga di voler porre fine alla propria vita (c.d. eutanasia attiva).
Merita attenzione, infine, l’affermazione dei PM secondo cui, a partire dagli artt. 2 e 8 CEDU, come interpretati dalla Corte di Strasburgo, si dovrebbe ricavare un «diritto ad accedere a pratiche di suicidio assistito, tanto più se effettuate in un Paese membro del Consiglio d’Europa che ne riconosce la legittimità e disciplina rigorosamente i requisiti per accedervi».
Tale lettura contrasta in modo palese ed evidente con le sentenze analizzate all’interno del par. 6. Sin dal caso Pretty c. Regno Unito del 2002 e poi nelle pronunce seguenti, mai la Corte EDU ha stabilito che esista un diritto al suicidio assistito, nel senso che gravi su un legislatore l’obbligo positivo di approntare una disciplina che renda praticabile tale via. Affermazioni quali quelle contenute ai paragrafi 39 e 40 della già citata sentenza Pretty – mai oggetto di revirement – valgono a sgombrare il campo da qualsiasi equivoco[22]. La Corte EDU, inoltre, ha stabilmente riconosciuto che, a fronte di una disomogeneità nelle scelte normative in punto di fine-vita, deve sussistere un margine di apprezzamento per ciascun legislatore, che, in ogni caso, deve tenere in debito conto «i rischi di abuso insiti in un sistema che facilita l’accesso al suicidio assistito non possono essere sottostimate»[23]. Nel caso Gross – l’ultimo esaminato dalla Corte EDU – la condanna della Svizzera è derivata in quanto le previsioni di accesso al suicidio assistito dipendevano da una fonte (linee guida) non normativa, quindi non dotata dell’adeguato carattere di generalità e stabilità richiesto. Se quindi non vi è mai stata una esplicita, diretta affermazione dell’obbligo di uno Stato di dotarsi di una legislazione in punto di suicidio assistito, ciò si deve al fatto che dal diritto a disporre della propria vita la Corte non ha mai tratto, come corollario, quello dell’esistenza di un diritto (esigibile) al suicidio assistito.
Di conseguenza, non si può ricavare dalla CEDU l’esistenza di un diritto al suicidio assistito quale declinazione della tutela della dignità umana.
Altresì inconferente appare il richiamo all’art. 3 Cost, ovvero al presunto vulnus al principio di uguaglianza. Nella propria memoria, il PM ritiene che la sanzione penale prevista dall’art. 580 c.p. renda impossibile, per un soggetto in condizioni analoghe a quelle di ANTONIANI, il gesto suicida: da un lato, perché il malato non può provvedervi in autonomia, dall’altro perché non può chiedere l’intervento di un terzo. Sulla scorta di tali considerazioni, il PM ritiene che il precetto in esame perpetri «una discriminazione grave, distinguendo dal punto di vista giuridico situazioni che presentano tratti sostanziali profondamente simili» (foglio n. 4 memoria dei 4.07.2017). Considerazioni analoghe sono state espresse dai difensori.
Questa considerazione appare tuttavia non condivisibile, per un motivo assai semplice: in Italia non esiste – né è riconosciuto dalla Costituzione – un diritto al suicidio. Pertanto, chi rivendica la possibilità di un’assistenza nel gesto suicidario chiede ciò che l’ordinamento non ha mai concesso ad alcuno, ovvero il diritto positivo – quindi esigibile – di potersi togliere la vita con l’intervento di un terzo.
Perciò, è di tutta evidenza come la denunciata incostituzionalità sorga da un percorso argomentativo che:
– ricava da alcune pronunce della Consulta un diritto alla “dignità umana” riconoscendovi un’estensione tale da legittimare il diritto al suicidio assistito, con tutte le implicazioni del caso;
– andrebbe a fondare una disparità di trattamento evidente tra “vite diverse” e che, in ogni caso, presenta criteri discretivi soggettivi;
– contraddice la stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, poiché da poche affermazioni, estrapolate in contesti e casi diversi, si pretende di ricavare ciò che quella Corte mai ha sancito;
– conduce ad un ampio annichilimento della portata precettiva degli artt. 579 e 580 c.p., non più applicabili a tutti i casi di omicidio del consenziente e suicidio assistito ove vi siano condizioni di vita del tenore descritto nella richiesta di archiviazione: in contraddizione con lo spirito delle norme e con la ratio che vi è sottesa.
Al contrario, l’art. 580 c.p. risulta pacificamente compatibile con il sistema costituzionale, né meritevole di alcun sospetto di illegittimità di fronte alla Carta repubblicana. Infatti, il precetto penale, come inteso dalla Corte di Cassazione, risulta pienamente coerente con la pervasiva e penetrante tutela accordata dall’ordinamento nazionale al bene vita e non contrasta in alcun modo con le previsioni e con la giurisprudenza CEDU. Ed è anche in linea con il disegno di legge al vaglio del Senato della Repubblica, poiché, nel caso in cui tale, progetto approdasse a buon fine, la tutela della vita risulterebbe inalterata.
L’opportunità di inserire – o meno – nella legislazione italiana pratiche di suicidio assistito – un quid pluris rispetto al disegno di legge in esame – è rimessa al solo Parlamento, unica istituzione accreditata, sulla base delle istanze espresse dal corpo sociale, ad introdurre un simile diritto.
La questione di legittimità costituzionale appare, in conclusione, manifestamente infondata.
- CONCLUSIONI
Nei paragrafi precedenti si è dato spazio ad una lunga ed approfondita analisi degli aspetti fondamentali della vicenda, posti in luce dal PM nella richiesta di archiviazione del 02.05.2017; sulla base di tali osservazioni, il Giudice non condivide tale istanza e ritiene, sulla base degli elementi disponibili, di ordinare, ai sensi dell’art. 409, co. 5, c.p.p. l’imputazione coatta dell’indagato CAPPATO Marco.
L’art. 580 c.p., precetto entro cui si deve valutare la condotta ascritta a CAPPATO, protegge, in modo particolarmente intenso, la vita: un bene giuridico che, nell’ordinamento italiano, assume rilievo prioritario, in quanto costituisce il presupposto necessario ed indefettibile perché ogni altro diritto – ivi incluso quello alla dignità dell’esistenza umana e all’autodeterminazione – possa dapprima esistere e, poi, essere goduto.
La condotta di CAPPATO non può essere oggetto di archiviazione in quanto rientra de plano nell’alveo normativo dell’art. 580 c.p. L’interpretazione di tale norma è chiara, poiché limpida è la formulazione sul piano semantico ed altrettanto esplicita la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui ogni condotta che costituisca rafforzamento o aiuto in qualsiasi modo al suicidio, purché sussistano il nesso di causalità e l’elemento soggettivo, dev’essere punita ai sensi del precetto richiamato.
Il rifiuto dell’interpretazione restrittiva dell’art. 580 c.p. promossa dal PM deriva dall’analisi tecnica del precetto in esame, com’è doveroso che sia in un sistema che annovera, tra i propri cardini, la legalità formale e la dipendenza del giudice dalla sola legge.
Non si può procedere all’archiviazione del procedimento, inoltre, poiché non sussiste alcuna causa di esclusione dell’antigiuridicità, che possa elidere il disvalore della condotta e renderla, così, lecita.
A differenza della condotta di un medico che esegua il comando del paziente di staccare la spina – comportamento che, come osservato nel caso Welby, è scriminato dall’adempimento del dovere (art. 51 c.p.) – la condotta di CAPPATO non può in alcun modo ricadere nell’ambio applicativo dell’art. 51 c.p.
Il PM, nella conclusione della propria richiesta, ritiene che si «inquadri il diritto al suicidio dell’ANTONIANI nella categoria delle cause di esclusione dell’antigiuridicità. (…) nel caso di specie sussiste, per il suicida (cioè per l’ANTONIANI) una forma di ‘causa di giustificazione impropria’, con rilievo oggettivo, che trasforma questo ‘fatto illecito non punito’ in un vero e proprio diritto, addirittura di rilievo costituzionale. Ne deriva, pertanto, che la condotta di Cappato, che presenta la struttura del concorso in tale fatto, risulta scriminata per effetto della diversa qualificazione che riceve il fatto in cui egli ha concorso»[24].
Tale ricostruzione non può essere accolta, in ragione del fatto che, nell’ordinamento italiano, non esiste alcun diritto assoluto al suicidio, tantomeno un diritto – esigibile dallo Stato – a “morire con dignità”, vuoi per mano propria, vuoi per mano altrui. Le fonti sovranazionali, in particolare la CEDU, pur riconoscendo che suicidarsi costituisce esercizio della propria autodeterminazione, non impongono alcun obbligo agli Stati in punto di suicidio assistito.
Non si può neppure condividere la presenza di un diritto al suicidio, ove la vita sia divenuta motivo di particolare ed esasperante tormento – psichico e fisico – per l’individuo, «nei casi di malati terminali o con patologie gravissime e irreversibili»[25]. Una simile impostazione, infatti, porrebbe in grave crisi il diritto alla vita e, soprattutto, lo piegherebbe in modo improprio all’esercizio dell’autodeterminazione: in nome di un criterio soggettivo di dignità, la ratio di tutela del bene vita muterebbe, rimanendo protetto il bene vita soltanto ove accompagnato dalla volontà del suo titolare di conservarlo. Dunque, il vero bene protetto delle stesse norme che puniscono l’omicidio non sarebbe più la vita ma la volontà di vivere: ovvero, si finirebbe per annichilire il senso stesso degli artt. 579 e 580 c.p., concepiti proprio per evitare che il consenso a morire, espresso da persone evidentemente deboli, possa essere sfruttato per finalità abiette e riprovevoli (finalità evidentemente non coltivate dall’indagato che ha ritenuto, viceversa, di operare nell’interesse di ANTONIANI).
Vi è di più: come già osservato, legittimare il suicidio assistito (in assenza di norme che lo prevedano positivamente) soltanto per alcune categorie di malati costituisce un potenziale vulnus dell’uguaglianza. Il diritto penale, in quanto diritto pubblico, tutela la vita e tale forma di presidio non può avere declinazioni diverse a seconda della percezione soggettiva del singolo. Peraltro, si finirebbe per compiere un’operazione logicamente censurabile, in quanto per rispettare la dignità della vita umana si andrebbe a distruggere ciò che di tale principio è il presupposto indefettibile, ovvero la vita stessa.
PQM
Letto l’art. 24, Legge 87/1953
RESPINGE
La questione di illegittimità costituzionale formulata dalle parti per manifesta infondatezza Letto l’art. 409, c. 5, c.p.p.
RESPINGE
la richiesta di archiviazione e
ORDINA
al Pubblico Ministero di formulare, nel termine di dieci giorni, l’imputazione per il reato di cui all’art. 580 c.p. nei confronti di Marco CAPPATO, per aver rafforzato il proposito suicidario di ANTONIANI Fabiano (detto Fabo) prospettandogli la possibilità, in alternativa alla terapia sedativa profonda in Italia, di ottenere assistenza al suicidio presso la Dignitas in Svizzera accreditata per la sua affidabilità e serietà; attivandosi per mettere in contatto la Dignitas con i prossimi congiunti di ANTONIANI facendo pervenire presso la loro abitazione il materiale informativo e, infine, per aver agevolato il suicidio di ANTONIANI trasportandolo fisicamente presso la Dignitas il giorno precedente al suicidio.
DISPONE
La restituzione degli atti al Pubblico Ministero procedente perché provveda come indicato.
Così deciso in Milano, 10 luglio 2017.
Il Giudice
Dott. Luigi Gargiulo
Depositata in cancelleria il 10/07/2017
[1] Di cui dà conto la fidanzata, Valeria IMBROGNO: cfr. verbale di SIT del 6.3.2017, in atti.
[2] Cfr. SIT di Valeria Imbrogno («nella primavera dell’anno scorso, come già altre volte manifestato in maniera meno chiara, Fabiano chiese esplicitamente a me e sua madre di prendere informazioni per la possibilità di dire basta») e della madre di ANTONIANI, le cui SI sono state verbalizzate 8.3.2017 («a seguito degli scarsi risultati ottenuti con le terapie intraprese, da qualche mese Fabiano non aveva altro pensiero se non di voler cessare di soffrire»).
[3] Cfr. verbale di interrogatorio di CAPPATO Marco, 3.4.2017, foglio n. 3.
[4] Cfr. verbale di interrogatorio di CAPPATO Marco, 3.4.2017, foglio n. 4.
[5] Cfr. verbale di interrogatorio di CAPPATO Marco, 3.4.2017, foglio n. 5
[6] Cfr. verbale di interrogatorio di CAPPATO Marco, 3.4.2017, foglio n. 6.
[7] Dignitas, fondata il 17 maggio 1998 a Forch (Cantone Zurigo), è un’associazione senza fini di lucro, il cui scopo fondamentale è quello di assicurare ai suoi membri una vita e una morte dignitose. Tra le varie attività della Dignitas rientra l’accompagnamento alla morte volontaria sottoposta, in ossequio alla normativa vigente, alle seguenti condizioni: il soggetto che ne fa richiesta a) dev’essere membro di Dignitas, pagando una quota associativa; b) deve avere una capacità di discernimento; c) dev’essere in grado di compiere azioni fisiche minime; d) deve avere una malattia il cui esito inevitabile sia la morte o/e un handicap intollerabile o/e dolori insopportabili. Si veda la web page istituzionale.
[8] Cfr. SIT di Valeria IMBROGNO, p. 2.
[9] Ibidem.
[10] Circostanza che emerge pacificamente dalle SIT di entrambe le donne, nonché dal verbale di interrogatorio di Cappato Marco, 3.4.2017, foglio n. 8, e, ancora, dalle foto tratte dalla videosorveglianza del palazzo ove ANTONIANI risiedeva (in atti).
[11] Verbale di interrogatorio di CAPPATO, 3.4.2017, foglio n. 7, nonché SIT di IMBROGNO Valeria, p. 3.
[12] Ai fini della legislazione svizzera, è fondamentale che l’atto decisivo – in questo caso l’iniezione della sostanza mortifera – sia compiuto, nel modo che gli è possibile, dal soggetto in persona: si veda l’art. 115 cod. pen. svizzero (cfr. sul punto la richiesta di archiviazione, foglio n. 3).
[13] Verbale di interrogatorio di CAPPATO Marco, 3.4.2017, fogli nn. 7 e 8; SIT di IMBROGNO Valeria, p. 3.
[14] Richiesta di archiviazione, foglio n. 5
[15] Richiesta di archiviazione, foglio n. 13.
[16] Traduzione tratta da M. De Salvia, V. Zagrebelsky, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, 2006.
[17] Richiesta di archiviazione, foglio n. 15.
[18] Richiesta di archiviazione, foglio n. 12.
[19] Ivi, foglio n. 15.
[20] Ivi, foglio n. 14.
[21] Richiesta di archiviazione, foglio n.11.
[22] In tutti i casi che ha trattato, la Corte ha posto l’accento sull’obbligo per lo Stato di proteggere la vita. Non è convinta che il “diritto alla vita” garantito dall’art. 2 possa essere interpretato nel senso che comporti un profilo negativo. La Corte ritiene, dunque, che non è possibile dedurre dall’art. 2 della Convenzione un diritto di morire, per mano di un terzo o con l’assistenza di una pubblica autorità.
[23] Sentenza Haas, § 58.
[24] Richiesta di archiviazione, fogli nn. 14 e 15.
[25] Ivi, foglio n. 14.