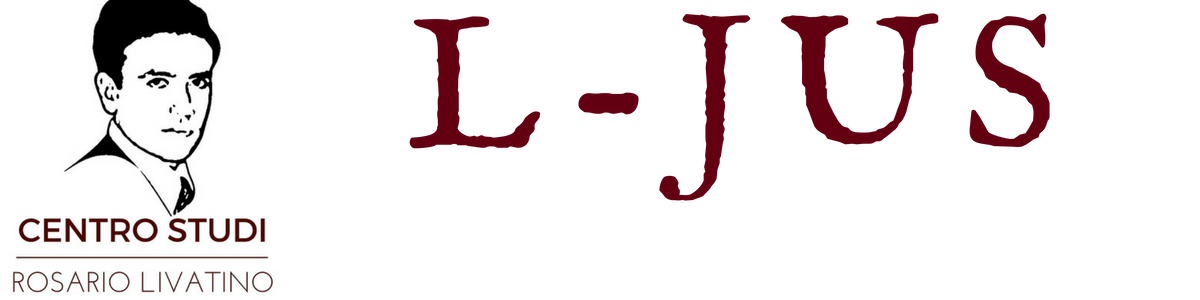Leonardo Giordano
Dirigente scolastico
Sommario: 1. La vita di Ugo Betti – 2. Il teatro “giudiziario” – 3. “Frana allo Scalo Nord” – 4. “Corruzione al Palazzo di Giustizia” – 5. Religione e teatro in Ugo Betti – 6. Per concludere.
Nella crisi della giustizia italiana, resa evidente dalle note vicende che hanno visto coinvolti taluni esponenti della magistratura, rileggere tre opere teatrali del Novecento e di quel grande drammaturgo-magistrato che fu Ugo Betti (1892-1953) sarà utile per affrontare le ragioni più profonde della crisi medesima, oltre i soli livelli più superficiali. Si tratta di “Frana allo Scalo Nord” del 1932, della più nota e famosa “Corruzione al Palazzo di Giustizia” del 1949, e di “La Regina e gli Insorti” del 1949.
- La vita di Ugo Betti
Ugo Betti[1] nasce a Camerino il 4 febbraio 1892 da una famiglia di medici. Nel 1915 si laurea in giurisprudenza a Parma e, appena conseguita la laurea, decide di arruolarsi volontario per la guerra. Verrà fatto prigioniero dopo la disfatta di Caporetto ed internato in un campo di prigionia a Rastatt insieme al già celebre Carlo Emilio Gadda (1893-1973).
Nel 1920 inizia la sua carriera di magistrato come pretore in provincia di Parma; non trascura la passione letteraria esordendo come poeta con la pubblicazione di una raccolta di versi dal titolo “Il Re pensieroso”. Sono componimenti che a una prima lettura possono sembrare convenzionali e interessati a un orizzonte puramente naturale e delle piccole cose ordinarie, quasi un’imitazione della lirica di Guido Gozzano. In realtà una lettura più attenta e mirata fa emergere in nuce i temi fondanti e pregnanti della sua migliore drammaturgia. Fu il suo compagno di prigionia Gadda a rilevarlo in una sua nota recensione nella quale parlò di una loro «intensa significazione drammatica»[2].
È del 1926 il suo esordio nel mondo della drammaturgia con “La Padrona”, opera con cui Betti vince un concorso organizzato dalla rivista “Lo Specchio e la Scimmia” aggiudicandosi recensioni favorevoli di insigni critici teatrali, quali Silvio D’Amico (1887-1955) e Aberto Cecchi (1895-1933). È così forte e intensa la passione per le lettere di questo magistrato, tutt’altro che disimpegnato nella professione, che egli non disdegnerà di sperimentare anche il campo della narrativa con tre raccolte di novelle “Caino” (1928), “Le case” (1933) e “Una strana serata” (1936) e con un romanzo: “La Piera alta” (1948). La sua prosa è caratterizzata da un equilibrato mélange tra echi di Flaubert, Dostoevskij e Tozzi, con il loro realismo introspettivo e psicologico (“Caino”)[3] ed elementi fiabeschi e favolistici (“Le case”)[4].
La sua seconda raccolta di liriche, “Canzonette-La morte”, pubblicata da Mondadori nel 1932, suscita l’interesse di uno dei più grandi critici italiani dell’epoca, Attilio Momigliano, che gli dedica addirittura un saggio nel quale rileva: «Questa personalità mi sembra innegabile, ed è, in una direzione stilistica e sentimentale opposta, una delle più originali che siano apparse dopo Guido Gozzano»[5].
Il primo dei drammi che analizzeremo, “Frana allo Scalo Nord”, è rappresentato per la prima volta nel 1936 al Teatro Goldoni di Venezia senza particolare successo, pur meritandosi queste entusiastiche espressioni da parte del critico teatrale Manlio Lo Vecchio Musti: «La “Frana” di Betti è per noi l’opera di teatro più viva, più potente e più profonda apparsa sulle nostre scene dopo “I sei personaggi” di Pirandello»[6]. Notevoli successi di pubblico riscontrano in questi anni opere in cui la vis drammatica è abilmente e sapientemente combinata con una forma di umorismo proprio del genere commedia. Si tratta di “Il paese delle vacanze”, “I nostri sogni” e “Una bella domenica di settembre”, opere rappresentate dalla compagnia “Tofano-De Sica-Rissone” al Teatro Odeon di Milano. Tutte le più grandi compagnie teatrali italiane si sono cimentate con le opere di Ugo Betti, oltre alla compagnia Palmer-Almirante-Scelzo” e la menzionata “Tofano-De Sica-Rissone”, i capolavori del drammaturgo magistrato furono messi in scena dalla compagnia dei fratelli De Filippo, dalla compagnia di Salvo Randone (1906-1991) e Paola Borboni (1900-1995), dalla “Compagnia dei Giovani” con Rossella Falk (1926-2013) e Tino Buazzelli (1922-1980), dal “Piccolo Teatro di Roma”, dalla compagnia “Gino Cervi-Andreina Pagnani”. Grandi registi, come Orazio Costa (1911-1999), Alessandro Blasetti (1900-1987) ed Ottavio Spadaro (1922 -1996) ne curarono gli allestimenti di maggiore successo.
Ugo Betti si avvicinò al cinema candidando a un concorso organizzato dalla rivista “Cinema” il testo del soggetto di un film che diventerà poi il romanzo “La Piera alta”, e partecipò alla scrittura dei soggetti dei film “Bengasi” (1941, regia di A. Genina) e “Quarta pagina” (1942, regia di N. Manzari)[7].
“Corruzione al Palazzo di Giustizia”, il secondo dramma del quale ci occuperemo, alla prima messa in scena, il 7 gennaio del 1949, regista quello che dopo Orazio Costa era considerato il miglior regista bettiano, Ottavio Spadaro, con attori di teatro del calibro di Lamberto Picasso (1880-1962), Elena Zareschi (1916-1999) e Filippo Scelzo (1900 – 1980) fu un autentico trionfo. A esso negli anni successivi fecero seguito analoghi successi all’estero, in Germania, Francia e Inghilterra[8].
Ugo Betti raggiungerà postazioni significative nella propria carriera di magistrato. Nel 1944 è nominato responsabile della Biblioteca del Ministero della Giustizia, nel 1950 è promosso consigliere della Corte di Appello ed è chiamato a collaborare all’Ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri[9]. La sua attività in punti di incrocio tra magistratura e politica, tra letteratura e professione magistrale si rivelerà decisiva ed influente nella redazione del suo capolavoro “Corruzione al Palazzo di Giustizia”. È questo il periodo in cui il drammaturgo «[…] si riaccostava alla pratica cattolica: specchio di questa evoluzione è il suo teatro, che dal 1950, con “Il giocatore” si rifarà alle concezioni del cristianesimo»[10]. Il 9 giugno 1953 muore nel pieno del successo internazionale dei suoi lavori.
2. Il teatro “giudiziario”
Tale espressione è adoperata per qualificare i due così detti “drammi d’inchiesta”: “Frana allo Scalo Nord” e “Corruzione al Palazzo di Giustizia”.
In questo suo teatro Betti fonde due tendenze dominanti della drammaturgia del primo Novecento: l’istanza naturalistica di una rappresentazione che vuole fotografare la realtà concreta, così come si percepisce di primo acchito, da una parte, e simbolismo, cioè la tendenza di fare dei personaggi e delle situazioni rappresentate simboli, emblemi estendibili ad altri contesti e a valenza universale. Questa operazione di accostamento di istanze apparentemente contraddittorie e opposte è definita dai critici col termine di “emblematismo”[11]. Elementi tipici di questa cifra stilistica sono l’allusione a topoi veri, realmente conosciuti e praticati dall’autore ma poi trasfigurati in una dimensione emblematica. Dietro la descrizione del palazzo di “Corruzione” si legge chiaramente il riferimento al “palazzaccio” romano, oggi sede della Corte di Cassazione[12]. I personaggi portano nomi poco verosimili: Kurz, Parsc e Goetz in “Frana allo Scalo Nord” e Vanan, Croz, Erzi in “Corruzione al Palazzo di Giustizia” ma questi nomi sono attribuiti a personaggi tanto veri e concreti nella loro dimensione psicologica e persino fisica, quanto trasfigurati in “tipi” con una loro valenza emblematica e simbolica.
La tensione che caratterizza queste due opere ne promuove un’impostazione da “drammi polizieschi” o “drammi processo” come li definisce Ferdinando Taviani[13]. Vi è un primo atto di impostazione della vicenda, che sembrerebbe scoraggiare il lettore o lo spettatore, cui segue una concatenazione di fatti e un incalzare di dialoghi, calati in una spessa atmosfera di tensione drammatica, che danno ai due drammi un ritmo gradualmente e inesorabilmente crescente sino alla liberazione catartica cui provvede il finale. Questo insistere di Betti sullo scavo psicologico e sul bisogno di trascendenza che deve essere soddisfatto dalla dimensione introspettiva per alcuni critici ha reso “astratto” e distante dalla contemporaneità e dai suoi problemi più concreti il teatro bettiano: «Una tale coerenza, una tale costante attenzione ai problemi inerenti alla dimensione interiore dell’uomo, se hanno dotato l’arte del B. di una profondità non comune, gli hanno anche quasi del tutto impedito, per lo meno per quanto riguarda la sua attività di scrittore, di aprirsi alla comprensione dei drammi che travagliarono la società del suo tempo»[14].
In realtà il punto di partenza delle vicende che caratterizzano i suoi “drammi giudiziari” sono fatti con un più che concreto riferimento anche alle problematiche sociali del tempo. “Frana allo Scalo Nord” pone il problema delle catastrofi provocate dall’incuria dell’uomo con il relativo corredo di temi giuridici e non solo, legati alla responsabilità e alla colpa. In “Corruzione al Palazzo di Giustizia” è evidente il riferimento al tema della corruzione, da cui le aule di giustizia non sono esenti, e al tema delle relazioni non sempre sane tra magistratura, mondo politico e mondo economico: nihil novi sub sole!
«Il rigore della costruzione drammaturgica, che ha l’andamento del “giallo” con i suoi colpi di scena e le tensioni inquietanti, e la densità del linguaggio sono messi da Betti al servizio di contenuti di straordinaria attualità e insieme di eterna validità. L’autore affronta il problema della giustizia non astrattamente o nelle convenzioni del dramma poliziesco, ma attraverso coloro che gestiscono la giustizia umana: i giudici, che sono anch’essi prima di tutto uomini»[15]. Come è nel suo stile, nel suo modo di intendere il teatro, Ugo Betti parte dalla realtà concreta e fattuale per coglierne le valenze universali ed emblematiche, i significati più profondi e reconditi. «é un teatro insomma, che nasce dalla cronaca ma che la supera in nome di istanze più alte. La saldatura tra cronaca e metafora, fra realtà e simbolo è realizzata dal linguaggio drammaturgico di Betti che ha una “fisicità” la quale impedisce qualsiasi fuga verso la fumosità e l’irrealtà»[16].
- “Frana allo Scalo Nord”
La stesura finale di questo dramma è del 1932 e il suo primo allestimento curato dalla compagnia “Palmer-Almirante-Scelzo” nel 1936 al “Teatro Goldoni” di Venezia fu un insuccesso a causa di una messa in scena che, secondo Orazio Costa, non aveva ben reso la particolare atmosfera del dramma. Prende spunto dall’episodio di una frana di grosse proporzioni su di uno scalo ferroviario che ha provocato delle vittime e dalla necessità di trovare i responsabili, giudicarli e condannarli. Il fatto che sta alla base del dramma è di una verosimiglianza, potremmo dire premonitrice, se pensiamo alla tragedia del Vajont con le aggrovigliate vicende giudiziarie che ne seguirono, o alla più recente catastrofe dell’albergo di Rigopiano con le sue 29 vittime e un complesso processo ancora in corso. Tali riscontri rappresentano la cartina al tornasole che dimostra come il teatro di Betti non è “astratto” e avulso dalla realtà concreta, anche quella di maggiore attualità. «Teatro sì di atmosfera, con la conseguente impalcatura simbolica che ne discende, ma dove il legame con la realtà rimane pur sempre un dato importante»[17].
La struttura del dramma presenta un manifesto impianto “giudiziario”: «[…] nel primo atto vengono ascoltati i principali indiziati e i testimoni, le cui parole si accavallano e frammischiano in una confusione assordante, nel secondo viene effettuata una visita sul luogo del misfatto (quello che oggi si definirebbe una ispezione dei luoghi n.d.r.) e nel terzo si ritorna all’aula di tribunale per sentir pronunciata finalmente la condanna»[18].
L’imputato è Gaucker, un imprenditore edile accusato di aver usato materiali scadenti e insufficienti perché i muretti di contenimento potessero reggere l’urto della frana. L’accusa pesa su questo personaggio tanto più perché egli inizialmente crede di essere stimato, di essere un colto e perfetto gentiluomo. Scopre invece durante il dibattimento di non essere stimato da nessuno, persino dalla moglie il cui sguardo perplesso ed indagatore lo ferisce penetrantemente nell’animo[19]. Egli tenta di scaricare la responsabilità della catastrofe sugli operai, definiti “fannulloni e canaglie” o sul sorvegliante che non avrebbe vigilato abbastanza.
Tra i testimoni chiamati in causa, oltre che i superstiti, pirandellianamente compaiono anche le vittime[20]. Altri protagonisti del dramma sono Gustavo Kurz il cinico e spregiudicato imprenditore a capo della ditta di trasporti ferroviari che, secondo Glaucker, non avrebbe eseguito correttamente la perizia sul terreno, il pubblico ministero Goetz e il consigliere giudicante Parsc. Non vi è azione drammatica in quest’opera di Betti: tutto si gioca sul potere evocativo della parola e sull’intensità espressiva del linguaggio, sul “serrato corpo a corpo tra accusatore ed accusato, tra incriminatore ed incriminato”[21]. «Ugo Betti appare lo scrittore che, pur avendo orientato la sua esperienza narrativa e poetica verso il terreno del contenutismo, conosce orami troppo bene la suggestiva e traditrice alchimia delle parole, non sa sottrarsi alla tentazione di applicarla, talvolta anche là dove l’azione urge e i sentimenti fanno ressa»[22].
I personaggi, pur identificati con nomi che sembrano piuttosto astratte denominazioni monosillabiche, presentano uno spessore psicologico tale da renderli personaggi a tutto tondo, tridimensionali, veri, non mere caratterizzazioni tipologiche di certa umanità: «Non una simbologia astratta è dunque quella di Ugo Betti; ma una simbologia umana e cioè poetica, nella quale la realtà appare trasfigurata secondo la particolare visione della vita dello scrittore»[23].
Il tema è quello del rapporto tra la giustizia umana e la “Giustizia” come valore assoluto ed universale. Nell’introduzione alla prima edizione di “Frana allo Scalo Nord”, Betti scrive: «Giustizia vuol dire paragone (fra) un oggetto e un’unità di misura: fra un fatto e una norma, fra una vita e una legge, fra una creatura e un codice. Dunque, mentre da un lato suppone una entità contingente, una vita, un fatto, una creatura, un dolore, un piacere; dall’altro una norma superiore, il che vuol dire una visione superiore, […] cioè l’unificarsi di tutti i fatti, creature, piaceri, dolori in un programma unico, con ombre e rilievi. Il che vuol dire che tutte quelle contingenze tali ci sembravano ma non erano episodi e contingenze: avevano un senso, un significato, un valore, un’importanza, una durata superiori a quelli empirici. […] In fondo vuol dire che c’è un Dio o un angelo, con un grande registro, che segna il dare e l’avere; […] si paga, se c’è da pagare, e poi si è pari. Questo è il significato di giustizia; un concetto che è solo nostro, non esiste in natura, esiste solo negli uomini. Solo noi uomini diciamo: questo è giusto-questo non è giusto […] il che vuol dire che noi siamo sicuri da prima che una giustizia vi sarebbe»[24].
Sicché al giudice Parsc apparirà abbastanza difficile, nel caso che si appresta a giudicare, “mettere a paragone un oggetto e un’unità di misura”, la tragedia della frana con la norma, le vite dei presunti colpevoli e, si potrebbe pure dire, dei “presunti innocenti”, e il codice delle leggi. «C’è che questo processo mi fa andar via la testa. C’è questo. Sembra di sognare, in coscienza. Non si capisce nulla, non si riesce a trovare…un punto fermo›› egli afferma in uno dei momenti topici[25]. Tutti i personaggi cercano inizialmente di rifuggire dalle proprie responsabilità attribuendo ad altri la colpa ma, nell’operazione di scavo che fanno nella propria anima contestualmente all’espressione della loro testimonianza, tutti sembrano rivelare, sia pure in proporzioni diverse, una sorta di correità.
«Le recriminazioni, le accuse, le grida e le giustificazioni che ognuno trova e riversa sull’altro per discolparsi si trasmutano all’unisono in un grido disperato d’aiuto, che rimane tuttavia inascoltato. Sono frammenti di un dialogo antico, eterna protesta dell’uomo, che respinge da sé la responsabilità del male compiuto. Tutti sembrano colpevoli, e tutti allo stesso modo innocenti. Eppure, i cadaveri di quelle creature giacciono immobili, prive di vita nella terra. Il giudice Parsc è l’unico personaggio fra tutti su cui sembra non gravare l’assillo e il tormento della colpa, e ciononostante si riscopre turbato e coinvolto in questo processo più degli altri»[26]. Dubbi ed indecisioni costringono il giudice ad ascoltare nuovi testimoni, tra questi anche i superstiti: due operai e una prostituta che, al momento della frana, si trovava con loro e che probabilmente li aveva distratti dal loro dovere di lavoro e di sorveglianza. Essi sembrano però aver perso il lume della ragione, urlano, gridano con farneticazioni vere e proprie, rivelando di provare nella morte scampata «il patimento di un peccato non espiato»[27].
Durante il dibattimento emerge anche un altro fattore, che potremmo definire di contesto e che sembrerebbe aver influito pesantemente sul disastro. A introdurlo sono dapprima le parole di accusa a Kurz di un “testimone miope” (il figlio di Kurz che è presente al processo in incognito). Egli afferma testualmente: «Sì: una macchina, un rullo. Le fabbriche. L’alluminio. Le ferriere riunite. Kurz, Kurz, sicuro Kurz! Voglio dire, signore, che qua bisogna guardare il complesso. Questo processo non si può risolverlo a sé, isolato»[28]. Costui in precedenza aveva usato la metafora del torchio per indicare il meccanismo economicistico del rapporto costo-profitti come causa della carenza di sicurezza e dell’utilizzo di materiali inadeguati. Un meccanismo che risponde alla rigida logica materialista del profitto a tutti i costi, rispetto alla quale ogni altra considerazione, anche inerente al dovere di salvaguardare la vita umana, sarebbe sacrificata[29].
Non possiamo però confondere personaggio ed autore, cioè le posizioni dei personaggi, che rientrano nella logica dialettica della struttura teatrale, col punto di visita dell’autore. Betti, che conosceva bene l’uso dei simboli e dei segni, identifica il figlio di Kurz come “il testimone miope”, cioè sostanzialmente incapace di vedere nitidamente, oltre la coltre superficiale, ciò che è profondo, non superficiale ma distante e remoto.
Questa difficoltà nell’applicare un metro equo di giustizia umana ad un caso così complesso dipende da un altro tipico tema bettiano: il rapporto di commistione inestricabile, apparentemente indissolubile tra bene e male. Nella vita di ognuno di noi bene e male sembrano aggrovigliarsi e combinarsi in una potente alchimia che la ragione umana non riesce a spiegarsi se non come un insondabile ed irrisolvibile mistero. «Dall’intuizione di questa duplicità deriva anche il senso del desiderio inappagato e dell’impossibilità di una giustizia terrena»[30]. Se Luigi Pirandello (1867-1936), che certamente avrà avuto influenza su Ugo Betti, si rassegna e accetta per quella che è questa duplicità, il drammaturgo camerinense non si arrende al mistero di questo illogico “impasto”. «L’ambizione più alta di Ugo Betti è quella di sorprendere tale “misteriosa confusione” nell’attimo in cui si schiude, quella di illuminare la zona segreta dove l’impasto della vita si forma nella sua indeterminatezza»[31].
Lungo questo itinerario sembra che Betti quasi si compiaccia di contemplare l’errore ed il male e come il bene non riesca a districarsi e distanziarsi da esso, ritenendo che le sofferenze che esso procuri sia già una forma di purificazione e redenzione[32]. Vi è invece un passo ulteriore che integra, completa e risolve l’intricato dilemma. Lo si comprenderà meglio con l’epilogo del dramma. Tutti, testimoni e accusato, dopo aver esaminato la propria coscienza, si sentono colpevoli di fronte alla giustizia umana, chi per il fatto di aver fornito materiali scadenti e insufficienti (Glaucker), chi per essersi fatto distogliere dal lavoro e da un’attenta vigilanza (i due operai testimoni), chi per aver distolto coloro che dovevano lavorare e vigilare dai loro doveri (la giovane prostituta Nasca), chi per aver falsificato la perizia sul terreno (Kurz).
Goetz, il pubblico ministero con un passato di militare, esige però che si giunga a un verdetto e quindi ad una sentenza che individui il o i colpevoli: «GOETZ (ambiguo) Su Parsc. Pronunciala, allora, questa condanna!»[33]. Questo è il climax della tensione drammatica. Nella mente e nell’animo di Parsc si affollano pensieri, sentimenti contraddittori, un senso di smarrimento sembra assalirlo e portarlo ad una sorta d’impotenza. «E come l’oscurità in cui era immersa l’aula del tribunale, cresceva al crescere della confusione e dello straniamento degli astanti, allo stesso modo un raggio di luce investe timidamente l’aria quando il giudice Parsc emette la sentenza definitiva»[34].
«PARSC (d’un tratto come illuminato) Noi dichiariamo che questi uomini pronunciarono, pronunciano essi stessi ogni giorno con la loro vita, con la loro pena, la giusta sentenza; trovarono essi stessi la loro certezza. E che forse nelle mani del giudice essi dovranno avere un’altra cosa, più alta: la pietà. La pietà.
TUTTI (con voce sommessa) Pietà…Pietà…»[35].
È una sentenza assolutoria? Si tratta di pietismo umanitarista e buonista? Si vuol segnalare l’impotenza e l’impossibilità di un’autentica giustizia umana e terrena? L’epilogo di questo dramma, che si rivela una sorta di “ermeneutica della colpa”[36], segnala invece un sentimento profondo di quella giustizia che è iscritta nel fondo dell’animo umano e che ci deriva da “un altrove” situato sopra la condizione umana. «Nel caso non viene applicata (la giustizia n.d.r.) ma vi sarebbe, vi è, è alla radice di ogni pensiero, anzi di ogni nostra sensazione; è di tutti gli uomini, quindi è dell’uomo e solo dell’uomo. È il punto forse più costante, tranquillante nel quale la coscienza (o il sub cosciente) dell’uomo dimostra di essere certa dell’esistenza di Dio»[37].
Il male, e la colpa di averlo commesso, non sono tanto nella volontà di compierlo quanto nell’incoscienza di averlo compiuto, nell’indifferenza relativistica e nichilistica rispetto al problema del male commesso. I presunti colpevoli eseguono uno scavo rigoroso e profondo nella propria coscienza (Goetz usa l’espressione “Abbiamo trivellato fino al fondo. Più in là non è possibile”[38]) che di per sé rappresenta una sorta di purgatorio; quando arrivano a rendersi conto del male compiuto essi si avvicinano alla redenzione ed hanno quasi espiato la pena. Per questi motivi il coro finale dei personaggi che declamano: «Pietà…Pietà…» assume, oltre che il colto segno del richiamo al teatro classico greco, anche una valenza religiosa. Afferma Antonio Di Pietro, uno dei maggiori e più acuti esegeti del teatro di Ugo Betti: «In questo coro di alta ispirazione religiosa, in cui si fondono in una sola le voci dei miseri e dei potenti, degli oppressi e degli oppressori, dei vivi e dei morti, culmina e coerentemente si conclude il dramma, che ha preso il via dal rito profano del servile ossequio e dall’impietosa denuncia delle colpe altrui, in difesa del proprio egoismo»[39].
Allo stesso modo del teatro di Thomas Stearns Eliot (1888 – 1965), il teatro bettiano può definirsi come “teatro purgatoriale”[40] non nel senso «[…] che anche il più bieco peccatore nell’atto in cui pecca si consuma e si purifica rendendosi perciò stesso degno di elevazione»[41], quanto invece nel fatto che il colpevole, il peccatore, avvia il proprio processo di espiazione e redenzione nel momento in cui si rende conto e diviene consapevole del male commesso perché allora inizia la sofferenza, allora si inizia a portare la “croce” che purga e redime.
- “Corruzione al Palazzo di Giustizia”
Scritto nel 1944, fu pubblicato nel 1949 sulla rivista “Sipario” e, come già detto, fu rappresentato per la prima volta nello stesso anno con un successo davvero straordinario, che si ripeté anche sui palcoscenici dei più famosi teatri di Europa[42]. Ne fu esegeta entusiasta il filosofo esistenzialista cristiano Gabriel Marcel (1889–1973) con la recensione dal titolo “L’angoscia di Daumier nei personaggi di Betti”[43].
La trama prende avvio da un’ispezione che un giudice, Erzi, compie ad un palazzo di giustizia, molto chiacchierato e sospettato di episodi di corruzione; i sospetti riguarderebbero le più alte cariche del tribunale: il Presidente Vanan, il giudice referente Cust, il giudice anziano Croz, i giudici Bata, Persius e Maveri. Autore della corruzione sarebbe stato un discusso uomo di affari, Ludvi-Pol. Durante l’indagine i sospetti maggiori, anche grazie al subdolo lavorìo psicologico e di retorica eloquenziale di Cust e Croz, che aspirano a sostituirlo, cadono sul superbo presidente Vanan.
Questi viene persuaso dai due a scegliere di dimettersi e ritirarsi, eventualmente per scrivere un memoriale che avrebbe ristabilito la verità. Il giudice ispettore Erzi però non sembra di questa soluzione, anche perché nel palazzo è stato ritrovato il cadavere del corruttore Ludvi–Pol. Perciò continua a indagare ascoltando gli aspiranti sostituti del presidente Vanan: Cust e Croz. Ricompare sulla scena un remissivo Vanan, accompagnato dalla figlia Elena, che crede fermamente nell’innocenza del padre e, entrata in possesso del memoriale scritto dal padre, vuole consegnarlo ad Erzi. Si trova però davanti Cust che si fa scambiare per Erzi e si fa consegnare il memoriale facendolo sparire. Inoltre, subdolamente e perfidamente, riesce a persuadere Elena che il padre non è innocente come ella lo immagina e ha sempre creduto, insinuandole il sospetto che sia tutt’altra persona rispetto a quella che ella crede di aver conosciuto.
Il trauma della rivelazione induce Elena a suicidarsi gettandosi dalla tromba delle scale del palazzo di giustizia. In un drammatico incontro tra Cust e Croz, nell’archivio del tribunale, Cust, il vero colpevole, credendo che Croz sia stato colpito a morte da un malore, confessa i suoi misfatti. Croz però è ancora vivo e chiede di parlare con Erzi per rivelargli la verità, senonché per prendersi beffa di Cust e dimostrare nichilisticamente che non esisterebbe una verità oggettiva, confessa, mentendo, di essere lui il corrotto. Vanan è scagionato, Cust diventa nuovo presidente del tribunale. Da questo momento però il rimorso ed il senso di colpa non lo lasciano più e gli assalgono insistentemente e pesantemente l’animo e la mente fino ad indurlo a recarsi dall’Alto Revisore per dire la verità e confessare le sue gravi colpe.
La struttura del dramma, composto di tre atti, rispetto a “Frana allo Scalo Nord” non presenta un procedimento di tipo rigorosamente “giudiziario-processuale”. Fa fulcro, invece, sull’atto finale, il terzo, quello in cui sembrano avvicendarsi diverse ipotesi di soluzione del caso sino a giungere a quella reale, veritiera e conclusiva. «Il primo atto è come un preludio alla tragedia, segna l’inizio dell’indagine. Nel secondo si assiste alla denuncia, all’accusa delle colpe; si scoprono le responsabilità di ognuno; vengono toccati i limiti dell’innocenza e del peccato, che erano e sono, confusi, inseparabili, in un inestricabile caos. Il terzo atto è quello della risoluzione, quello in cui si parla del “futuro”. L’atto della decisione suprema»[44].
Esistono diversi livelli di lettura del dramma e in “Corruzione al Palazzo di Giustizia”, ancor più che in altre opere di Betti, il piano orizzontale dei riferimenti espliciti ed impliciti al proprio tempo, si interseca strutturalmente con il piano verticale dei significati emblematici e profondi della vicenda e dei rimandi alla dimensione del trascendente. «Il dramma riflette la conoscenza diretta che l’autore, alto magistrato egli stesso, si era potuto fare del “palazzo di giustizia”, cioè di quel mondo separato ed esoterico che è costituito, in una società civile moderna, dall’amministrazione giudiziaria, ma assurge al tempo stesso a rappresentazione universale dei limiti e delle contraddizioni della giustizia umana, quando essa si separa dalla sua legittimazione etica»[45].
Seguendo la traccia di una lettura che si snoda lungo il piano “orizzontale”, i riferimenti a ciò che avveniva nel pianeta giudiziario già ai tempi di Betti, e che egli ben conosceva da magistrato attento e scrupoloso, sono ben evidenti con le cointeressenze tra potere politico-economico e potere giudiziario, di separazione netta dal paese reale e “autoreferenzialità” del sistema giudiziario, di veleni, ricatti, pettegolezzi, violazioni di segreti istruttori, talpe, carrierismi che con frequenza hanno caratterizzato parte della magistratura italiana.
«BATA: Intendiamoci, è anche possibile che tutto sia una valanga nata dal nulla. La gente è fatta per chiacchierare. Il palazzo poi è la miniera, è il pozzo, è il nido del malcontento, dei sussurri. Comincia uno, a spargere calunnie, l’altro seguita, il giorno dopo sono dieci, venti, e zu e zu, e zu e zu: è come una cancrena che si allarga.
MAVERI: E poi i giornali subdoli; subdoli…
PERSIUS: I partiti, gli intrighi. Io sento in tutto questo una cupa volontà, una manovra»[46].
Il punto di raccordo tra “piano orizzontale” e “piano verticale” della drammaturgia di Ugo Betti e della sua opera più nota, si registra quando l’autore decide di affondare il bisturi, e in questa opera di scavo che egli coglie la portata della crisi che affligge il “palazzo”, i suoi giudici, il suo popolo di archivisti, cancellieri, commessi e poliziotti, che è crisi dell’umano ancor prima che di una certa categoria professionale di uomini. «Inquisitore implacabile, lo scrittore va al fondo della questione, sonda, trivella, giù, giù, e giudica i giudici e la loro giustizia: li demolisce, perché è venuto ormai il tempo di riedificare: i giudici sono come gli altri uomini e nulla vale la loro giustizia; anch’essi sono pieni di colpe e desiderano confessarsi per poterle scontare»[47].
Betti già da subito segnala la netta separazione tra diritto ed etica. Fin quando vi era una sorta di simmetria riflettente tra l’etica, i fondamenti valoriali di una società e dell’umano, e il corpus delle leggi primarie e secondarie che, assommate e combinate, costituiscono il diritto, i giudici, in qualche maniera, erano oggettivamente vincolati alla ricerca di una verità non semplicemente “processuale” e “positiva” ma la più vicina possibile alla realtà.
«Ma con l’emergere di una cultura complessa e diversificata, contrassegnata, com’è la nostra, da un irreversibile pluralismo religioso e ideologico, i due ordini divergono sempre più nettamente, in modo tale che i reciproci confini si fanno sempre più marcati e invalicabili. Ma l’ordinamento giuridico perde in questa divaricazione la sua legittimazione originaria, che era ultimamente di natura morale e comportava una certa convinzione circa ciò che era ritenuto giusto o ingiusto in sé stesso, al di là di ogni relativismo etico. In una società che, non possedendo più una visione unanimemente condivisa della verità ultima dell’uomo, non crede più nella possibilità di identificare il giusto e l’ingiusto in sé, il diritto diventa una “convenzione” nel senso più letterale della parola […]»[48].
Il senso più vero ed autentico della percezione che la giustizia si sia ridotta a un rito convenzionale che si consuma tra giudici e cittadini lo fornisce lo stesso Betti in un suo articolo pubblicato da una rivista giuridica, nel quale afferma che «Vi è un punto della città, un palazzo dalle cui porte, ogni giorno, entra a fiumi la più varia gente che sia dato vedere; le più strane condizioni, i più differenti vestiti. Cotesta gente percorre dei corridoi, entra in certe aule; e lì grida, piange, mente, pronuncia sconsolate o atroci o trepidi parole. A chi sono dirette tutte quelle parole? Ad alcuni altri uomini che ascoltano e non parlano mai, i giudici. Per giorni, per anni, per decine d’anni costoro ascoltano, senza mai aprir bocca, le verità e le bugie che dicono quegli altri. Se è possibile all’esperienza umana superare qualche volta quel povero limite che l’assuefazione segna all’uomo, quante cose mai devono sapere quei silenziosi ascoltatori! Di ciò spesso, quelli che parlano davanti ad essi hanno improvviso sospetto. Li trattiene, per qualche momento, un imbarazzo, un rossore, un compianto di sé stessi. Ma subito dopo essi ricominciano a dire le verità e le bugie che la necessità impone loro di dire; e i giudici seguitano ad ascoltarle in silenzio»[49].
Questa crisi del diritto e della giustizia è ben esplicitata nel terzo atto del dramma dal giudice Croz, il più relativista e nichilista dei personaggi, colui che, pur di dimostrare l’impossibilità di arrivare ad una verità oggettiva, si autoaccusa di un reato non commesso col fine di far deragliare la Giustizia verso l’ingiusto e quindi il male[50]. «CROZ: […] Questi giudici mi hanno sempre rivoltato lo stomaco. Molti di essi sono integerrimi, dignitosi…E questi saranno longevi…Sono di legno. Quanto agli altri…accostati Cust…Essi fanno giustizia! Ah ah ah. (Ride) Cioè essi esprimono il parere che certe azioni siano giuste e altre no. Come una salsiccia è appesa a un’altra salsiccia, così questo parere è appeso a dei codici…ben rilegati…e questi codici, via via, ad altri codici e leggi e tavole…sempre più antiche. L’inconveniente mio caro […] l’inconveniente è che manca il gancio principale, l’unico originale…mancando il quale…ecco tutta la fila di salsicce per terra! […] Chi è stato a stabilire che una cosa è giusta e l’altra no? Noi sappiamo benissimo che le cose…sono quel che sono, tutte uguali»[51].
Se la legge non si poggia su alcun fondamento etico e valoriale ma semplicemente sulla volontà del legislatore, spesso risultante da arditi e complessi compromessi tra interessi, tra le forze più influenti e incisive di un corpo sociale, è chiaro che tali interessi e forze potranno prima o poi far pressione, esercitare il loro potere sull’ordinamento giuridico piegandolo a proprio vantaggio, e costruendo di fatto un contesto di corruzione[52].
«CROZ: Sapete caro Erzi cosa siamo noi poveretti, noi infelici giudici di questa sezione, sicuro, la sezione delle grandi cause? Un piccolo, solitario e malfermo scoglio sul quale piombano da tutte le parti ondate immense, spaventose; vere schiumose montagne. E cioè interessi implacabili, ricchezze sterminate, blocchi ferrei manovrati da uomini tremendi, insomma forze veramente selvagge, il cui urto…poveri noi meschini -è qualcosa…di scatenato, di affascinante, di feroce…»[53].
Se ci fermassimo a questa analisi che Croz fa della crisi della giustizia – non sempre ciò che dicono i personaggi riflettono del tutto o solo in parte la posizione dell’autore – rimarremmo su un piano “orizzontale”, che rimanda a cause sociali e cerca giustificazioni nei condizionamenti del “sistema”, come era accaduto al “testimone miope” in “Frana allo Scalo Nord”. Il salto di qualità, con il conseguente passaggio al piano “verticale” viene fatto quando Betti si addentra nel cuore e nell’animo dei singoli personaggi, negli interstizi del loro spessore psicologico e nel groviglio del loro travaglio spirituale, per comprenderne e valutarne il modo in cui essi si rapportano e reagiscono rispetto al rischio “assuefazione” del rito convenzionale in cui spesso indulge la giustizia umana. Il personaggio che maggiormente si presta a questo scopo è proprio il colpevole: il giudice Cust. Quando nel secondo atto l’inquisitore Erzi gli chiede che cosa possa indurre un colpevole, deciso e determinato a non rivelarsi, a cedere e poi a confessare la sua colpa egli, pensando a sé stesso, e prefigurando di fatto ciò che potrà accadergli e gli accadrà, risponde: «Questo: che gli uomini sono un po’ gracili; e invece ciò che essi stessi fabbricano, pensieri…leggi…delitti…è troppo pesante per le loro spalle»[54].
Questa “fragilità”, che è poi l’innata inclinazione umana a cercare il bene e a disfarsi del male, viene fuori nella vicenda del giudice Cust dopo il suicidio di Elena, la figlia del presidente Vanan, che in questo dramma è l’equivalente della Cordelia del “Re Lear”[55] di Shakespeare. Già durante il suo subdolo e diabolico persuadere Elena che il padre non fosse quell’ammirabile persona nella quale ella aveva creduto, Cust rivela una strana attrazione nei confronti di questa giovane, della sua innocenza, dell’aura di purezza incontaminata che la circonda. Egli le si rivolge con queste espressioni: «Quando vi ho visto, ho detto: ecco veramente entrare la innocenza e la vera giustizia in questo triste luogo…» più oltre: «Che inebriante sfolgorìo! Se ne resta immalinconiti, umiliati; voi non ne avete colpa; voi splendete, alla lettera, in questo inferno. Fate pensare ai cristalli puri di cui è formata, come saprete, la materia organica»[56].
Ciò che ossessivamente turberà Cust è il grido di Elena prima che si getti dalle trombe delle scale del palazzo, lo stesso suono che egli aveva udito, sotto forma di squillo, all’arrivo di Elena la prima volta che l’ha vista in tribunale, «il suo grido tagliò in due il cristallo del cielo. Arrivò lontano»[57].
«Il grido lanciato da Elena nel suo volo è un grido che non solo non si può dimenticare (rappresentando, quel grido, il linguaggio dell’innocenza, della verità contro il burocratico linguaggio del potere, della finzione), ma è qualcosa che avvia il personaggio verso un processo di approfondimento interiore, avvertito come sempre più necessario, facendogli sentire l’urgenza della confessione, della verità»[58]. Un grido, in altre parole, che squarcia e rompe la dura crosta dei riti, delle abitudini oramai ripetute e stanche, dei procedimenti e delle convenzioni vuote e lente che affliggono il servizio della giustizia erogato in quel palazzo.
Si è già detto del carattere “emblematico” e simbolico dei protagonisti dei drammi di Betti. Forse nessun personaggio meglio di Elena riflette tale aspetto. Il senso recondito della presenza di questo personaggio nel dramma bettiano, così come descritto da Cust e così come ella si pone nel suo eloquio e nel suo rapportarsi all’atmosfera rancida del palazzo, ci viene disvelato proprio dal colpevole Cust: «[…] che invece vi era in lei qualcosa che non esiste e non esisterà più in nessun altro punto dell’eternità… (d’un tratto, con una specie di furore) qualche cosa di più immenso della più immensa stella…»[59]. È la Grazia che si infila nelle fessure della fragilità e della gracilità umana, su cui Cust stesso aveva dissertato con Erzi, per produrre un pressante bisogno di purificazione e catarsi sino ad indurlo a consegnarsi ad una giustizia più alta che è quella dell’Alto Revisore.
«Nell’animo dell’uomo ingiusto e addirittura del giudice eversore della giustizia scopriremo, alla fine, che egli stesso non potrà respirare e sopravvivere senza una giustizia. […] Sicché alla fine è proprio il colpevole che va a denunciarsi, spontaneamente, e proprio quando gli è stata assicurata una trionfante impunità»[60]. Ad alcuni critici questa improvvisa conversione di Cust è apparsa un limite del dramma, rischiando di chiudere la tragedia con un finale poco credibile e poco probabile[61]. Altri invece ha sostenuto il contrario: «Come scrivemmo la sera della sua prima rappresentazione, la tragedia, d’una terribilità cupa, sarebbe insostenibile se non finisse con l’anelito alla sua necessaria purificazione. Il poeta l’ha espressa nel suo eloquio più denso; con parole d’una veemenza che giunge al culmine nell’orrendo e stupendo colloquio fra la purezza della adolescente e la protervia del suo distruttore. Dicemmo allora che Betti è poeta del tempo nostro, anche, e soprattutto, in questa ricerca d’una catarsi; in questo “bisogno di credere”, che è, specie da alcuni anni in qua, il ricorrente affanno dei nostri più nobili scrittori di teatro»[62].
Altra figura “emblematica” che segna fortemente l’epilogo del dramma è quella dell’Alto Revisore dal quale Cust ha deciso di recarsi per la sua confessione. L’allusione alla giustizia divina e a Dio non sembra diretta e univocamente decifrabile. «Ma il Volto inerme dell’Altro e l’urlo della sofferenza che reclama giustizia non sono ancora l’istanza morale in se stessa, ma solo le condizioni del suo emergere ( o riemergere) dalle profondità del cuore umano; sono lo schermo su cui appare, più o meno nitida, più o meno a fuoco, la figura di quell’Alto Revisore che, al termine della “lunga scale che sale”, su cui si chiude il dramma, attende ogni uomo per la confessione finale della verità, che finalmente lo libererà dal peso insopportabile del rimorso. La realtà di cui è simbolo questo Alto Revisore, questa garanzia ultima dell’invincibilità dell’istanza morale, è appena intuibile tra le righe di questo dramma. Solo nelle ultime opere, uscite postume, del nostro autore […] la figura di questo Alto Revisore assumerà il nome e il volto di Dio e apparirà in tutta la sua chiarezza, non soltanto come fondamento ultimo dell’ordine morale, ma anche come speranza suprema dell’uomo»[63]. Si ha motivo di credere, però, che certamente Ugo Betti avesse ben presente che, per quella fede e quella Verità alla quale egli si avvicinerà anche nella pratica liturgica, prima della conclusione della sua vicenda esistenziale, la storia dell’umanità si chiuderà con un “Giudizio”.
- Religione e teatro in Ugo Betti
Già l’epilogo di “Corruzione al Palazzo di Giustizia” evidenzia la stretta relazione che si sviluppa e si costruisce tra la vis drammatica del teatro bettiano e la visione del sacro dell’autore, il suo “senso religioso”. Questa correlazione sarà più evidente nella produzione finale e postuma dell’opera di Ugo Betti[64].
Vi è un dramma, in particolare, in cui la dialettica tra giustizia e verità si salda più strettamente col tema della religione. che caratterizza in maniera più significativa l’ultima stagione della drammaturgia di Betti. È la tragedia “La Regina e gli Insorti”. Essa fu scritta nel 1949 e fu rappresentata la prima volta, non con un rilevante successo, al teatro Eliseo dalla compagnia di Gino Cervi (1901-1974) e Andreina Pagnani (1906-1981), con la regia di Alessandro Blasetti (1900-1987) il 5 gennaio 1951[65].
Il dramma è ambientato durante una rivoluzione politica che interessa un non meglio precisato Paese moderno. Alcuni viaggiatori, che tentano di fuggire per non essere preda delle violenze e dei soprusi rivoluzionari, sono fatti prigionieri dagli “insorti” in un municipio di un villaggio di confine. Tra essi vi sono, sotto le spoglie di una contadina, la regina deposta, in attesa di un figlio, un ingegnere, la prostituta Argia, il suo amante Raim, affarista in cerca di fortuna a ogni costo, e personaggi minori. Arrivano sul posto anche un Commissario della Rivoluzione, il freddo e spietato Amos e il ferito capo militare dei rivoltosi Biante. Essi vi giungono perché sono alla ricerca della regina che devono processare e condannare.
La prostituta Argia e il suo amante Raim riconoscono nella contadina la regina e pensano di denunziarla per poterne ricavare la libertà e altri vantaggi, non esclusa una taglia. Ma in un drammatico colloquio tra Argia e la regina, alle richieste di pietà e aiuto di quest’ultima, specie dopo la rivelazione di essere in attesa di un bambino, Argia escogita uno stratagemma per farla fuggire anche all’insaputa di Raim: sostituirsi alla regina e, con un’azione diversiva, farla fuggire.
L’escamotage, però, non funziona perché Argia è fatta prigioniera, è creduta essere davvero la regina e viene processata mentre la regina vera è chiamata a testimoniare quale contadina che l’ha incontrata e ci ha parlato[66]. Si apre allora nel terzo atto un processo. Non è però il processo di “Frana allo Scalo Nord” o di “Corruzione al Palazzo di Giustizia”, legato alle convenzioni giuridiche del diritto positivo, sia pur analizzato ed approfondito nelle sue contraddizioni da Ugo Betti. È un processo “politico”, sommario, con un condannato già predestinato dalla “giustizia rivoluzionaria”, un processo fatto con tante false testimonianze, estorte con la minaccia rivoluzionaria e basate sulla paura di pavidi personaggi, come lo stesso Raim, di subire le ritorsioni rivoluzionarie[67]. Argia ha una sola possibilità di essere salvata: che la vera regina confessi, dismettendo i panni di contadina, ma questi muore suicida proprio prima di rendere testimonianza. La prostituta, oramai divenuta a tutti gli effetti regina, è condannata a morte.
«BIANTE: (affannoso e vacillante, si alza sostenuto da Maupa) La rivoluzione decide che la regina debba morire. Io ordino…io ordino… (non può più proseguire alla fine Maupa lo ridepone sulla sedia).
AMOS: Tu non sei più in grado di dare ordini. Il tuo posto è vacante. (Si volta agli astanti). La rivoluzione decide che la regina debba morire. La sentenza sarà eseguita questa medesima notte»[68].
In questo processo politico, quale dei tanti di quelli tenuti negli stati totalitari del Novecento, o al termine di un rivolgimento politico traumatico e violento, non è il giudice che, in nome di una legge, usando la prima personale singolare (Io) pronuncia una sentenza di condanna per Argia, ma è un “commissario politico” (Amos) che, in nome e a impersonale servizio di quest’entità astratta che è la rivoluzione, pronuncia la condanna e dispone della esecuzione della sentenza. Non è un caso infatti che il giudice/presidente sommariamente autodesignatosi (il generale Biante) muoia proprio prima di pronunciarla. Quando Amos gli dice “tu non sei più in grado di dare ordini” non si riferisce solo al fatto che Biante stia morendo ma intende rendere impersonale la decisione che spetta non ad uno, ad una persona, bensì alla rivoluzione. Lo scopo, infatti, non è fare giustizia ma “giustiziare” un potenziale nemico della rivoluzione non di Biante. «AMOS: Credete davvero che la rivoluzione avrebbe accordato tanto della sua pazienza alle vostre schermaglie e all’approssimativa legalità del processo, se non avesse mirato ad uno scopo preciso?»[69].
Decisiva è anche la figura di questo personaggio del dramma, “emblema” e simbolo delle ragioni inumane ed astratte della rivoluzione. Egli, ex teologo, in un monologo posto nella scena finale, con lucidità luciferina così spiega le motivazioni del suo comportamento e del suo impegno politico: «Quel furore (allude al furore della folla inferocita che reclama la condanna della regina n.d.r.) dice di no al mondo: dice…(con stanchezza disperata) che esso è sbagliato, un vero sproposito; sterminata e immodificabile petraia di disperazioni, grottesco e immodificabile labirinto di ingiustizie, insensato ingranaggio che costringe un bel giorno voi e me a dire e fare qui ciò che stiamo facendo. Dice di no; sterilizzazione totale; via tutto: il giusto e l’ingiusto, la lealtà e il tradimento, meriti, colpe, glorie: (indica Argia) … tutto ciò che ci fa avidi e vanitosi proprietari in vita e in morte, tutta questa massa di trappole, questa gran frode!»[70].
Difficile ricostruire meglio il profilo di un rivoluzionario, pienamente identificato ed assorbito dalla “causa”, completamente “sacrificato” al fine che intende perseguire, disposto a cancellare e rifare i connotati alla realtà, come nell’indole gnostica di ogni velleitarismo rivoluzionario di creare “l’Uomo Nuovo” ed il “Mondo Nuovo”[71]. Per Argia, oramai sembra non esservi alcuna speranza, ma Amos gli offre la possibilità di essere graziata dalla rivoluzione, «La rivoluzione ha interesse a tenervi viva. Viva e circolante. Viva… (con una specie di noncuranza) e svergognata»[72], purché confessi per iscritto la colpa di aver angariato ed oppresso il popolo e tutto ciò di cui i rivoluzionari l’accusano, anche a torto. Ella allora, con ammirevole dignità, assume sulle proprie spalle la responsabilità di rifiutare la grazia ed accettare, in un atto di estrema libertà, il suo infausto destino per dimostrare che non tutti sono disponibili e pronti a piegarsi al sopruso e alla oppressiva forza rivoluzionaria.
«ARGIA: anzi, essere regina vuol dire proprio essere sola. Essere andata avanti, aver lasciato ogni compagnia. Nemici, amici, tutto sparito. Gran semplicità. Questa stanza è davvero una reggia; la vostra avversione non è che rispetto; voi non siete che un suddito ribellato. Io posso dire di sì, posso dire di no.
AMOS: Però c’è un prezzo.
ARGIA: é l’unico che io possa pagare. (Ha un brivido di freddo) E se decido di pagarlo…sono libera di dire di sì, oppure no. E nessuno al mondo, può farci niente. Scelgo io. È bello, questo; potervi parlare così, guardare così…e sentire il respiro così libero, i colpi del cuore così tranquilli»[73].
Il Commissario della rivoluzione tenta anche un’altra carta per estorcerle la confessione e la denunzia di eventuali complici, rimasti liberi. Le porta davanti un bambino, il figlioletto che gli “insorti” avevano rapito alla regina e nascosto in una fattoria di campagna. Sperano di commuoverla ed indurla a cedere facendo leva sui sentimenti materni. Paradossalmente Argia si è così immedesimata nei panni della sovrana che, al cospetto del bimbo, prova una straziante sofferenza, se l’abbraccia, lo accarezza, lo bacia, se lo stringe al petto. Fa cose che nemmeno la vera madre forse avrebbe fatto. Amos la minaccia persino di uccidere il bambino ottenendone l’approvazione rivoluzionaria in quanto futuro pericolo insieme ai controrivoluzionari fuggiti e sopravvissuti[74], Ma Argia non cede ed Amos: «E dunque il contrasto tra noi è finito. Non ci resta che terminare ciò che fu cominciato. (Pausa; con gravità e dolcezza). Se credete alla sopravvivenza della vostra anima e desiderate un confessore, chiunque può ascoltarvi. ARGIA: Si, lo desidero […]»[75].
L’epilogo del dramma è di una forte intensità emotiva mista ad una religiosa ma non passiva rassegnazione. Argia dice che si presenterà sola davanti a Dio «Credo che il Signore, fra poco, non mi domanderà nomi, ma qual è stato il mio profitto. L’unico che io abbia avuto l’ho avuto questa notte; e così non proprio spoglia, ma con una piccola moneta vado avanti a lui […] Piccola ma mia, non regalata, né ereditata, mia. È questo il guadagno che ci fa proprietari e abbienti»[76]. È la vittoria della persona contro il regime, della libertà personale contro l’oppressione totalitaria, di un’anima che vince le insidie e le lusinghe di un potere spietato, oppressivo, diabolico. L’esercizio di questa libertà però è mediata dalla volontà di riconciliarsi con Dio, di rimettersi ed abbandonarsi alla sua volontà. Questo è il senso religioso di quest’opera.
«ARGIA: Io credo che Dio …ci abbia appositamente fatto, non docili, altrimenti era inutile…ma diversi da lui e un po’ orgogliosi…perché si possa stargli davanti, contrariarlo, stupirlo. Forse è questo lo scopo. È una lunga lotta. Solo alla fine ci si riconcilia; e ci si ripensa. (Guarda il bambino) Vado via ricca. Ho acquistato un figlio…e dei ricordi…Se mai un po’ di memoria sopravvive, questa notte brillerà per me, brillerà […]»[77]. Si avvierà all’esecuzione tendendo teneramente la mano al bambino in segno di commiato, per darsi un contegno si tinge le labbra di rossetto, non ci si può presentare al cospetto del Signore indecorosi, ed esclama con un’espressione di delicato e dolce vigore spirituale: «Che bel sereno sui monti, e c’è ancora la stella Diana. Indubbiamente questa è una sede da re e noi dovremo viverci regalmente (Esce in silenzio)»[78].
Diverse sono state le interpretazioni e le posizioni critiche sul personaggio di Argia e su questo finale. Vi è stato chi ha voluto far risalire il conato di libertà di Argia ad una radice filosofica stirneriana, quasi si trattasse dell’individuo che rifiuta ogni condizionamento del potere per affermare sé stesso in quanto individuo. Un argomento utilizzato a sostegno di questa tesi sarebbe il dialogo finale nel quale Argia dice di credere che Dio ci abbia creato quali tanti “Prometeo” orgogliosi di sfidarlo e di non piegarsi a Lui. «Di fronte al nulla, l’individuo è solo. È solo, di fronte al dilemma se avere o non un destino proprio. Nella posizione di un tale “volontarismo etico”, Betti permette di mettere in risonanza la teoria del nichilista Stirner con il messaggio dell’esistenzialismo, in cui le voci di Junger, Heidegger si mescolano con le voci di Kirkegaard, Nietzsche, Dostoevskij»[79].
A leggerlo approfonditamente quel dialogo, si scoprirebbero, oltre le tipizzazioni “emblematiche” proprie della scrittura di Betti, le radici bibliche e un alto richiamo religioso. In quell’affermazione di Argia secondo cui Dio ci avrebbe fatti appositamente “diversi da lui e un po’ orgogliosi … perché si possa stargli davanti, contrariarlo, stupirlo” c’è il riferimento alla “Genesi” e alla nostra creazione “a immagine e somiglianza” di Dio. Dietro la potente e vigorosa rivendicazione della sua libertà di scegliere, di “dire di sì e dire di no” di Argia vi è il chiaro rimando alla grazia di origine divina che ci è stata donata di poter accettare o rifiutare il male, nonostante i condizionamenti ed i vincoli che vorrebbero limitare e piegare, spezzandola, questa libertà[80].
Altri critici ancor meglio hanno evidenziato il legame tra questo dramma, il suo epilogo, e le posizioni di Ugo Betti in merito alla religione ricavandone e sottolineandone le radici cristiane e cattoliche. «Molti concetti bettiani sono cardinali nella cultura cattolica: contrapponendo mondo occidentale e materialismo, Betti pone in rilievo -dei suoi personaggi- la coscienza individuale, che costituisce l’essenza umana e non è determinata dall’esistenza sociale. L’affermazione della responsabilità personale sorregge del resto ogni concezione etico-giuridica, mentre il concetto di peccato e quello di un Dio personale sono i capisaldi concettuali del mondo tragico bettiano e del cattolicesimo. Né si può dimenticare che il concetto di dignità della persona umana, intorno a cui ruotano sia La Regina che L’Aiuola, ha le sue radici nel cattolicesimo, anzi rappresenta la cerniera d’ogni pensiero sociale cristiano dall’Ottocento in poi»[81].
Lo stesso Betti pubblicò sulla rivista “Teatro-Scenario”, nel numero 19 del 1953 un piccolo saggio dal titolo “Teatro e Religione” i cui concetti essenziali furono successivamente ripresi su di un periodico pubblicato ad Assisi. Là egli affermava con serena e intensa progressione di ragionamento e sentimento: «Sorprenderemo nell’animo dei crudeli, degli egoisti, dei perduti, nel fondo delle amarezze più indurite, a un certo punto un “ingiustificato” bisogno di pietà, d’armonia, di solidarietà, di fiducia, di perdono, d’immortalità; e soprattutto d’amore. Cristo ci attende là. Una pietà, un amore assai maggiori di quelli che offre il mondo, pallide imitazioni. È una sete cui le fontane della terra sono avare. Ognuna di queste misteriose esigenze è il lato di un perimetro, il cui disegno completo, quando lo intravvediamo finalmente, ha un nome: Dio»[82].
- Per concludere
Ugo Betti è stato vittima di una vera e propria damnatio memoriae, unitamente ad un altro grande drammaturgo cattolico coevo, Diego Fabbri. Lo stesso destino toccato a Cesare Pavese, non appena sono emersi inediti in cui il romanziere delle Langhe si distanzia dal marxismo e dal materialismo comunista. «Ecco alcuni autori vengono preferiti se possono dare sostegno a determinate ideologie, altri che nonostante in precedenza occupassero un posto di rilievo, vengono espulsi senza pietà poiché non allineati al pensiero dominante, altri ancora, poiché non del tutto eliminabili vengono epurasti dalle scorie che potrebbero inficiarne il contenuto recuperabile, altri, ed è il destino più crudele, vengono reinterpretati, rivisitati e consegnati alla storia in una veste completamente differente da quella originale per non parlare della sequela di nomi su cui grava il marchio di innominabili»[83].
I successi di pubblico e di consensi che, come le opere di Ugo Betti, poche altre opere teatrali hanno avuto in tutto il mondo, rendono ancora meno giustificabile questa dimenticanza e quest’oblìo, anche perché il teatro di Betti non è consolatorio, pur essendo catartico; è un teatro capace di scuotere le coscienze dall’indifferenza e dal relativismo. La sua opera «[…] non ci fa rimanere impassibili di fronte all’esistenza ma ci costringe a pensare altrimenti, a riformulare in modo del tutto differente gli aspetti essenziali della nostra vita»[84]. Ancor più vero nell’epoca dei social, dell’effimero, della “società liquida” o “coriandolizzata”.
* Contributo sottoposto a valutazione.
[1] Cfr. U. Betti, Corruzione al Palazzo di Giustizia, a cura di G. Antonucci, Roma, 1993, pp. 17-20. A corredo di questa edizione del dramma bettiano si trova una sinossi biografica dell’autore curata appunto da Giovanni Antonucci, che sarà riferimento preponderante di questo nostro primo paragrafo. Si veda anche G. Giacobbe-L. Fava Guzzetta (a cura di), Ermeneutica giuridica ed ermeneutica letteraria: Emilio e Ugo Betti, Torino, 2006 e in particolare i seguenti saggi della Parte I dedicata ad Ugo Betti: W. Gerts, Ugo Betti e il palcoscenico dell’ermeneutica, p. 27 ss.; L. Fava Guzzetta, Il conclusivo approdo di un itinerario tra giustizia e pietà: i drammi della grazia, p. 37 ss.; F. Musarra, La giustizia come elemento drammatico nel teatro di Ugo Betti, p. 59 ss.
[2] M. Verdenelli, La sofferenza della parola: il teatro di Ugo Betti, vol. I, Pesaro, 2011, p. 14.
[3] F. Taviani, Betti Ugo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1967, Vol. 9, in https://bit.ly/37Q688m
[4] A. Bocelli, Betti Ugo, in Enciclopedia Italiana, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1938, Appendice I in https://bit.ly/2KApNjI
[5] U. Betti, op. cit. p. 17.
[6] Ivi, p.18.
[7] F. Taviani, op. cit.
[8] U. Betti, op. cit., pp. 18-19.
[9] Ibidem
[10] F. Taviani, op.cit.
[11] M. Verdenelli, op. cit., Vol. I, p. 20. In realtà anche nelle prime opere di James Joyce (1882-1941) le due cifre stilistiche del realismo e del simbolismo si trovano fuse e in combinazione.
[12] Ivi, Vol. II, p. 7.
[13] F. Taviani, op. cit.
[14] Ibidem.
[15] U. Betti, op. cit. p.13. La citazione è presa dall’introduzione di Giovanni Antonucci che ne ha curato questa edizione del capolavoro bettiano.
[16] Ivi, p.12.
[17] Ivi, p. 44.
[18] A. De Sio, Vite degli oscuri: Diego Fabbri ed Ugo Betti, nel blog “L’Intellettuale dissidente”, 24 marzo 2019, in https://bit.ly/37Q6D2e
[19] Cfr. Ibidem.
[20] Cfr. S. Torresani, Ugo Betti, in Id. Il teatro italiano negli ultimi vent’anni (1945-1965), Cremona, 1965, p. 74.
[21] M. Verdenelli, op. cit., Vol. I, p. 43.
[22] G. Calendoli, Ugo Betti, in M. Verdone (a cura di), Teatro Contemporaneo, Vol. II, p. 447.
[23] Ivi, p. 444.
[24] M. Verdenelli, op.cit., Vol. I, p. 42.
[25] U. Betti, Teatro Completo, con prefazioni di Silvio D’Amico ed Achille Fiocco, Bologna, 1957, p. 243. In precedenza aveva affermato: «[…] (d’un tratto passandosi le mani sul volto) Dio mio. Questo processo è un incubo», p. 233.
[26] A. De Sio, op. cit.
[27] Ibidem.
[28] U. Betti, Teatro Completo, p. 240. Nella testimonianza del figlio di Kurz (il testimone miope) troviamo due riferimenti a fatti di attualità: il conflitto generazionale tra padre e figlio e il tentativo di giustificare colpe individuali e personali con la logica deterministica del “sistema”. Sembra che quasi si anticipino modelli, comportamenti e temi propri degli anni ’60 e del ’68.
[29] M. Verdenelli, op. cit., p. 46.
[30] G. Calendoli, op. cit., p. 438.
[31] Ibidem.
[32] Cfr., Ivi, pp. 448-449.
[33] U. Betti, Teatro Completo, p. 259. Prima di questa perentoria sollecitazione, per ben altre 8 volte, Goetz ha incalzato Parsc chiedendogli di pronunciare la sentenza conferendo al dramma un ritmo da crescendo che carica di tensione e di suspence l’epilogo.
[34] A. De Sio, op. cit.
[35] U. Betti, Teatro Completo, p. 260.
[36] A. De Sio, op. cit.
[37] A. Di Pietro, L’opera di Ugo Betti, Vol. II, Bari, 1968, p. 57. Abbastanza paradossalmente uno dei più acuti e rigorosi esegeti dell’opera di Betti porta nome e cognome del procuratore che negli anni ’90 avviò quell’anomala stagione della magistratura e della giustizia italiana passata sotto il nome di “Tangentopoli”. Quasi una legge del contrappasso per chi fustigò in tempi non sospetti la non irrilevante “corruzione” che allignava nei palazzi di giustizia.
[38] U. Betti, Teatro Completo, p. 256.
[39] M. Verdenelli, op. cit., p. 47.
[40] L. Giordano, Le sofferenze degli innocenti completamento della passione di Cristo nel pensiero di Thomas Stearns Eliot, in Progresso del Mezzogiorno, Anno XXVIII – n.1 e 2, Napoli, 2004, pp. 158-160. Diverse cose accostano il teatro di Betti a quello di Eliot, come il frequente ed intenso uso della forza espressiva ed evocativa della parola ed il “tema purgatoriale” secondo cui la rinascita ha inizio allorché si prende piena coscienza del male commesso con il conseguente portato di sofferenza che tale presa di coscienza comporta ed implica.
[41] G. Calendoli, op. cit., p. 448.
[42] G. Antonucci, introduzione in U. Betti, Corruzione al Palazzo di Giustizia, pp. 18-19.
[43] Ivi, p.11. La recensione fu pubblicata dalla rivista Teatro-Scenario, anno XVII – I, 1953. Marcel ebbe ad affermare: «Ugo Betti è egli stesso un magistrato e questa esperienza diretta della professione conferisce all’opera il suo peso, il suo valore angoscioso. In alcuni tratti io ho ricordato Daumier».
[44] F. Cologni, Ugo Betti, Bologna, 1960, pp. 103-104.
[45] G. Gatti, Diritto e morale, in “Corruzione al palazzo di giustizia” di U. Betti, in Note di Pastorale Giovanile, blog salesiano, in https://bit.ly/38CMzPJ
[46] U. Betti, Corruzione al Palazzo di Giustizia, p. 26. Sembrerebbe leggere, nell’osservazioni del giudice Bata, quanto accadde a Giovanni Falcone (1939-1992) alla vigilia della sua nomina a capo della procura palermitana, poi saltata, perché vi fu nominato Antonino Mele. Dice Giovanni Antonucci nella sua ricca e documentata introduzione: «Un’atmosfera realistica, che sembra fotografare perfettamente l’Italia di oggi, di Tangentopoli ma anche quella di ieri di Sindona e di Calvi, accentuata dalla scoperta del cadavere, proprio nel Palazzo di Giustizia, di un “faccendiere” ormai liquidato, ma che, come diceva Maveri,“è stato riverito più di un ministro”».
[47] F. Cologni, op.cit., p. 94.
[48] G. Gatti, op.cit.
[49] S. D’Amico, in Prefazione a U. Betti, Il teatro completo, p. XVI.
[50] U. Betti, Corruzione al Palazzo di Giustizia, p. 85. Così il giudice Croz illustra il suo ateismo: «Non c’è altro. Non credo che qualcosa resti di noi. Staremmo freschi se davvero…qualche cosa potesse distillarsi da un tale cumulo di grullerie».
[51] Ibidem.
[52] Cfr. G. Gatti, op. cit.
[53] U. Betti, Corruzione al Palazzo di Giustizia, Roma, 1993, p. 33.
[54] Ivi, p. 53.
[55] Ivi, p. 58. “Pietosa Antigone, soave Cordelia” la definisce Croz rivelando le influenze della tragedia greca e delle grandi tragedie del Bardo di Stratford sulla drammaturgia di Ugo Betti.
[56] Ivi, pp. 64-67.
[57] Ivi, p. 88.
[58] M. Verdenelli, op. cit., pp. 8-9.
[59] U. Betti, Corruzione al palazzo di Giustizia, Roma, 1993, p. 88.
[60] Ivi, pp. 13-14.
[61] F. Taviani, op. cit.
[62] S. D’Amico, in Prefazione a U. Betti, Teatro Completo, p. XVIII. Con l’espressione “nobili scrittori di teatro” Silvio D’Amico (1887-1955) si riferisce anche al teatro di Diego Fabbri.
[63] G. Gatti, op. cit.
[64] Cfr. S. D’Amico, in Prefazione a U. Betti, Teatro Completo, pp. XXI-XXII, soprattutto in “Delitto all’isola della capre” (1946), “La Regina e gli Insorti” (1949), “L’Aiuola bruciata” (1952) che fu rappresentata per la prima volta in una chiesa, “La Fuggitiva” (1953).
[65] G. Antonucci, introduzione in U. Betti, Corruzione al palazzo di Giustizia, p. 19.
[66] L’espediente della sostituzione di persone, una costante sia del teatro comico che tragico (vedi T. M. Plauto (250 a.C.-184 a. C.), W. Shakespeare (1564-1616) e L. Pirandello) richiama alla mente il bellissimo film del 1980” Kagemusha – L’Ombra del Guerriero” di Akira Kurosawa (1910-1998).
[67] Per un approfondimento sulle radici comuni di “diritto positivo” su base relativistica e diritto rivoluzionario, cfr. A. R. Vitale, Diritto e Persona tra Storia e Ideologia nell’Esperienza Marxista, in L-JUS Rivista Semestrale del Centro Studi Rosario Livatino, Fascicolo 1-2020, Anno III, pp. 121-149.
[68] U. Betti, Teatro Completo, p.1332, Bologna, 1955.
[69] Ivi, p.1333. In verità, nel 1914, Ugo Betti si era laureato in giurisprudenza all’Università di Parma con una tesi dal titolo “Il diritto e la rivoluzione”. Antonio Di Pietro in “L’opera di Ugo Betti”, Vol. I, Bari 1966, ha ben chiarito e descritto la temperie politica, culturale e sociale in cui maturavano le posizioni di Ugo Betti sul rapporto tra diritto e rivoluzione. Il 1914 è l’anno della “settimana rossa” durante la quale, a seguito dei violenti disordini che l’accompagnarono, non pochi pensarono che si stesse trattando della vigilia di una rivoluzione politica di segno socialista rivoluzionaria. (Cfr. M. Verdenelli, op. cit., Vol. I, pp. 7-8).
[70] Ivi, p.1342.
[71] Amos sembra, col suo nichilismo, rivestire specularmente il ruolo occupato da Croz in “Corruzione”. D’altro canto in “La Regina e gli Insorti”, tra i giudici, tra i testimoni (Raim, Maupa, l’Ingegnere, l’usciere) non sembra esserci pentimento e desiderio di confessare le proprie colpe avviando un processo di purificazione e redenzione. È questo uno degli elementi di distinzione rispetto a “Corruzione al Palazzo di Giustizia” e “Frana allo Scalo Nord”.
[72] Ivi, p. 1336.
[73] Ivi, p. 1338.
[74] Cfr. Ivi, pp. 1342-1343. Argia non cede alle minacce di ritorsione verso il bambino non perché poco glie ne importerebbe di un figlio che non è suo, bensì perché sa, e lo dice, i rivoluzionari cinicamente, nella loro spietata logica, non avrebbero esitato ad uccidere comunque il bambino, anche in pendenza della sua confessione, per il solo fatto di non lasciare un erede cui eventuali controrivoluzionari avrebbero potuto far riferimento. «I nomi? (quelli dei controrivoluzionari sopravvissuti n.d.r.) Ma voi lo ucciderete in ogni caso, è evidente». Del resto se pure è vero che ella, non essendo la vera regina, non conoscesse i nomi dei controrivoluzionari, in quel clima torbido fatto di menzogne e false testimonianze, avrebbe potuto fare i nomi di Raim, dell’ingegnere pur di dare dei nomi, come nelle delazioni estorte nei regimi totalitari.
[75] Ibidem.
[76] Ivi, p. 1344. Il suo “profitto” è la dignità di persona riguadagnata con il martirio ed il sacrificio da “innocente”.
[77] Ibidem.
[78] Ivi, p.1345.
[79] T. Achilli, Il destino della donna e la grammatica del potere. “La regina e gli insorti” di Ugo Betti, in Aa.Vv., Donne e Teatro. Seminario di studi, Bari, 2012, p. 254. Si tratta degli atti di un seminario di studi organizzato dal Centro Interdipartimentale per il Teatro, le Arti visive, la Musica, il Cinema presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari. Altri, invece, come già accennato, hanno accostato l’opera di Betti alla filosofia di Gabriel Marcel; una filosofia ampiamente aperta alla trascendenza pur partendo dal nostro “esserci” e dal mistero della nostra esistenza. (Cfr. R. Salsano, Pirandello, Betti e l’esistenzialismo di Gabriel Marcel, in Aa.Vv., Lingue e letterature in contatto, Firenze, 2004, pp. 69-76.)
[80] «A un uomo si può togliere tutto, tranne una cosa: l’ultima delle libertà umane – la possibilità di scegliere il proprio atteggiamento in ogni circostanza- di scegliere il proprio modo». V. E. Frankl, L’uomo in cerca di senso, Milano, 2017. Lo psicoterapeuta, fondatore della “Logoterapia” Viktor E. Frankl (1905-1997) scrisse questo testo come risultato della sua tragica esperienza nei lager nazisti nei quali era stato internato; il messaggio sostanziale di questa sorta di reportage era che non può esserci condizione esteriore, per quanto dura, cogente, condizionante, che può strapparci questa scintilla ultima di libertà che è propria dell’uomo in quanto creato “ad immagine e somiglianza (non identico) di Dio”.
[81] F. Imbornone, Natura politica e impegno cattolico di due drammi bettiani (La Regina e gli Insorti e L’Aiuola bruciata) in Ugo Betti, Istituto di Studi Pirandelliani-Quaderni 4, Roma, 1981, pp. 84-85.
[82] S. D’Amico, in Prefazione a U. Betti, Teatro Completo, p. XXI. Non si deve cadere nell’errore di pensare ad una religiosità bigotta e fideistica di Betti: Nello stesso saggio egli aveva precisato i contorni della sua posizione in tema di religione: «[…] religione come bene da conquistare, verso il quale muove, se non un preciso proposito, un inquieto desiderio; religione come rielaborazione intima di certi principi, per sentirli più vivi e assimilabili; religione magari come nemico da aggredire, non senza ricchezza, però, di turbamenti e rimorsi».
[83] A. De Sio, op. cit.
[84] Ibidem.