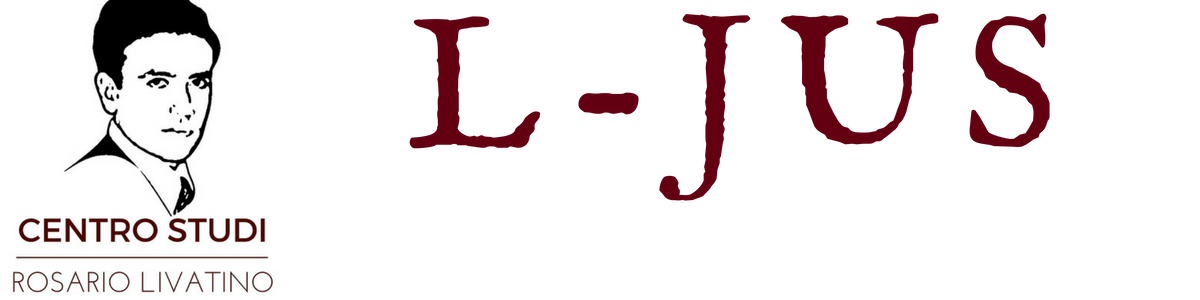Mauro Ronco
Avvocato in Torino e Professore Emerito di Diritto Penale
Università degli Studi di Padova
Sommario: 1. Una breve premessa storica ‒ 2. I valori in gioco nella tutela del segreto ‒ 3. L’oggetto del segreto professionale dell’avvocato ‒ 4. L’erosione del segreto professionale dell’avvocato ‒ 5. La testimonianza del difensore contro l’assistito ‒ 6. Brevi conclusioni.
- Una breve premessa storica
Il segreto professionale dell’avvocato come limite del dovere della deposizione testimoniale in ordine a quanto egli ha conosciuto per ragione della sua professione costituisce l’oggetto di una tradizione antica e consolidata, che è divenuta un ethos di carattere etico del professionista forense.
Per limitarci a un esempio del passato, vale la pena ricordare che l’art. 288 del codice di procedura penale del 1865 stabiliva che: «gli avvocati e i procuratori non possono, sotto pena di nullità, essere obbligati a deporre sopra quei fatti o circostanze di cui essi non abbiano cognizione che in seguito a rivelazione o confidenza ad essi fatta dai loro clienti nell’esercizio del proprio ministero» (che trovava un esatto corrispondente nell’art. 274 del codice di procedura penale del Regno di Sardegna).
Accanto all’esenzione dall’obbligo per gli esercenti le private professioni forensi, la legge dell’epoca contemplava la medesima esenzione per gli esercenti le professioni sanitarie, nonché per “ogni altra persona” che si trovasse in una situazione, giuridicamente precisabile, analoga, sotto il predetto profilo, a quelle specificamente indicate. La giurisprudenza riteneva consuetamente come soggetti esenti i pubblici ufficiali di qualsiasi ordine e i sacerdoti[1]
La classe forense è sempre stata gelosa di questa prerogativa, che non costituisce un privilegio arbitrariamente concesso dallo Stato, bensì un interesse fondamentale della società e della giustizia, che non potrebbe amministrarsi in modo equo senza il libero esercizio della difesa.
Pasquale Stanislao Mancini, giurista di formazione liberale, Ministro di Grazia e Giustizia del Regno d’Italia e maestro insigne di diritto costituzionale, di diritto pubblico e penale, fu autore di un parere memorabile sul segreto professionale degli avvocati. In qualità di Presidente del Consiglio degli Avvocati di Roma scrisse al Presidente del Consiglio di Pesaro, che gliene aveva fatto richiesta, sull’inviolabilità del segreto in un caso in cui era stata richiesta dall’Autorità giudiziaria la testimonianza di un avvocato in ordine alle informazioni confidategli dal proprio cliente, non nell’ambito della sua difesa in un processo penale o civile, bensì nell’ambito di una consultazione professionale estranea alla celebrazione del processo. Mancini affermò con forza e ricchezza di argomenti la tesi che l’esenzione dalla testimonianza riguardava anche questa tipologia di rapporti tra avvocato e cliente, scrivendo: «Vi è rapporto di avvocato e cliente non solamente allorché esista un processo pendente in materia penale o civile, ed un avvocato sia stato già nominato difensore della causa e del litigante; ma è benanche parte del ministero dell’avvocato, e parte essenziale e nobilissima la semplice consultazione, la quale si esercita sempre che un cittadino riponendo la sua fede in un avvocato rivestito di tale qualità, pone il piede nel santuario del suo gabinetto, e va ad interrogarlo ed intrattenerlo sopra materia giuridica, che in qualsiasi guisa possono riferirsi ad un processo, pendente o futuro, in cui egli o qualunque suo congiunto o committente abbiano interesse».
Per dare maggior rilievo alla sua affermazione Mancini accostò lo status dell’avvocato a quello degli ecclesiastici, citando le pronunce della Corte di Cassazione francese nel senso da lui patrocinato.
In esse gli ecclesiastici erano stati considerati esenti dall’obbligo di testimonianza non solo per i segreti loro confidati “sotto il suggello della confessione”, ma anche per i segreti ricevuti «fuori dalla confessione, e senza essersi amministrato al rivelatore il sacramento della penitenza, secondo le forme e le regole della pratica religiosa…»[2].
- I valori in gioco nella tutela del segreto
Nell’epoca contemporanea si sono moltiplicate le fonti normative che conferiscono la più ampia protezione al segreto professionale degli avvocati, i cui corollari sono l’esenzione dall’obbligo della testimonianza sulle notizie ricevute in ragione del ministero esercitato (art. 200 c.p.p.) e dall’obbligo di esibire immediatamente gli atti e i documenti e ogni altra cosa esistente presso di essi per ragione della loro professione, previa dichiarazione per iscritto che si tratti di segreto inerente alla loro professione (art. 256 c.p.p.).
Senonché, a fronte di un plesso normativo sempre più garantistico, l’esperienza della vita giudiziaria e alcune disposizioni normative degli anni recenti sembrano aprire brecce preoccupanti all’intangibilità del segreto professionale.
La ragione della contraddizione risiede molto probabilmente nella sempre maggiore tensione etica esistente nella società in ordine ai valori che meritano di essere protetti, soprattutto quando vengono confrontati con altri valori.
Il regime processuale per la rilevanza del segreto professionale tende infatti a contemperare il bene della riservatezza del rapporto tra assistito e avvocato con l’interesse all’accertamento giurisdizionale di uno o più eventi di carattere storico rilevanti per il diritto.
Il giudizio di bilanciamento fornisce esiti diversi a seconda del valore che la società – e, conseguentemente, la legge e la giurisprudenza – attribuiscono ai valori contrapposti. È evidente, pertanto, che quanto più pregnante sia il valore dell’assistenza legale rispetto al valore dell’accertamento giurisdizionale, tanto maggiori saranno i limiti all’ingerenza dell’Autorità giudiziaria nel sacrario della coscienza dell’avvocato e, viceversa, quanto più sia apprezzato il raggiungimento dello scopo di accertare i fatti, tanto più saranno larghe le prerogative dell’Autorità giudiziaria nell’obbligare alla rivelazione del segreto.
Il ragionamento concernente il segreto professionale è analogo – servata distantia – a quello relativo al segreto ecclesiastico. Anche qui sono in gioco due valori. Il primo può essere addirittura di carattere sacramentale, ove il segreto sia stato rivelato al sacerdote nell’ambito dell’amministrazione della penitenza, oppure anche non sacramentale, ove il segreto sia stato confidato a un sacerdote, a un religioso o a una religiosa nell’ambito di un rapporto instaurato per consiglio o per sostegno spirituale. Il valore contrapposto è sempre, come per il segreto professionale, l’accertamento giudiziario in ordine a un fatto di reato.
La tensione in ordine al riconoscimento dei valori è assai accesa nella società contemporanea, in cui si contrappongono spesso visioni contraddittorie tra loro.
Con riferimento al tema del segreto in generale va rilevata la fortissima tensione tra il valore della trasparenza e il valore della riservatezza personale. Per un verso, un’insistente pressione mediatica fa apparire meritevoli di lode coloro che si offrono al pubblico in tutte le loro inclinazioni e tendenze; per un altro verso, l’interpretazione personalistica dei diritti umani fondamentali mette in luce l’esigenza costituzionale di tutela dell’intimità della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni.
Esaminando, poi, i valori che entrano in gioco nel bilanciamento tra la tutela del segreto della coscienza, soprattutto – ma non solo – quando esso attinge l’ambito del sacramento, e del segreto professionale, da un canto, e, dall’altro canto, l’interesse sociale all’accertamento giurisdizionale dei fatti rilevanti per il diritto penale, ci si rende conto dell’esistenza di una frattura verticale all’interno della società civile.
I sostenitori del primato della giurisdizione tendono a mettere in crisi l’intangibilità del segreto, sia confessionale che professionale, con argomenti talora seducenti, quali, per esempio, la tutela delle persone offese dal delitto; il perseguimento senza remore della criminalità organizzata; la lotta senza quartiere alla corruzione politica, economica e finanziaria; le esigenze dell’Erario in vista del perseguimento dell’equità fiscale.
Si tratta indubbiamente di valori importanti nel quadro costituzionale; occorre però vedere se i beni tutelati dal principio dell’intangibilità del segreto confessionale e professionale non siano più intimamente – e quindi, costituzionalmente – necessari allo svolgimento della persona umana, riconosciuti come diritti inviolabili ex art. 2 Costituzione, non concessi dallo Stato, che stanno a un livello superiore rispetto agli altri interessi, pur rilevanti, che si sono in precedenza menzionati.
Il segreto sigillato dal Sacramento è un bene spirituale che non può essere scalfito in alcun modo dall’ordinamento giuridico. Vero è, tuttavia, che appaiono talora, qua e là, nei paesi dell’Occidente ormai radicalmente secolarizzato, minacce che vorrebbero porre dei limiti all’inviolabilità del sigillo.
In qualche occasione vengono attuati dei tentativi subdoli che cercano di aggirare l’intangibilità del segreto con la confusione tra il piano giudiziario, proprio dell’autorità temporale, e il piano sacramentale e spirituale, che è di esclusiva pertinenza della Chiesa.
- L’oggetto del segreto professionale dell’avvocato
Non mi soffermo sul tema del segreto confessionale, che non è di mia competenza, e passo subito al segreto professionale e all’ingerenza in esso dell’autorità giudiziaria e, talora, addirittura, dell’autorità amministrativa.
Occorre in primo luogo comprendere adeguatamente il significato del segreto professionale dell’avvocato (ma sarebbe anche utile esaminare il significato, altrettanto fondamentale, del segreto dell’esercente una professione sanitaria), che troppo spesso viene ridotto alla dimensione individualistica della libertà del rapporto di fiducia tra assistito e avvocato. La protezione del segreto professionale è cosa ben più pregnante della semplice tutela di un rapporto di prestazione d’opera, perché è un bene comune tanto dell’assistito, considerato nella dimensione profonda dell’intimità personale; quanto dell’avvocato, nella dimensione che lo caratterizza intrinsecamente come advocatus, cioè di chiamato a soccorso di una persona in stato di necessità, tenuto a un dovere ineludibile di “fedeltà” e di “segretezza e riservatezza”; doveri previsti rispettivamente agli articoli 7 e 9 del Codice deontologico; quanto, infine, e non da ultimo, dello stesso bene della giustizia, per il cui esercizio è essenziale che ciascuna persona sia difesa nel processo. Questo integra un “diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”, secondo il dettato dell’art. 24, co. 2 della Costituzione, del § 16 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e, infine, dell’art. 111, co. 2 della Costituzione che indica nel “contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”, il nucleo indefettibile del processo giusto.
Ove è evidente che se, in qualsiasi momento, il difensore fosse costretto a testimoniare in giudizio, anche contro il suo assistito, sui fatti venuti a sua conoscenza in ragione del ministero defensionale, sarebbero lesi allo stesso tempo: 1. il diritto inviolabile dell’assistito alla riservatezza personale; ii) il dovere di fedeltà e di segretezza che costituiscono le prerogative tipiche ed essenziali della professione forense; iii) il bene della giustizia, perché si consentirebbe la celebrazione del giudizio al di fuori del contraddittorio tra parti in condizione di parità, per essersi l’avvocato trasformato da difensore in accusatore e per essere stato il giudicabile privato del contraddittorio tecnico indispensabile per far valere le sue ragioni davanti al giudice.
Alla luce di queste considerazioni appare evidente il carattere recessivo delle ragioni poste alla base di una limitazione legislativa o di una erosione per via giurisprudenziale dell’intangibilità del segreto professionale.
Ciò è tanto vero sol che si pensi che la legge ha previsto stringenti controlli per evitare ogni abuso da parte del difensore. Il co. 2 dell’art. 200 del codice di rito contempla infatti la facoltà del giudice – e, oggi si dice, con ampliamento discutibile, o anche del pubblico ministero – di disporre gli accertamenti necessari in ordine alla fondatezza dell’exceptio difensiva per esimersi dal deporre. Ove la dichiarazione «sia infondata, [il giudice] ordina che il testimone deponga».
Questa disposizione vale nei riguardi di tutti i soggetti che possono avvalersi dell’exceptio, non solo dell’avvocato, ma anche del ministro della confessione religiosa, del medico, del commercialista e degli altri destinatari dell’esenzione previste dall’art. 200 c.p.p. e dalle norme successivamente intervenute.
L’accertamento giudiziario sulla fondatezza della dichiarazione si svolge de plano, senza alcuna garanzia difensiva, e verte su un tema delicato e quanto mai scivoloso, relativo all’aver appreso l’interessato la notizia «per ragione del proprio ministero, ufficio o professione» (art. 200, co. 1).
In questo punto si annida il rischio, tutt’altro che remoto, dell’abuso da parte del giudice o, ancor più, del pubblico ministero, se si ammettesse che questi, nella fase delle indagini preliminare, abbia facoltà di ordinare di deporre a chi eccepisce il segreto.
Come si è accennato in apertura, quale è esattamente il perimetro dell’esercizio del ministero spirituale o dell’attività professionale? Per il sacerdote, soltanto il perimetro delimitato dal sigillo sacramentale o anche lo spazio più ampio della consulenza e della direzione spirituale?
Per l’avvocato, poi, l’esenzione vale soltanto per ciò che egli ha appreso nell’ambito della difesa formalizzata da una nomina ritualmente depositata in atti ovvero anche dalla designazione della persona per l’esercizio di attività difensive, ex art. 391-bis ss., o, ancora più ampiamente e opportunamente, anche per l’attività di consulenza e consiglio in affari penali e civili?
La migliore dottrina ritiene che l’espressione “per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte” dovrebbe essere interpretata nel senso che oggetto del segreto professionale è la notizia appresa in ragione del nesso che deve obbligatoriamente sussistere tra apprendimento della notizia ed esercizio dell’attività professionale, con la conseguenza che soltanto ciò che è stato rivelato al professionista, indipendentemente da ogni prestazione professionale, e, cioè, per esempio, in qualità di amico, conoscente o generico confidente, non costituisce oggetto di tutela a norma dell’art. 622 c.p. e, quindi, non vale come ragione di esenzione dalla testimonianza ai sensi dell’art. 200 c.p.p.[3].
I margini di discrezionalità della valutazione giudiziaria sull’opponibilità del segreto sono indubbiamente ampi. Non infrequentemente, invero, nell’ambito dei rapporti di tipo professionale si instaurano relazioni di confidenza che inducono l’assistito a rivelare, sotto vincolo di segreto, notizie concernenti la propria esistenza personale e le proprie traversie di vita.
Ancora più ampia è la discrezionalità valutativa – fin quasi a determinare la pratica inoperatività del divieto di testimonianza – per il sacerdote, il religioso o la religiosa che abbiano acquisito informazioni riservate nell’ambito di un rapporto di direzione spirituale o di consiglio di tipo morale sulle condotte del confidente al di fuori del sigillo sacramentale.
L’interpretazione benigna, che logicamente dovrebbe prevalere, trova ostacolo nel fatto che i rapporti di direzione spirituale o di consulenza morale non sono regolamentati in alcuna maniera e comunque difficilmente sono presi in considerazione da parte dell’Autorità giudiziaria, soprattutto nella fase delle indagini preliminari, allorché il pubblico ministero è arbitro pressoché assoluto in ordine alla fondatezza della dichiarazione di astensione.
- L’erosione del segreto professionale dell’avvocato
é opportuno scendere a qualche esemplificazione circa l’erosione della facoltà di astensione del professionista. Ciò sta accadendo nel campo della normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – integrata da quella relativa alla normativa antiterrorismo (D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109) – nella parte in cui impone anche ai professionisti, avvocati, notai, dottori commercialisti ed esperti contabili, l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (art. 41 ss. D.lgs. 231/2007).
Gli avvocati sono esentati da tale obbligo nella fase c.d. “contenziosa” o “pre-contenziosa” (art. 12, co. 2); l’obbligo sussiste, tuttavia, quando l’avvocato presti l’assistenza in materia contrattualistica, in operazioni di ristrutturazione societaria, di consulenza in campo economico e finanziario. La Corte di giustizia europea ha peraltro statuito che gli obblighi di informazione e di collaborazione con le Autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio, imposti agli avvocati dall’art. 2-bis punto 5 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2001, non violano il diritto a un equo processo, come garantito dagli artt. 6 della CEDU e 6 n. 2 UE[4].
In particolare, poi, il co. 7 dell’art. 45 D.lgs. n. 231/2007 statuisce che “l’identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede”. La deroga al segreto professionale dell’avvocato è evidente, in quanto il professionista, che in una fase successiva del processo può astenersi dal deporre, può essere costretto nella fase prodromica del procedimento alla rivelazione del nominativo del cliente.
L’erosione del segreto professionale è avvenuta anche nel campo della legislazione europea a riguardo dello scambio automatico di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di codifica.
Particolare preoccupazione desta però la ricerca della prova tramite i mezzi intercettativi delle conversazioni telefoniche o ambientali e, ancor più, tramite il sequestro e la trascrizione delle conversazioni intercorse tra l’avvocato e il proprio assistito avvenute per via telematica.
È noto che l’art. 103 del codice di rito, tra le varie garanzie di libertà del difensore (in particolare a riguardo delle ispezioni, delle perquisizioni negli uffici dei difensori e della corrispondenza tra imputato e il proprio difensore) contempla al comma 5 in modo tassativo che «Non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite».
Accade frequentemente, però, che le conversazioni tra il difensore e l’assistito siano intercettate. Ciò perché sarebbe inoperante il divieto legislativo quando l’utenza intercettata è quella dell’assistito e non del legale. L’intercettazione, infatti, non sarebbe destinata a controllare specificamente le comunicazioni tra l’assistito e il professionista. L’attività di ricerca della prova sarebbe allora legittima, in quanto, sulla base di un giudizio ex ante, essa non sarebbe dettata dall’intento di ingerirsi nello spazio protetto dall’art. 103, co. 5 c.p.p. L’intercettazione sarebbe avvenuta per mera casualità. La violazione della norma sarebbe, inoltre rimediabile dichiarando l’inutilizzabilità dei risultati acquisiti.
Ora, se effettivamente si conferisse rilievo al carattere casuale della captazione, il rimedio dovrebbe essere l’interruzione dell’intercettazione.
Invece, il rimedio postumo consente: i) l’acquisizione di eventuali notitiae criminis che l’indagato confida al difensore per essere dallo stesso in futuro difeso, utilizzabili perché avulse dal mandato difensivo attualmente affidato all’avvocato; ii) la selezione da parte del pubblico ministero del materiale utilizzabile e di quello non utilizzabile; iii) la conoscenza preventiva, comunque, della strategia difensiva e delle iniziative che la difesa intende compiere, con la vanificazione sostanziale del diritto di difesa.
L’inutilizzabilità del risultato del processo non preclude, infatti, che la parte d’accusa conosca preventivamente i segreti che l’accusato ha confidato al suo difensore. Si pensi soltanto alla captazione della conversazione telefonica in cui l’accusato mostri al suo difensore incertezza in ordine a un atteggiamento di negativa dell’accusa ovvero di tipo confessorio. La conoscenza preventiva da parte del pubblico ministero di questa situazione provoca un vulnus al diritto di difesa. Nella realtà, poi, le cose non sono così semplici. L’assistito, pur intenzionato a negare l’accusa, può rivelare alcune notizie segrete al difensore che, venute a conoscenza e opportunamente sviluppate dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, possono consentire di ottenere la prova del fatto.
Sarebbe anche legittimo per la giurisprudenza captare conversazioni in presenza tra l’avvocato e l’assistito. Ciò può accadere quando nel locale destinato ai colloqui della struttura carceraria siano stati introdotti apparecchi di ascolto delle conversazioni tra l’indagato e le persone ammesse a conferire con loro, ovvero quando l’assistito si trovi in stato di arresti domiciliari in un luogo in cui sia stato inserito un mezzo di captazione delle conversazioni in presenza e l’avvocato si sia recato in quel luogo per conferire con il proprio cliente.
Se i colloqui del detenuto con il proprio difensore, avvengono in questi stessi locali, come talora accade, anche in questo caso è violato il disposto del co. 5 dell’art. 103 c.p.p. é ovvio che il risultato delle captazioni non sarà utilizzabile nel processo. Ma i gravi inconvenienti prima riferiti con riferimento alle intercettazioni telefoniche sono gli stessi.
La violazione del segreto professionale è divenuta assai frequente anche in virtù dei sequestri e delle conseguenti trascrizioni della corrispondenza informatica tra avvocato e assistito, mescolata alla congerie innumerevole di conversazioni o chat dell’assistito con terze persone. Nella rete delle chat o delle e-mail cadono anche le comunicazioni tra difensore e imputato, che diventano oggetto di visione, di controllo e di selezione da parte del pubblico ministero e della polizia giudiziaria.
L’interpretazione giurisprudenziale corrente in ordine alle intercettazioni e all’acquisizione dell’intero volume delle comunicazioni informatiche svuota di significato il divieto del co. 5 dell’art. 103 c.p.p. nella sua ratio garantistica effettiva.
Lo scopo del divieto, prima ancora di evitare l’uso del prodotto dell’intercettazione, è di salvaguardare lo spazio di libertà del rapporto fiduciario tra avvocato e accusato e, conseguentemente, la piena espressione del diritto di difesa nel processo.
- La testimonianza del difensore contro l’assistito
I processi di criminalità organizzata costituiscono il terreno in cui affiorano spesso profili che mettono a rischio il diritto di difesa e travolgono talora l’intangibilità del segreto che il difensore ha l’obbligo di mantenere in ordine alle notizie acquisite dall’assistito in forza dei suoi doveri di “lealtà” e di “segretezza”.
Il caso, sorto in un ambiente in cui già la funzione dell’avvocato, per sua responsabilità, si era degradata, riguarda la testimonianza del difensore contro il suo assistito, ammessa nelle forme dell’art. 210 c.p.p. dalla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Il difensore di uno degli imputati, divenuto collaboratore di giustizia, è stato ammesso a testimoniare sul contenuto specifico delle discolpe che, addotte dall’imputato sin dal primo grado, «avevano costituito la struttura portante dell’appello proposto da quel difensore avverso la sentenza di condanna… il difensore, divenuto collaboratore, ha affermato che la discolpa proposta dall’imputato non aveva alcun fondamento di verità (essa, a suo dire, era frutto di un tentativo di inficiare la genuinità delle prove) e, conseguentemente, che quanto proposto con l’atto di appello (rinnovazione del dibattimento compreso) non aveva fondamento»[5].
La Corte di Appello ha ammesso la testimonianza sul rilievo che il difensore, divenuto collaboratore dopo la presentazione dell’atto di appello e l’instaurazione del giudizio di impugnazione, aveva dismesso il mandato difensivo. Pertanto, non sarebbe più sussistita l’incompatibilità con l’ufficio di testimone, giacché l’art. 197, co. 1 lett. d) c.p.p. prevede tale incompatibilità, oltre che per coloro che hanno svolto nel medesimo procedimento la funzione di giudice e pubblico ministero, soltanto per il difensore «che abbia svolto attività di investigazione difensiva», e non per il difensore che abbia svolto la difesa nelle precedenti fasi del giudizio.
L’ordinanza del giudice è improntata a un formalismo che non tiene conto della ratio dell’art. 197 co. 1 c.p.p. Invero, se è incompatibile il difensore che ha svolto indagini difensive, a fortiori è incompatibile il difensore che ha esercitato la difesa durante le indagini e addirittura nel corso del primo grado del giudizio. Più ancora: se è incompatibile il pubblico ministero che ha partecipato al processo, allo stesso modo dovrebbe essere incompatibile il difensore che ha rappresentato l’accusato.
Particolarmente grave è stata la violazione deontologica del legale dell’imputato sotto il profilo del tradimento dell’obbligo di fedeltà e dell’obbligo del segreto. Egli avrebbe potuto avvalersi dell’esenzione contemplata dal co. 1 dell’art. 200, in quanto aveva ricevuto le informazioni segrete nell’ambito e a causa dell’esercizio del suo ministero. La decisione di testimoniare contra il suo assistito e di svelare la falsità dell’apparato da questi ordito a discolpa rivela la condizione di degrado in cui egli svolgeva la professione. D’altra parte, la posizione assunta di collaboratore di giustizia costituiva per lui una ragione psicologica di intenso disagio, tale da spingerlo alla violazione per conseguire vantaggi personali nel trattamento sanzionatorio e in ordine alle misure custodiali applicabili nei suoi confronti.
Tuttavia, né lo scopo, perseguito dalla pubblica accusa, di colpire un soggetto appartenente alla criminalità mafiosa avvalendosi della testimonianza dell’avvocato che lo aveva assistito, né l’interesse di costui di apparire trasparente di fronte alla giustizia allo scopo di ottenere sconti di pena per gli altri reati da lui commessi, giustificano l’inqualificabile gesto.
L’aspetto più grave che soggiace alla vicenda è però di carattere ordinamentale. L’impianto del processo giusto, statuito dall’art. 111 della Costituzione, è stato sovvertito. Infatti, non soltanto è stato violato il principio dell’art. 24, co. 2 della Costituzione, che proclama l’inviolabilità del diritto di difesa; non soltanto l’avvocato ha infranto i doveri deontologici di lealtà e segretezza; ma soprattutto è svanito il diritto al contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti al giudice.
Il contradditorio, invero, costituisce – alla stregua dell’esperienza e in forza del dettato costituzionale – il nucleo centrale e ineliminabile del processo, come metodo che consente normalmente di conoscere meglio la verità dei fatti e come garanzia per l’accusato di difendersi provando, cioè di difendersi con le stesse armi a disposizione della pubblica accusa.
Né il contraddittorio costituisce un ostacolo all’accertamento della verità storica (per quanto sia possibile conoscerla nell’estrema complessità delle vicende umane), avvilendo la posizione del pubblico accusatore. Occorre tener conto che questi è, in tutta la fase delle indagini preliminari, il protagonista della ricerca della prova, tramite l’utilizzo di mezzi ampi e invasivi della libertà e del diritto alla riservatezza e all’intimità di vita dell’indagato, coadiuvato dalle forze della Polizia giudiziaria.
Il diritto di difendersi provando si confronta nel contraddittorio con il diritto dell’organo di accusa di provare la fondatezza dell’imputazione. Il contraddittorio non frappone alcun ostacolo alla ricerca della prova da parte dell’accusa, ma costituisce il semplice diritto dell’accusato di confrontarsi ad armi pari almeno nella fase del giudizio davanti al giudice.
Ammettere, sia pure in una ipotesi aberrante, la testimonianza contra l’imputato del suo precedente difensore significa rendere vacuo il valore centrale del contraddittorio, annullando il diritto di difesa.
- Brevi conclusioni
La crisi del diritto di difesa trova alla sua origine delle cause oggettive, costituite dall’estensione e dal raffinamento delle tecnologie di controllo delle persone. Tale crisi è parte del più generale e inquietante fenomeno del ridursi degli spazi di libertà concreta della persona. In sostituzione delle libertà concrete, codificate nella Carta costituzionale, dell’inviolabilità del domicilio, della libertà di circolazione, del diritto di riunirsi e di associarsi, del diritto di professare la propria fede, di celebrare in privato o in pubblico il culto e di propagandare liberamente la fede in tutta la società, si offrono all’uomo contemporaneo utopie libertarie contrarie alla natura e alla libertà umana, quasi a titolo di compensazione per lo svanire dei veri diritti umani fondamentali.
L’amministrazione della giustizia non deve farsi trainare da questo fenomeno dilagante di invasione nell’intimità delle persone e di annullamento delle libertà concrete individuali. Essa deve preservare con la massima cura i diritti concreti dei cittadini e, in particolare, i diritti che nel processo garantiscono all’imputato la dignità e, in qualche misura, la parità con l’accusatore. L’advocatus si immedesima con lui per prestargli l’aiuto e il soccorso di cui necessita in modo vitale. Questa funzione è turbata in modo grave dallo svilimento del segreto. La consapevolezza di poter essere intercettati nei dialoghi telefonici con l’assistito; la consapevolezza che qualsiasi dialogo per via informatica con lui sarà sottoposta al vaglio della pubblica accusa e della polizia, anche se sarà per essere scartato come elemento di prova ex post inutilizzabile, incide sostanzialmente sulla libertà di esercizio del diritto di difesa.
Il rischio è che la sacralità insita nell’amministrazione della giustizia sia svilita e disprezzata; che l’autorità giudiziaria, mossa da un desiderio apprezzabile di giustizia, finisca – per l’oscuramento dei princìpi che regolamentano in modo rigoroso l’esercizio della difesa dell’accusato – di offuscare la nobiltà del suo ufficio.
[1] P.S. Mancini, Intorno al segreto professionale degli avvocati, riprodotto in Indice pen., 1988, 1, p. 8.
[2] Ibidem, p. 11.
[3] R. Borgogno, Segreto professionale e riservatezza. Profili penali e implicazioni sistematiche, Roma, 2012, p. 130.
[4] Grande Sezione della Corte di giustizia 26 giugno 2007, C. 305-05, in Dir. e prat. soc., 2003, 3, p. 50.
[5] S. Furfaro, Testimonianza contra del difensore e giusto processo (ovvero “quando l’avvocato si pente”), in Archivio Penale, 2015, n. 1, p. 2.