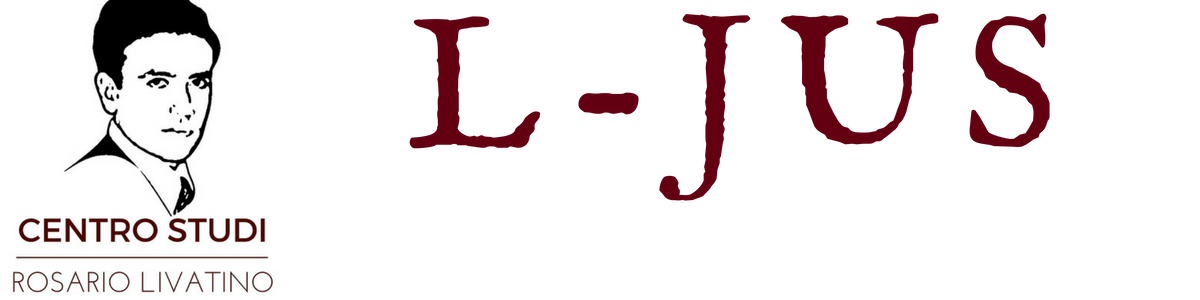Domenico Airoma
Procuratore della Repubblica di Avellino
Sommario: 1. La rivoluzione copernicana del processo accusatorio ‒ 2. L’obbligo di denuncia ‒ 3. Il dovere di testimoniare ‒ 4. Deroghe al dovere di testimoniare ‒ 5. Presupposti e condizioni della deroga ‒ 6. La valutazione del giudice ‒ 7. I recenti orientamenti giurisprudenziali ‒ 8. Le ragioni di un attacco ‒ 9. Rimedi discutibili ‒ 10. Una colpa di appartenenza ‒ 11. Quali scenari futuri.
- La rivoluzione copernicana del processo accusatorio
Il codice Rocco, agli artt. 2 e 3, prevedeva un dovere generale di rapporto per tutti i pubblici ufficiali, ivi compresi gli ufficiali di p.g., mentre gli artt. 7 e 8 prevedevano una facoltà di denuncia per ogni persona che avesse notizia di un reato perseguibile di ufficio.
Con il nuovo codice, non si parla più di rapporto, ma solo di denuncia, sia che provenga dal pubblico ufficiale che dal privato, mentre si disciplina distintamente l’informativa che la p.g. è tenuta a rimettere al p.m. ai sensi dell’art. 347 c.p.p.
Lo scenario è radicalmente mutato.
È il P.M. dominus della fase delle indagini preliminari; egli ricerca la notizia di reato, non la riceve soltanto. La prospettiva si sposta dalla fonte della notizia di reato al soggetto che la deve istruire.
In tale prospettiva assume rilievo centrale la individuazione dei criteri di priorità relativi all’esercizio dell’azione penale come vulnus consentito al principio di obbligatorietà.
- L’obbligo di denuncia
Non vi è, nel sistema penale italiano, un obbligo di denuncia per i privati tranne che con riferimento a determinate ipotesi di reato (art. 364 c.p., in relazione ai delitti contro la personalità dello Stato, che tutelano le esigenze primarie di difesa contri nemici esterni o interni di particolare pericolosità per l’ordine democratico).
Questa è una delle principali differenze fra un sistema penale proprio di un ordinamento fondato sul rispetto delle libertà e delle autonomie individuali ed uno autoritario o totalitario (aperto o subdolo che sia).
Un sistema fondato sull’obbligo di denuncia del privato mostra di considerare i cittadini come sudditi ed accetta il rischio della delazione; in più, una denuncia fatta per il timore di evitare ritorsioni o incriminazioni per la violazione ‒ necessariamente sanzionata ‒ dell’obbligo di segnalazione alla pubblica autorità è di per sé portatrice di un interesse, laddove il principale canone ermeneutico della genuinità di una dichiarazione accusatoria risiede proprio nel disinteresse dell’accusatore.
- Il dovere di testimoniare
Il dovere di testimoniare ha una portata più ampia rispetto all’obbligo di denuncia e si fonda sulla necessaria cooperazione, gravante su tutti i consociati, all’accertamento della verità fattuale che è lo scopo del processo penale.
Se non vi è un obbligo di dare corso al procedimento attraverso il quale lo Stato esercita la propria pretesa punitiva, vi è, però, il dovere di piena lealtà laddove si è chiamati a svolgere il munus publicum del testimone.
La rilevanza pubblicistica della testimonianza è dimostrata, oltre che dalle aspre sanzioni riservate alla falsità ed alla reticenza, anche dalla corposa cintura protettiva che il legislatore ha apprestato per proteggere il testimone da interventi diretti alla subornazione o alla corruzione di quest’ultimo.
Tuttavia, il nostro ordinamento prevede delle ipotesi di diritto al silenzio, fondate sulla peculiarità dei diritti e dei principi che reclamano di essere bilanciati con l’esigenza, scolpita nell’art.112 Cost., di dare attuazione alla legge.
Il sistema penale italiano esonera, ad esempio, dal dovere di testimoniare la persona indagata od imputata, sulla base della ritenuta prevalenza del diritto di difesa rispetto alla potestà punitiva dello Stato, che deve poter fare a meno della confessione del destinatario della pretesa stessa ai fini dell’accertamento della di lui responsabilità. Il principio nemo tenetur se detegere è espressione di una visione propria di una civiltà, non solo giuridica, che vede la libertà della persona un cardine fondamentale, soprattutto nel garantire ad essa il diritto di scegliere se cooperare confessando o se difendersi, fino a dichiarare il falso.
La confessione è il fine tipico del processo penale proprio dei regimi totalitari, non di quelli di stampo liberale.
- Deroghe al dovere di testimoniare
Vi sono altri casi in cui il legislatore italiano, e non solo, riconosce il diritto al silenzio.
Si tratta di talune deroghe al dovere di testimoniare che si fondano sul rilievo attribuito alla veste del dichiarante, al suo status, in quanto ritenuto coincidente con un interesse pubblico.
La disciplina è contenuta nell’art. 200 c.p.p.; si fa riferimento a talune categorie professionali nonché ai ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
La prima domanda da porsi attiene alla ratio, cioè alle ragioni ed alle finalità che hanno spinto il legislatore a prevedere delle deroghe ad un dovere così fondante il consorzio civile.
La dottrina e la giurisprudenza, in modo pressocché unanime, individuano la ratio nella libertà e sicurezza dei rapporti intimi e professionali, determinati dalla necessità o quasi necessità; laddove tale necessità va posta in relazione all’esigenza di soddisfacimento di un qualsiasi desiderio, non necessariamente di bisogni primari e imprescindibili.
In altri e più chiari termini, quel che si vuole preservare dall’invadenza indebita dall’autorità statuale è il rapporto che si viene ad instaurare con quel professionista o quel ministro la cui funzione è indispensabile per realizzare un’aspirazione o un bene della vita.
Fin qui, la ratio. Ma qual è l’oggetto della tutela?
L’oggetto della tutela è il diritto al segreto professionale, o meglio, ministeriale, nella sua funzione strumentale di protezione del sottostante interesse al ricorso alle prestazioni di necessità o quasi necessità; interesse che sostanzia diritti: come nel caso del diritto di difesa, nel diritto alla salute, nella libertà religiosa.
La ratio e l’oggetto della tutela spiegano anche il motivo per il quale, se, come si è detto, il libero professionista o il ministro religioso non hanno una posizione diversa dal privato quanto all’obbligo di denuncia, discorso diverso è per il dovere di testimoniare, giacché il privato è obbligato a rendere testimonianza, mentre i primi, a determinate condizioni, non lo sono.
Ratio e oggetto della tutela spiegano pure come il legislatore intenda attribuire una posizione privilegiata non tanto alla persona esercente quella funzione, ma alla funzione, al ministero esercitato e con esso al rilievo pubblico della stessa, per l’importanza che essa riveste per il consorzio civile ed il bene comune.
Sul punto, la Corte Costituzionale, nella sentenza nr. 87 dell’8 aprile 1997, ha chiarito come, in virtù della ratio della tutela accordata dal legislatore, la disciplina del segreto ministeriale debba intendersi non tanto come eccezione alla regola del dovere di testimoniare, ma come piena attuazione dei diritti e delle libertà sottostanti.
«L’esenzione dal dovere di testimoniare non è, dunque, diretta ad assicurare una condizione di privilegio personale a chi esercita una determinata professione. Essa è, invece, destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che ad un difensore tecnico possano, senza alcuna remora, essere resi noti fatti e circostanze la cui conoscenza è necessaria o utile per l’esercizio di un efficace ministero difensivo. Da questo punto di vista la facoltà di astensione dell’avvocato non costituisce un’eccezione alla regola generale dell’obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza ed il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. L’ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell’ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento. La protezione del segreto professionale, riferita a quanto conosciuto in ragione dell’attività forense svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume carattere oggettivo, essendo destinata a tutelare le attività inerenti alla difesa e non l’interesse soggettivo del professionista».
Quanto sopra chiarito, serve, altresì, a spiegare per quale ragione, mentre per la denuncia è legittimo prevedere delle ipotesi in cui anche il privato è obbligato a denunciare, legate alla gravità dei reati, altrettanto non può farsi per le deroghe al dovere di testimoniare, che non sono soggette a contaminazioni sostanzialistiche, essendo, come si è detto, l’attenzione del legislatore portata al rapporto e non all’oggetto del segreto.
Ed infatti, la tutela prescinde dalla circostanza che la notizia sia oggettivamente segreta e che la stessa sia riferita al dichiarante ovvero ad un terzo; quel che rileva è che si tratti di un fatto riferito ed appreso nel contesto ed a ragione di quel rapporto qualificato. A tale riguardo, risulta di particolare rilievo quanto disposto dall’art. 4 n. 4 della legge 121/1985 (Accordi di Villa Madama), laddove la deroga copre tutte le informazioni delle quali gli ecclesiastici sono venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
Quanto sopra detto, trova molteplici conferme nella disciplina che il legislatore ha previsto a protezione della inviolabilità del rapporto. Innanzitutto, si considerino tutte quelle disposizioni che pongono una vera e propria barriera all’attività investigativa ovvero delle particolari cautele e formalità, presidiate da una tutela giurisdizionale rafforzate (si pensi alle perquisizioni presso gli studi dei difensori).
Altro significativo presidio è quello che interviene sulla prova acquisita per effetto dell’illegittima invasione nell’ambito sottratto all’attività investigativa: si pensi all’art. 271 comma 2 c.p.p. in tema di intercettazioni o ancora all’art. 195 co. 6 per i terzi che vengano a conoscenza di fatti coperti da segreto dai titolari del dovere o, infine, all’art. 256 c.p.p., quanto alla documentazione proveniente dal rapporto ministeriale.
Inoltre, merita di essere richiamato anche il presidio posto mediante la previsione della sanzione penale nei confronti di coloro, che essendovi legalmente obbligati, violano il dovere di segretezza.
Infine, non è senza rilievo ricordare che il segreto ministeriale e quello confessionale sono protetti dal diritto internazionale mediante l’art. 73.3 delle Rules of Procedure ed Evidence (2002), che danno applicazione al Trattato di Roma e dal codice di procedura civile, all’art. 249.
- Presupposti e condizioni della deroga
Trattandosi di una sfera di immunità investigativa che incide su un principio costituzionale che è quello della obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, il legislatore ha ben definito i confini di tali deroghe al dovere di testimoniare.
In primo luogo, viene in rilievo proprio il rapporto nel cui ambito è stata riferita la notizia la cui propalazione è interdetta alla pubblica autorità.
L’art. 200 c.p.p., come art. 271 co. 2, c.p.p. pongono come condizione che la notizia sia stata appresa «in ragione del ministero, ufficio o professione».
Non basta, perciò, un rapporto di occasionalità, ma occorre un nesso di causalità: è necessario, cioè, che quella notizia, quel fatto, sia stato riferito a quella persona in quanto munita di quella veste o di quello status, e nell’ambito del rapporto che si è originato per la necessità o quasi necessità di rivolgersi appunto a quel ministro.
In secondo luogo, viene in rilievo la qualifica soggettiva e la funzione svolta (ministri di confessioni religiose, etc.), ovvero l’essere legittimamente inserito nell’ordine professionale corrispondente.
In terzo luogo, è indispensabile che il segreto professionale sia prevista da una legge, che attribuisca, appunto, a quel soggetto, investito di quella funzione in base all’ordinamento giuridico di riferimento, il diritto di essere esonerato dal dovere di testimoniare.
La disamina delle condizioni e dei presupposti delle deroghe induce, inoltre, a svolgere talune ulteriori considerazioni sulla portata delle deroghe stesse, in qualche modo ancora espressione della ratio e della finalità della tutela.
Tutto quanto sopra osservato, spiega, infatti, per quale ragione sarebbe del tutto irrilevante il consenso eventualmente prestato dal confitente alla rivelazione della notizia data come da segreta; giacché è il destinatario dell’affidamento che l’ordinamento giuridico intende tutelare. È quest’ultimo che è tenuto a valutare se rivelare il segreto ed è sua la facoltà di rendere eventualmente testimonianza laddove ciò possa corrispondere al bene del confitente, superiore a quello assicurato dal mantenimento della barriera all’invasione statale.
- La valutazione del giudice
Il giudice potrà, dunque, chiamare a testimoniare il ministro tenuto al segreto, ma solo al fine di valutare se la stessa intenda avvalersi dell’immunità e se la sua richiesta di esonero sia fondata.
La fondatezza, tuttavia, non può che far riferimento alle condizioni che supportano la ratio dell’immunità.
Vi sono, infatti, degli aspetti insindacabili da parte del giudice: in primo luogo, l’iniziativa, cioè la decisione se avvalersi o meno dell’immunità, spetta al titolare della stessa; in secondo luogo, l’interpretazione della portata del “ministero”, ovverosia cosa debba ritenersi rientrare nel ministero e cosa no, sulla base dell’ordinamento giuridico di riferimento.
Gravi sono i rischi connessi ad un’interpretazione riduzionistica della giurisprudenza, connessa alla pretesa di entrare nell’ordinamento di riferimento e misurare l’estensione e la portata del ministero.
E ciò proprio in considerazione della ratio di cui sopra si è discusso; è evidente, infatti, che una riduzione arbitraria della portata del ministero, implica anche una illegittima restrizione del rapporto e, quindi, del diritto e della libertà che si realizzano attraverso la riservatezza attribuita a quel rapporto.
Inoltre, escludere la deroga in ragione della necessità di perseguire determinati reati, per la loro gravità, comporta quella contaminazione sostanzialistica che è quel che deve essere evitato se si vuole tutelare uno spazio di libertà dagli arbitri del legislatore di turno.
- I recenti orientamenti giurisprudenziali
Poste tali premesse, destano non poche perplessità i recenti arresti giurisprudenziali, specialmente con riferimento al rapporto con il ministro religioso.
Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza della Corte di Cassazione nr. 6912 del 14 febbraio 2017, dove i giudici di legittimità, pur dopo aver riconosciuto che «deve ritenersi indubbio» che «l’ambito di segretezza riconosciuto agli ecclesiastici riguardo quanto abbiano conosciuto ‘per ragioni del loro ministero’» «vada ben oltre il concetto di ‘segreto confessionale’», giacché, diversamente opinando, si riserverebbe alla confessione cattolica un trattamento deteriore risetto alle altre confessioni che non conoscono il sigillo sacramentale della confessione, aggiungono, tuttavia, una considerazione demolitiva del principio affermato. Ed infatti, nella sentenza si legge quanto segue: «Ciò, ovviamente, non significa che il segreto possa investire qualsiasi conoscenza dell’ecclesiastico, bensì riguarda solo quella acquisita dell’ambito di attività connesse all’esercizio del ministero religioso. Correttamente, quindi, la Corte di Appello ha ritenuto che si tratti tutelare comportamenti od atti conosciuti dall’ecclesiastico con riferimento all’esercizio di ‘fede religiosa’ e non anche, fra l’altro, nell’ambito di attività ‘sociale’, anch’essa tipicamente svolta dagli ecclesiastici. Ad esempio, l’attività di assistenza a soggetti deboli, pur rientrante nella generica ‘missione’ dell’ecclesiastico (tanto da esistere specifici enti a ciò deputati nell’ambito della religione di appartenenza dei ricorrenti) non rientra certamente nell’esercizio diretto di ‘fede religiosa’».
Ed infine, ancor più chiaramente, conclude: «non può che considerarsi acquisito che parte delle attività erano certamente al di fuori dell’esercizio spirituale».
Al di là dell’oggettiva invasione di campo di stampo squisitamente giurisdizionalista, vi è da chiedersi se, al di là dell’ambito sacramentale, a cosa si riduca la sfera da intendersi ancora sottoposta a tutela, dal momento che i confini vengono individuati all’ambito esclusivamente spirituali o della fede religiosa; qualcuno si è lecitamente chiesto se il segreto riguardi, a questo punto, solo questioni di dottrina.
- Le ragioni di un attacco
L’orientamento sopra esposto costituisce il sintomo di un attacco più generalizzato al segreto ministeriale.
Alcune ragioni sono di ordine generale.
Il segreto viene presentato come opacità da eliminare, in quanto contrastante con il dovere, generalizzato, di trasparenza.
Si dimentica, tuttavia, che la trasparenza è un dovere delle autorità pubbliche, non del privato.
Vi è poi la declinazione della riservatezza come privacy, intesa in senso squisitamente soggettivistico, e non come riferita ad una relazione, men che meno avente rilievo pubblico.
Sul punto, appare utile ricordare ‒ come è stato acutamente scritto in una non remota sentenza ‒ che «la tutela del segreto ministeriale non si esaurisce nella garanzia della privacy, ma appare evidentemente collegata all’esercizio del diritto alla libertà religiosa, qualificato dall’espletamento del ministero religioso» (Tribunale di Teramo, sentenza nr. 2436 del 7.3.2016).
Altre ragioni attengono alla sfera dei rapporti con la religione e in particolare con la dimensione pubblica della religione.
Si tende a negare, di principio, che la religione possa avere una rilevanza giuridica pubblica, in qualche modo concorrente o limitativa delle prerogative statuali.
Si tratta di un riduzionismo pneumatico che trova una sua veste culturale nel ritenere la Chiesa e le confessioni religiose debbano spogliarsi di ogni orpello temporale anche per meglio svolgere la loro funzione che va relegata in un ambito esclusivamente spirituale.
Si distingue una funzione sociale, per la quale non vi è differenza rispetto alle altre organizzazioni disciplinate dal diritto civile, da una funzione religiosa.
Altro profilo rilevante attiene alla peculiarità di talune fattispecie di reato, in particolare l’abuso sessuale sui minori.
In tale ambito, si registra un pregiudizio di fondo e cioè che per tali reati l’immunità dal testimoniare costituisca una agevolazione al crimine, essendo, inoltre, la causale ritenuta strettamente connessa all’educazione cioè alla cultura dominante in ambito ecclesiastico.
Non è un caso se incominciano a registrarsi molteplici iniziative legislative dirette all’abolizione del segreto ministeriale, ed in particolare di quello sacramentale; l’ultima, in ordine di tempo, si è avuta in California, nel luglio 2019.
- Rimedi discutibili
Se così stanno le cose, non sembra prudente da parte ecclesiastica aprire a modifiche del diritto canonico che introducano obblighi di denunzia. È chiaro, infatti, che un tale obbligo annullerebbe totalmente ogni deroga al dovere di testimoniare.
Neppure è consigliabile limitare la deroga al solo ambito sacramentale della confessione, essendo evidente che l’ampiezza della tutela accordata al ministero rappresenta l’antemurale della difesa del sigillo sacramentale; si giungerebbe, inoltre, ad accordare una tutela inferiore al ministro cattolico rispetto a quello delle altre confessioni religiose.
Mi riferisco, in particolare, alle recenti normative emanate dapprima dal legislatore vaticano (Legge CCXCVII, Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, 26.3.2019) e poi da quello canonico.
In particolare, nel motu proprio “Vos estis lux mundi”, del 7.5.2019, si è sancito l’obbligo di segnalazione di alcuni delitti contro il sesto comandamento del Decalogo, specificamente indicati siccome attinenti ad atti sessuali ottenuti con violenza o minaccia ovvero con minori.
Diviene, poi, rilevante sul piano disciplinare, l’aver eluso le indagini civili: una condotta non troppo tassativamente determinata ‒ come è stato autorevolmente notato (G. Boni) ‒ e nella quale parrebbe poter rientrare anche il non aver cooperato con i magistrati. Inoltre, un’obbligazione morale di informare l’autorità ecclesiastica è ingiunta nelle Linee guida per la protezione dei minori, sottoscritte dal Papa il 26.3.2019, seguite dalle linee guida analoghe impartite dalla CEI il 24.6.2019.
Al di là delle lodevoli intenzioni che muovono tali iniziative, resta il fatto che si tratta di atti che vanno oggettivamente ad innovare il diritto canonico, soprattutto se poste in relazione con il novellato canone 1371 par. 6, che stabilisce che chi omette la comunicazione di un delitto, alla quale sia obbligato per legge canonica, sia punito a norma del canone 1336 parr. 2-4.
La perplessità è che, con tale nuovo assetto normativo, si offra al giudice penale uno strumento importante per scardinare in radice la tutela del segreto ministeriale ed in prospettiva dello stesso sigillo sacramentale, poco disposto ad operare tanti distinguo fra obbligazione morale e obbligo giuridico.
Vi è, inoltre, da considerare che, ponendosi il segreto come deroga al generale dovere di rendere testimonianza, l’interpretazione dell’ambito di esenzione non può che essere restrittivo; e l’interpretazione riduzionistica finisce con il ricevere sostegno da novelle normative di segno restrittivo che interessano l’ordinamento giuridico dove quel diritto viene conformato.
Quel che più conta è che si pone il ministro in una situazione difficile, nella quale cioè il rischio che quest’ultimo si preoccupi delle conseguenze disciplinari e penali cui può andare incontro per effetto di eventuali omissioni informative, piuttosto che compiere quel libero discernimento circa la sussistenza di una giusta causa che lo induca alla rivelazione, alla luce del bonum commune, inclusivi di quello delle persone e della loro insopprimibile dignità.
- Una colpa di appartenenza
Si fa facendo strada che, soprattutto nell’ambito degli abusi sessuali in pregiudizio di minori, si è dinanzi ad una responsabilità da posizione, una colpa di appartenenza.
La vicenda del card. George Pell è eloquente; egli è stato condannato per essere il rappresentante di un’istituzione ritenuta pregiudizialmente portatrice di una colpa sistemica.
Nel rapporto elaborato dalla Commissione francese (“Ciase”), si legge che gli abusi segnalano un malfunzionamento di alcuni snodi centrali della vita ecclesiale e la necessità di alcune riforme: la revisione della teologia del ministero, il celibato sacerdotale e il segreto della confessione.
Il modo peggiore per reagire è affrontare la questione come se fosse materia confessionale.
Non è questione religiosa, ma laica: è una questione di libertà religiosa, cioè di libertà di coscienza, il sacrario della libertà.
- Quali gli scenari futuri
Si è fatto sopra riferimento al giurisdizionalismo con riferimento al recente orientamento della Corte di Cassazione.
Si tratta della pretesa dello Stato di ius dicere, di stabilire le regole anche per la vita interna della Chiesa.
In realtà, il quadro è oggi molto diverso.
Non siamo dinanzi all’invadenza di uno Stato che cerca di estendere le proprie prerogative annullando le legittime autonomie delle altre istituzioni, ivi compresa la Chiesa. Il contesto attuale è quello, invece, di uno Stato sempre più spogliato delle sue attribuzioni in favore di soggetti sovranazionali.
Siamo al cospetto di un giurisdizionalismo vero nomine, ovvero di una pretesa esercitata non dallo Stato che si fa giudice in munere alieno, ma della giurisdizione che pretende di farsi Stato, e stato assoluto.
Il governo dei giudici non è frutto ‒ solo ‒ del protagonismo dei magistrati; esso è frutto della delega dell’etica pubblica alla funzione giudiziaria.
Sul punto, così si è espresso il Procuratore Generale Gianfranco Ciani, all’inaugurazione dell’anno giudiziario, nel 2014, richiamando e facendo propria un’autorevole dottrina (Donini): «Archiviate le ideologie, insomma, le scelte etiche condivise sono solo quelle sancite dal diritto penale: per censurare una condotta occorre qualificarla come reato, ‘mancando altrimenti un sistema di valori davvero eloquente e condiviso’ e ciò comporta dunque che ‘si passi immediatamente da ciò che è reato a ciò che è lecito in quanto non delitto’, come se non vi fosse alcuna terra di mezzo, alcuna etica non giuridica (…) Da ciò una serie di intuibili fenomeni degenerativi: la mancanza di valori autonomi di etica socio-politica comporta che è solo il delitto a stabilire il lecito (vale a dire: ciò che delitto non è); tutto ciò che non è penalmente illecito è, per ciò stesso, intrinsecamente corretto e, dunque, la sfera della responsabilità morale (collettiva, individuale) coincide esattamente con quella della responsabilità penale. (…) Se, insomma, il giudice penale diviene metronomo assoluto dei comportamenti esigibili sul piano etico dai consociati e se l’apparato sanzionatorio penale diviene l’unica tabella di valori per i comportamenti pubblici, allora i riflettori accesi dalla collettività sulla giustizia penale sono accecanti: non si ammettono ombre e neppure chiaroscuri (…): non solo la rilevanza dei comportamenti antisociali è affidata alla giustizia penale, ma l’intero collante sociale, rappresentato dal senso civico comune, è appaltato alla giurisdizione penale. (…) L’effetto precipuo ed immediato di tale aspettativa è quello di una progressiva centralità della giurisdizione. La magistratura – ha osservato qualche tempo fa il Presidente emerito della Corte costituzionale, Gaetano Silvestri – è da tempo uscita dal terreno del controllo, che è quello ad essa congeniale e proprio, per addentrarsi in quello della mediazione e della regolazione del conflitto sociale. Il diritto giurisprudenziale è preminente nella composizione delle più svariate problematiche sociali, assai più di quanto lo sia la stessa legislazione. Esso diviene la pietra di volta sulla quale poggia l’intera aspettativa sociale, non solo per affermare i valori essenziali di convivenza, ma soprattutto per garantirne l’attuazione: ci si attende molto di più da una sentenza che da una (nuova) legge e si pensa al controllo della giurisdizione penale quale forma unica di controllo e poi di sanzione, senza neppure immaginare forme alternative, di tipo preventivo o successivo, al di fuori del circuito penale».
In assenza di una morale condivisa, in definitiva, il codice penale è la nuova tavola mosaica, ed i giudici sono i nuovi sacerdoti della legge: come è possibile tollerare isole di immunità? Come si possono giustificare zone sottratte al loro intervento, se su di essi riposa un’attesa salvifica?
Siamo al cospetto di un totalitarismo dal volto buono, quello incarnato dalla toga e dal volto rassicurante del giudice (come preconizzato da Nicolas Gomez Davila), che stabilisce quale debba essere il migliore interesse di ciascuno.
Il compito dei giuristi diventa allora centrale. Riportare il diritto alle sue radici di giustizia, è l’imperativo morale di chiunque abbia ricevuto dei talenti da spendere su questo terreno.
Questo è l’obiettivo che si è dato il Centro Studi Rosario Livatino.
«Diritto e fede o, se vogliamo, giustizia (intesa come ‘frutto’ ultimo del diritto) e fede sono in continuo rapporto fra loro» (così Rosario Livatino in “Fede e diritto”).
Se questo è lo scenario, il diritto canonico è chiamato a tornare alle sue origini, a riscoprire la ragione per il quale è nato: difendere la libertà di ogni uomo.
Perché se non c’è libertà, non può esserci neppure nuova evangelizzazione.
«Molti di noi ambiscono a una vita tranquilla, alcuni non riescono a conseguirla, ciascuno deve scegliere da che parte stare. Non si può evitare di combattere» (George Pell).