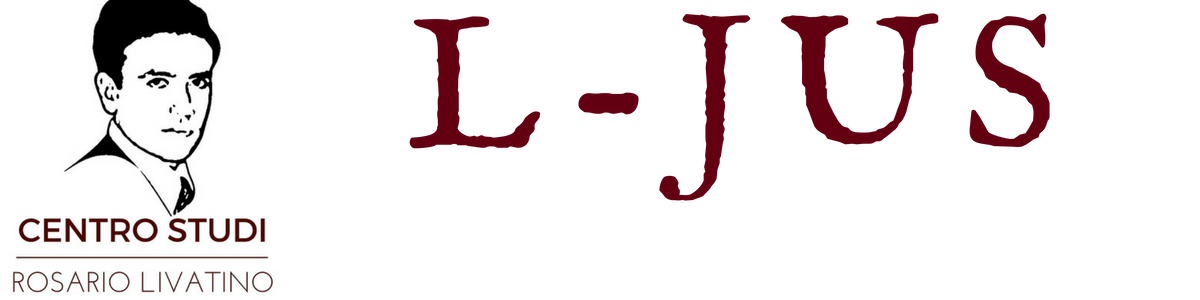Angelo Contrino
Avvocato e Professore Ordinario di Diritto tributario, Università Bocconi di Milano
Francesco Farri
Avvocato e Professore Associato di Diritto Finanziario, Università degli Studi di Genova
Angelo Salvi
Avvocato in Roma
Sommario: 1. Introduzione: sul bisogno storico di una riforma della giustizia tributaria in Italia – 2. La professionalizzazione del giudice tributario di merito: la creazione di una nuova magistratura speciale – 3. La limitata e incompiuta riforma della “Cassazione tributaria” – 4. Le correlate riforme del processo tributario: l’introduzione della testimonianza – 5. La regola speciale sull’onere della prova – 6. Le modifiche in tema di mediazione e conciliazione – 7. La definizione delle liti pendenti in Cassazione.
- Introduzione: sul bisogno storico di una riforma della giustizia tributaria in Italia
Fin dall’unità d’Italia gli organi investiti di competenza a conoscere le controversie tributarie, chiamati “Commissioni Tributarie”, hanno dato vita a vere e proprie eccezioni rispetto al sistema giurisdizionale nel suo complesso, e rispetto al sistema di giustizia nei confronti degli atti della pubblica amministrazione in particolare. Sfuggite alla generalizzata abolizione dei tribunali del contenzioso amministrativo degli Stati preunitari, realizzata con la storica legge n. 2248/1865 allegato E, per effetto della clausola di salvezza contenuta nell’art. 12 di essa, le Commissioni Tributarie hanno passato indenne anche l’introduzione della Costituzione repubblicana, per effetto della lettura conservativa che la Corte Costituzionale ha offerto della VI disposizione finale, nel senso che i giudici speciali preesistenti non dovessero essere necessariamente aboliti, ma semplicemente riorganizzati.
Tale riorganizzazione naturalmente non avvenne, al punto che alcune pronunce della Corte Costituzionale hanno addirittura negato alle Commissioni tributarie il carattere di veri e propri giudici, ciò che avrebbe privato l’intero comparto tributario della presenza di un giudice in senso tecnico, facendo tornare la situazione di questa branca dei rapporti con la pubblica amministrazione alla condizione preunitaria, e comunque anteriore all’istituzione della Quarte Sezione del Consiglio di Stato nel 1889, quando il rapporto tra il cittadino e l’amministrazione non poteva essere conosciuto da un giudice terzo e imparziale, ma soltanto da organi interni alla stessa amministrazione. Essendo stata ritenuta sufficiente una miniriforma (quella di cui al d.P.R. n. 636/1972 e, poi, al d.lgs. n. 545/1992) per riabilitare le Commissioni come giudici speciali, esse si sono conservate sostanzialmente indenni con le loro radici nei sistemi preunitari.
Ciò ha comportato che, fino a oggi, le controversie aventi ad oggetto la legittimità e la fondatezza degli atti impositivi non sono state decise nei gradi di merito da giudici pienamente indipendenti e imparziali, quanto meno nella percezione esterna, trattandosi di giudici non professionali, cioè che svolgono l’attività essenzialmente nel tempo libero da altri impegni, e incardinati in una struttura organizzativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Considerato che la maggior parte delle controversie tributarie riguarda proprio rapporti di debito-credito di cui è titolare il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite la gestione dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, è immediato avvedersi del cortocircuito che da decenni si ingenera: le cause tributarie sono state decise da un giudice incardinato nella struttura organizzativa di una delle parti in causa. Ovviamente, si sono adottati accorgimenti per tamponare la situazione, come il rafforzamento del ruolo del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e la progressiva riduzione del ruolo del Ministro, ma è evidente il vulnus al principio dell’indipendenza, sicuramente quella percepita, che tale situazione si presta a generare.
Ciò si è tradotto da anni – come ammesso in recenti convegni da taluni giudici tributari di lungo corso e con posizioni apicali in senso all’organo di autogoverno – in una eccessiva attenzione della giustizia tributaria verso le istanze provenienti dall’amministrazione finanziaria. La circostanza, poi, che giudici tributari potessero essere nominati anche persone che nella vita svolgono l’attività di PM ha acuito tale tendenza, per i possibili condizionamenti “professionali” derivanti dalla particolare funzione svolta. Per converso, la circostanza che giudici tributari potessero essere nominati anche geometri, ingegneri, periti agrari, architetti ha contribuito a ridurre la qualità giuridica delle decisioni, moltiplicando il contenzioso pendente nel grado di legittimità.
La mancanza di giudici tributari professionali di merito ha generato, altresì, la conseguenza che in Cassazione la materia tributaria sia trattata da magistrati, stavolta professionali, ma che nella vita giudicante si erano nella maggior parte dei casi trovati a trattare tutt’altre materie ed erano privi di esperienza specifica in materia tributaria, con la conseguenza che anche nel grado supremo la qualità delle decisioni non è stata sempre impeccabile. Il che ha comportato, specie negli ultimi anni di clima di guerra all’evasione, una forma di deferenza che si è talora manifestata, anche da parte loro, verso le istanze provenienti dall’amministrazione finanziaria, ma in quanto parte, in questa prospettiva, dello stesso Stato cui appartengono i medesimi magistrati di legittimità, ponendo sovente su un gradino superiore l’interesse fiscale rispetto ai diritti dei contribuenti.
In definitiva, si possono ricondurre a tre gruppi i profili dell’ordinamento della giustizia tributaria che richiedevano (e richiedono) un urgente intervento: l’introduzione di magistrati tributari professionali e a tempo pieno, al posto dei giudici tributari onorari; la possibilità per i magistrati tributari di accedere agli organici della Corte di Cassazione, in modo da costituire una sezione specializzata in materia tributaria che non sia tale soltanto nel nomen (come l’attuale Quinta Sezione Civile) ma anche nella competenza dei giudici; la recisione del cordone ombelicale che lega gli organi di giustizia tributaria a una delle parti in causa e, quindi, l’incardinamento degli organi della giustizia tributaria, non più nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanza, bensì in quello del Ministero della Giustizia, come i Tribunali ordinari, o quanto meno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al pari degli altri giudici speciali come TAR e Corte dei Conti. A questi aspetti strutturali, tra quelli più urgentemente bisognevoli di riforma si aggiunge uno di carattere processuale, ossia il superamento di un ormai incomprensibile divieto di assunzione di testimonianze da parte del giudice tributario.
La legge n. 130/2022 ha affrontato unicamente il primo e gli ultimi di tali aspetti, oltre ad alcuni altri di contorno, ma ha totalmente trascurato di misurarsi con gli altri due. Essa ha finalmente introdotto la figura del giudice tributario professionale a tempo pieno, selezionato per concorso al pari degli altri magistrati di carriera, ma non ha tranciato il legame col Ministero dell’Economia e delle Finanze, anzi addirittura rafforzandoli, e non ha posto le basi affinché in Cassazione si occupino di tributi giudici realmente esperti della materia. Le Commissioni Tributarie, così, cambiano nome, divenendo Corti di Giustizia Tributaria, ma non cambiano natura: non vengono risolti né i denunciati e oramai da tutti riconosciuti problemi di indipendenza e imparzialità percepita della giustizia tributaria, né i problemi attinenti alla composizione dei collegi giudicanti nel supremo grado di giudizio.
Si è di fronte a una riforma che coloro i quali hanno a cuore la giustizia in Italia non possono che salutare con soddisfazione per gli aspetti che ha affrontato, ma che è risultata timida e incompiuta, per non aver affrontato altri aspetti altrettanto urgenti e centrali che affliggono la struttura della giustizia tributaria.
L’occasione di approvazione di questa riforma, inoltre, richiede di compiere alcune riflessioni. La prima è che, se lo vuole, il Parlamento Italiano riesce a funzionare e ad approvare riforme anche senza bisogno di ricorrere allo strumento, ormai immancabile, della delega al Governo.
La seconda è che in materia tributaria i rapporti di forza tra Parlamento e Governo sono ancora sbilanciati a favore del secondo. Secoli di riserva di legge in materia tributaria, a partire dalla Magna Charta Libertatum, non sono bastati né a rompere gli indugi delle burocrazie fiscali ad accettare la giurisdizione come ogni altra pubblica autorità, né a far sì che il Parlamento liberasse il sistema da vecchi privilegia fisci (il giudice tributario incardinato nello stesso Ministero titolare del credito tributario) senza aver prima ottenuto il placet dell’amministrazione finanziaria stessa. Invece, il Parlamento dovrebbe tornare a svolgere il proprio ruolo di garante dei cittadini contro gli ingiusti privilegi dell’amministrazione.
La terza riflessione si collega al fatto che la spinta all’approvazione di questa riforma, che comunque come si è detto risolve alcuni, ma purtroppo non tutti, i problemi più annosi della giustizia tributaria, è giunta dall’attesa dei fondi del Recovery Fund Europeo. Tra le riforme che l’Italia doveva approvare in tempi rapidi per godere di una importante tranche dei fondi europei vi era, appunto, quella volta a migliorare la giustizia tributaria, e questa è stata la molla che ha convinto un Governo ormai dimissionario ad accelerare i tempi e un Parlamento ormai sciolto ad approvare una legge di riforma quanto meno con un giudice tributario professionale di carriera.
Tutto ciò non rende grande onore alla gestione dei rapporti fisco-contribuenti che siamo stati in grado di garantire in Italia negli ultimi anni. In uno dei pochi ambiti della politica economica rimasto di pertinenza degli Stati, soltanto l’intervento europeo ha fatto muovere (almeno in parte) in quella giusta direzione che le istituzioni nazionali ben avrebbero potuto percorrere da sole, come da decenni i tributaristi richiedono. Così non è stato perché, specialmente dagli anni della crisi del debito del 2011, si è rafforzata smisuratamente – anche stavolta per stimolo europeo, a testimoniare una sorta di subalternità delle politiche nazionali pure in materia fiscale – la componente di strumenti di lotta all’evasione, senza porre adeguata attenzione alla garanzia dei contribuenti. Dove si sono recepiti istituti di garanzia del contribuente, come il contraddittorio preaccertativo, lo si è fatto in una prospettiva – quella della definizione “transattiva” della pendenza – a tutto vantaggio del fisco.
In questo modo il sistema tributario rischia di risultare sbilanciato, come un corpo tutto muscoli e niente (poche) difese immunitarie: se nell’immediato l’approccio muscolare può produrre dei risultati, a regime occorre un riposizionamento dell’equilibrio, per evitare disarmonie che a lungo andare danneggiano il corpo sociale.
Il rapporto fisco-contribuenti, infatti, è al cuore del vivere civile ed è particolarmente delicato per la legittimazione delle istituzioni: così, il giusto contrasto a chi omette di compiere il proprio dovere di solidarietà nei confronti della collettività deve sempre svolgersi nel pieno rispetto delle garanzie e dei diritti che si deve a ogni amministrato, per evitare l’ingenerarsi di conseguenze controproducenti, di cui la storia della fiscalità è assai ricca.
Soltanto un rapporto tributario socialmente percepito come giusto ed equo è in grado di garantire, al di là della minaccia della sanzione, quell’adesione sociale spontanea agli obblighi di contribuzione che è alla base del vivere civile delle società evolute, e può garantire quell’afflusso delle risorse necessarie per far fronte alle pubbliche spese che la rincorsa poliziesca all’evasione mai riuscirà a raggiungere stabilmente.
Vi è bisogno, adesso, di recuperare serenità nei rapporti tra fisco e contribuenti. Il che non vuol dire rilassamento nel contrasto all’evasione e alle frodi, bensì, sul piano sostanziale, definizione di un livello di contribuzione tributaria giusto ed equo per l’attuale contesto storico-sociale e per il difficile equilibrio che esso richiede nei rapporti tra necessaria spesa pubblica e necessaria disponibilità economica dei contribuenti, e sul piano procedurale definizione di un giusto equilibrio tra poteri dell’amministrazione e diritti dei contribuenti. E vi è bisogno che nel recupero della serenità nei rapporti tra fisco e contribuenti le istituzionali nazionali ritrovino quel ruolo di guida che il diritto riconosce loro, ma che negli ultimi anni è obiettivamente mancato.
L’auspicio è quindi che la legge n. 130/2022 non sia un punto d’arrivo circoscritto al fine di godere una tranche di fondi del Recovery Fund europeo, ma il preludio di una nuova stagione di garantismo nei rapporti tra fisco e contribuenti: nuova stagione che dovrà comprendere non soltanto il compimento della riforma della giustizia tributaria, rendendo autonomo il giudice tributario dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e aprendo gli organici della sezione tributaria della Cassazione ai magistrati provenienti dalla giustizia tributaria di merito, ma anche una molteplicità di altri aspetti sostanziali e procedurali che non possono, ormai, essere procrastinati.
Si passano in rassegna, nei paragrafi successivi, i dettagli delle norme contenute nella l. n. 130/2022, evidenziandone pregi e difetti e prospettive di miglioramento. Si esamineranno, dapprima, gli aspetti relativi alla riforma degli organi deputati alla risoluzione delle liti in materia tributaria e, successivamente, gli aspetti relativi alla riforma di alcuni aspetti delle regole del processo applicabile alle controversie tributarie.
- La professionalizzazione del giudice tributario di merito: la creazione di una nuova magistratura speciale
Il progressivo dilatarsi del debito pubblico nazionale e gli eventi socio-politici che al crepuscolo del ventesimo secolo portarono alla fine della “Prima Repubblica” sono solo alcuni dei fattori che hanno nell’ultimo ventennio contribuito a far sì che il tema del contrasto all’evasione divenisse centrale nel nostro paese, nella prospettiva di permettere all’Italia di allinearsi a (almeno in teoria) più virtuosi modelli provenienti dal Nord dell’Unione, che avrebbero dovuto permettere alla “Seconda Repubblica” di tenere sotto controllo il proprio debito, colpendo con il pugno di ferro i cattivi costumi degli italiani nel pubblico (la corruzione) e nel privato (l’evasione) e, dunque, in ultima istanza avrebbe dovuto permettere alla “Seconda Repubblica” di evitare di tradursi in una “seconda Prima Repubblica”.
Nel discorso tenuto durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario del 26/27 febbraio 2018, l’allora Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, Giovanni Mammone, aveva sottolineato la centralità della materia tributaria, non più materia di nicchia ma di «estrema importanza, in termini di risorse, per la collettività».
Nel 2018, d’altronde, era già chiaro a tutti quanto il sistema di giustizia tributaria – della cui “innaturale” longevità si è già detto nel precedente paragrafo – fosse obsoleto e inadeguato a fornire risposte in quei termini di trasparenza e competenza sui quali convergono i contrapposti interessi di definitivo accertamento e riscossione delle imposte da parte dell’Amministrazione finanziaria e di garanzia dei diritti da parte dei contribuenti, che poi si traducono anche nella esigenza di programmazione e pianificazione da parte di imprese, chiamate a operare in un mercato globale sempre più aperto e concorrenziale.
Inefficienze che si affiancavano a quei «limiti strutturali derivanti dall’origine amministrativa della giurisdizione tributaria» che avevano reso «lungo e difficile l’avvicinamento dell’attuale impianto processuale tributario al modello del giusto processo, così come positivizzato all’art. 111, 1° e 2° comma, della Costituzione e come già prima sostenuto dal diritto europeo (che all’art. 6 della CEDU statuisce il diritto all’equo processo)»[1].
Nel corso di quasi trent’anni di vigenza dei decreti legislativi nn. 545 e 546 del 31 dicembre 1992, che avevano riformato l’assetto della giustizia tributaria agli inizi degli anni Novanta, si erano manifestate diverse criticità strutturali e applicative, tra le quali centrale era la questione della non assoluta terzietà e indipendenza del giudice tributario, o comunque della sua non assoluta percepibilità come tale da parte dei contribuente, posto che esso costituiva (e costituisce) istituzione giudiziaria incardinata sotto l’egida del Ministero dell’economia e delle finanze, ovverosia del soggetto titolare della maggior parte dei crediti della cui legittimità si discuteva innanzi le commissioni tributarie.
Il tempo, inoltre, aveva reso evidente la fragilità di una magistratura tributaria composta per lo più da giudici onorari, dunque reclutati su chiamata e non per pubblico concorso, e non a tempo pieno, dunque dediti anche ad altre attività giudiziarie, requirenti o professionali, i cui provvedimenti molto spesso non superavano la prova di resistenza del giudice di legittimità, contribuendo a sovraccaricare di lavoro la stessa sezione tributaria della Corte di Cassazione.
Per la verità, in passato il legislatore aveva provato a intervenire per sopperire – almeno in parte – a dette criticità, da ultimo attraverso la mini riforma operata con il decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015, che aveva però interessato essenzialmente il processo tributario e, nella prospettiva di deflazionare il contenzioso, aveva esteso l’ambito di applicazione dell’istituto della mediazione tributaria a tutte le controversie di valore non superiore ad € 20.000,00 (ora € 50.000,00) e introdotto la possibilità di conciliare la lite anche successivamente al primo grado.
Istituti la cui efficacia ultima era pur sempre rimessa alla concreta predisposizione dell’Amministrazione finanziaria a porsi nella prospettiva – tracciata a suo tempo da Enrico Allorio – di organo “giustiziale”, che «in quanto prima destinataria della legge tributaria, deve farne applicazione tenendo ben presente che essa agisce non solo in qualità di “parte” del rapporto tributario, ma anche, in base ai principi costituzionali, quale organo di giustizia»[2].
In tema di ordinamento della giurisdizione tributaria, invece, si erano registrati alcuni tentativi di riforma, fra cui la proposta di legge del 23 novembre 2017, a firma del deputato Palese, ove era stata prospettata la possibilità di una magistratura tributaria come “quarta magistratura” (accanto all’ordinaria, la amministrativa e contabile), a tempo pieno e professionalmente competente, e la costituzione di un tribunale tributario monocratico cui attribuire le controversie di minore consistenza economica.
Il documento era risultato stimolante anche per la riflessione sul principio di proporzionalità del giudicato – che la relazione accompagnatoria alla proposta di legge in questione espressamente menzionava, laddove richiamava i principali istituti del sistema processuale tributario tedesco, e – che si concretizza in quel principio «atto a calibrare l’azione della giustizia tributaria alle effettive circostanze economiche e sostanziali in cui si è venuto a creare il contenzioso». Certo, avrebbe dovuto essere verificata la tenuta di una tale ipotesi di riforma, poiché «l’assetto “pluralistico” del potere giudiziario è attualmente predeterminato dalla Costituzione e il mutamento di tale assetto può aver luogo solo con legge costituzionale»[3].
Per quanto con i limiti già accennati nel precedente paragrafo 1, la Legge 21 agosto 2022 n. 130 interviene sul decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, con una riforma importante, che realizza finalmente il passaggio a una magistratura tributaria professionale composta da giudici a tempo pieno e professionali, assunti per concorso: «La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento» (così il nuovo art. 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. e, della Legge 21 agosto 2022 n. 130).
Il primo aspetto su cui porre l’attenzione è comunque la scelta del legislatore di mantenere in vita una autonoma giurisdizione speciale tributaria; questa non era, come noto, l’unica soluzione possibile, perché il medesimo scopo di realizzare una professionalizzazione del giudice tributario avrebbe potuto essere perseguito anche attraverso la devoluzione della materia tributaria alla cognizione del giudice ordinario, ivi strutturando una sezione specializzata tributaria. Maggiori difficoltà avrebbe, invece, presentato l’attribuzione della materia tributaria alla cognizione del giudice amministrativo[4] o di quello contabile, anche in considerazione del quadro costituzionale risultante dall’interpretazione della VI disposizione finale della Costituzione, che non recepisce espressamente la giurisdizione tributaria ma la tollera semplicemente[5].
Un soluzione – quella adottata dal legislatore – che appare ragionevole e che consente anche di realizzare una più armonica migrazione da una giurisdizione integralmente affidata a giudici onorari, come è quella attuale, a una che invece dovrà essere di quasi esclusiva competenza di magistrati “togati”. Questa migrazione è operata dal legislatore mediante il nuovo art. 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, secondo cui «la giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all’ articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022»; il che significa che questi ultimi giudici «attualmente in organico eserciteranno pertanto le proprie attribuzioni sino al completamento della loro carriera, accompagnando la giurisdizione tributaria verso l’esercizio esclusivo da parte di magistrati tributari professionali a tempo pieno, assunti tramite concorso pubblico, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dagli artt. da 4 a 4-quater del d. lgs. n. 545 del 1992, come disposti dalle lettere c) e d) del comma in esame»[6].
Il documento di sintesi sulla riforma tributaria, reperibile sul sito della Camera dei deputati, spiega che «per conseguire l’obiettivo previsto dal PNRR, i Ministri della giustizia e dell’economia hanno dapprima insediato una commissione di studio chiamata a proporre al Governo un disegno di riforma della giustizia tributaria (c.d. Commissione Della Cananea), che ha presentato le proprie proposte, e successivamente, il 1° giugno 2022, hanno presentato in Senato il disegno di legge A.S. 2636, Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. Dopo le modifiche apportate dal Senato, il provvedimento (A.C. 3703) è stato approvato definitivamente dalla Camera.
La legge n. 130 del 2022, anzitutto persegue la razionalizzazione del sistema della giustizia tributaria attraverso la professionalizzazione del giudice di merito, con la previsione della figura del magistrato tributario professionale, e apporta le conseguenti, modifiche alle norme che disciplinano il reclutamento, la nomina alle funzioni direttive e le progressioni in carriera dei componenti delle commissioni tributarie. La legge, intervenendo sul decreto legislativo n. 545 del 1992, modifica inoltre la denominazione delle commissioni tributarie in corti di giustizia tributaria (di primo e secondo grado) e stabilisce che la giurisdizione tributaria è esercitata dai nuovi magistrati tributari a tempo pieno, reclutati mediante procedure concorsuali appositamente disciplinate». La suddetta professionalizzazione del giudice tributario di merito viene, dunque, realizzata attraverso il reclutamento per concorso.
Al di là di alcune osservazioni critiche sulle materie previste nelle prove selettive disciplinate dal nuovo art. 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545 e sui requisiti per l’ammissione al concorso di cui al successivo art. 4-bis, in buona parte comunque superate nella stesura definitiva dei predetti articoli[7], va detto che il passaggio da una magistratura onoraria a una magistratura professionale non poteva prescindere dall’introduzione di una procedura selettiva di stampo concorsuale, articolata in prove volte a verificare competenze e capacità dei candidati, in quanto non v’è dubbio che «la nomina a seguito di concorso è individuata come elemento socialmente legittimante per garantire ai cittadini la competenza del giudice (art. 106 Cost.)»[8].
Il vero punctum dolens della riforma è rappresentato dal fatto che il concorso viene affidato al Ministero dell’economia e delle finanze, sotto la cui egida resta sostanzialmente incardinata la nuova magistratura tributaria, con toni anzi addirittura accentuati rispetto all’assetto precedente.
A chi da tempo provocatoriamente sostiene che è più facile «che un cammello passi per la cruna di un ago che il ministero delle Finanze rinunci al dominio che ha sulla vita delle Commissioni tributarie»[9], si sono affiancate autorevoli voci di dottrina che hanno evidenziato il rischio che le nuove corti di giustizia tributaria nascano “dimidiate”, in quanto non dotate della necessaria indipendenza, con buona pace per quanto previsto dall’art. 108 della Costituzione.
L’argomento è stato peraltro di recente valorizzato da Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, Sez. I, ordinanza 31 ottobre 2022 n. 408, che ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, prospettando la questione nei termini che seguono: «3.1) L’effetto di accentuazione del rapporto di dipendenza dei giudici tributari dal Ministero Economia e Finanze, titolare sostanziale dell’interesse oggetto delle controversie tributarie, determinato dall’entrata in vigore della Legge novellatrice n. 130 del 2022, in ingravescente contrasto con i principi costituzionalmente garantiti dell’indipendenza e dell’imparzialità dei giudici rispetto all’assetto normativo preesistente, che già appariva idoneo a pregiudicare la garanzia dei ridetti fondamentali principi in materia di giurisdizione.
Si tratta, in specie dei principi dettati non solo dagli artt. 101; 104, 105 e 110 della Carta (“I giudici sono soggetti soltanto alla legge”; “La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere”; “Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”; “….spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”), in combinato disposto con l’art.108 della Carta (“La legge assicura l’ indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali”), ma anche dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848 così come interpretato ed applicato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) in tema di “equo processo”, norma -quest’ultima- che funge da disciplina interposta ai fini della valutazione della conformità a Costituzione della legge ordinaria nazionale, per effetto del rinvio contenuto nell’art.117 Cost. (in termini Corte Cost. 24.10.2007 n.348 e Corte Cost. 11.3.2011 n.80).
In quest’ultima ottica, non può non menzionarsi Corte CEDU 10.1.2012, Pohoskal v. Poland, secondo la quale l’indipendenza del giudicante va valutata da una prospettiva “obiettiva”, alla luce della disciplina che ne prevede le modalità di selezione e che stabilisce le regole di protezione contro le pressioni esterne; nel mentre l’imparzialità del giudicante medesimo va verificata in prospettiva “soggettiva” ‒ quasi come espressione della psicologia individuale del giudicante ‒ onde acclarare se (indipendentemente da una concreta sussistenza di pregiudizio) sia garantita al giudicante la consapevolezza dell’assenza di condizionamenti esterni.
Il coacervo di queste disposizioni di rango costituzionale ha consentito al Giudice delle leggi di esprimere (sentenza n.284 del 1986) quel principio generalmente applicabile a tutti i giudici latamente intesi (della cui violazione qui appunto si dubita) secondo il quale “L’indipendenza del giudice consiste nell’autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette, ovvero indirette provenienti dall’autorità di governo o da qualsiasi altro soggetto; essa concerne non solo l’ordine giudiziario nel suo complesso (art. 104 Cost.) ma anche i singoli organi, ordinari (art. 107) e speciali (art. 108), al fine di assicurare che l’attività giurisdizionale, nelle varie articolazioni, come la sua intrinseca essenza esige, sia esercitata senza inammissibili influenze esterne. Anche se concettualmente distinta, l’indipendenza ha ricorrenti e stretti legami con l’imparzialità …”».
In buona sostanza, secondo la Corte di giustizia di Venezia «l’inquadramento della organizzazione giudiziaria tributaria all’interno di un apparato che della medesima organizzazione giudiziaria ‒ in concreto ‒ si serve per la realizzazione di fini suoi propri appare a questa Corte giudicante istituzionalmente in conflitto con i principi di autonomia e indipendenza che devono permeare non solo la sostanza della funzione giurisdizionale ma anche la sua apparenza nei confronti dei consociati, i quali hanno il diritto di non dover temere che il giudice innanzi al quale si presentano sia pregiudizialmente schierato a favore di una delle parti del processo».
Il tema è e resta dunque di estrema attualità, per quanto secondo alcuni sia argomento più di forma che di sostanza, in quanto la riforma ha comunque previsto che «ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalità di cui all’articolo 4, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili» (nuovo art. 13-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545); l’equiparazione dei magistrati tributari a quelli ordinari sotto il profilo retributivo viene ritenuto infatti un fondamentale passo avanti verso l’effettiva indipendenza del giudice tributario[10].
Rispetto al tema dell’indipendenza va considerato poi anche il ruolo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Dice Antonio Leone, che lo presiede: «convintamente evidenzio la necessità di prevedere nella riforma della giustizia tributaria ora in discussione un rafforzamento del ruolo del Cpgt a tutela dell’autonomia e indipendenza dei giudici tributari. L’indipendenza del giudice nell’esercizio delle sue funzioni deve essere assicurata dalla legge anche ai giudici speciali come indicato dall’articolo 108, secondo comma della Costituzione. Nel dibattito sulla riforma della giustizia tributaria molti hanno sostenuto la necessità di una netta separazione tra le commissioni tributarie ed il Mef. Questa separazione non sarà necessaria se il Cpgt verrà messo nelle condizioni di svolgere la fondamentale sua funzione di assicurare l’autonomia e l’indipendenza dei giudici tributari, anche solo apparente. In buona sostanza l’organo di autogoverno deve fungere da schermo – barriera invalicabile – tra i giudici ed il Mef. Per raggiungere questo scopo si dovrà istituire una sezione disciplinare e un ufficio ispettivo che possa periodicamente verificare l’andamento delle Commissioni tributarie dislocate sul territorio»[11].
Chi ritiene marginale la questione del MEF nel quadro complessivo della riforma, valuta positivamente il fatto che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria esca indubbiamente rafforzato dall’intervento legislativo in commento, in quanto – tra l’altro – delibera il numero dei posti di volta in volta messi a concorso (art. 4-ter) e la Commissione di concorso (art. 4-quater). Insomma, secondo costoro «non corrispondono al vero quindi le affermazioni secondo le quali i nuovi magistrati saranno reclutati sotto il controllo del Ministero dell’Economia. Al MEF, ma non potrebbe essere diversamente, è devoluta esclusivamente la gestione organizzativa delle procedure di selezione (affitto locali, PC, front office per l’accesso dei candidati, pagamento dei compensi dei commissari d’esame), il tutto secondo un modello che è identico a quello previsto per il reclutamento dei magistrati ordinari (in cui il CSM delibera sui posti da mettere a concorso e il Ministero della Giustizia ratifica con decreto quanto stabilito dall’organo di autogoverno)»[12].
La questione è certamente aperta, ma in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, si possono prospettare alcune prime considerazioni di sintesi.
La riforma segna senza dubbio un significativo passo avanti, riconoscendo sin d’ora al giudice tributario una autonomia e indipendenza quantomeno sostanziali, «nella prospettiva – inevitabile nel lungo periodo, almeno a Costituzione vigente – di assorbimento nella giurisdizione ordinaria, segnatamente nelle forme dell’istituzione ai sensi dell’art. 102 Cost. di una sezione specializzata apposita per la materia tributaria»[13]. L’assetto ordinamentale tratteggiato dalla riforma non necessariamente deve essere ritenuto definitivo (come peraltro non lo è quello delineato da nessuna legge) e può senz’altro essere migliorato con un’opera di labor limae che tenga conto delle pertinenti osservazioni mosse da quella parte di dottrina e dalla giurisprudenza secondo cui l’indipendenza del giudice, oltre che esistere, deve anche apparire ed essere percepita come tale di fronte al corpo sociale e che, a ragione, individua un vulnus nel ruolo che la Legge 21 agosto 2022 n. 130 ha tuttora riservato al Ministero dell’economia e delle finanze. Un primo passo comunque andava fatto e, al netto delle critiche, anche importanti, di cui occorrerà farsi carico, il saldo provvisorio di questo aspetto della riforma può considerarsi positivo.
In prospettiva futura, invece, rimangono indubbiamente centrali le criticità evidenziate, da ultimo, dalla Corte di Venezia. La circostanza che un giudice sia “dipendente” e controllato da una delle parti in causa determina una percezione del tutto insoddisfacente della sua indipendenza e imparzialità. Se si pensa, poi, che tra le prerogative del MEF rientrano anche – in base all’art. 12, comma 5, lett. c) e d) del d.P.C.M. n. 103/2019 ‒ quelle di provvedere alla rilevazione statistica sull’andamento dei processi nonché sul valore economico delle controversie avviate e definite, effettuare il monitoraggio sull’andamento delle spese di giustizia riferite al contenzioso tributario e le previsioni del gettito, rilevare ed esaminare le questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza, predisporre provvedimenti e atti per l’attuazione delle norme in materia contenzioso tributario e delle relative spese di giustizia e per la loro interpretazione, curare la predisposizione dei provvedimenti relativi al personale giudicante; attività dunque nelle quali il singolo giudice può facilmente essere monitorato per nome, cognome e risultati in termini di “previsioni di gettito”, si comprende come le perplessità sull’effettiva appropriatezza del sistema vadano ben oltre il mero idealismo.
- La limitata e incompiuta riforma della “Cassazione tributaria”
Diversamente da quanto avviene per le decisioni degli altri giudici speciali previsti dalla Costituzione, come in particolare il sistema TAR-Consiglio di Stato e la Corte di Conti, avverso le decisioni del giudice speciale tributario il ricorso in cassazione non è e continuerà a non essere limitato alle questioni di giurisdizione ai sensi dell’art. 111, ultimo comma Cost., ma può esplicarsi per tutti i motivi di cui all’art. 360 c.p.c.
Ciò significa che una parte dei giudici di Cassazione dovranno conoscere a perfezione il diritto tributario, poiché a loro, e non ai giudici speciali, toccherà di svolgere la fondamentale funzione nomofilattica in materia.
In questo quadro, sarebbe del tutto fisiologico, oltre che strettamente indispensabile, che fosse favorita la creazione in seno alla Corte di Cassazione di una sezione specializzata all’interno della quale far confluire anche i magistrati tributari di merito che abbiano raggiunto la maturazione d’esperienza e capacità necessaria per accedere ai ranghi del supremo collegio.
Eppure, sul punto, la legge 130/2022 non ha manifestato cenni di apertura sostanziali.
Invero, non appaiono risolutive in proposito le novità introdotte dall’art. 3: esso provvede, sì, a formalizzare l’istituzione di una sezione specializzata tributaria presso la Corte di Cassazione, avvalendosi della possibilità consentita dall’art. 102, comma 2, secondo periodo Cost., ma niente dispone in merito al suo organico e al suo funzionamento, demandando integralmente le decisioni in materia al Primo Presidente della Corte di Cassazione, peraltro senza fornire alcun criterio e direttiva di massima in materia e, così, ponendo pure dubbi circa l’effettiva soddisfazione della riserva di legge di cui all’art. 108, comma 1 Cost.
In mancanza di un intervento espresso sulla legge dell’ordinamento giudiziario, si deve quindi ritenere che l’accesso alla Cassazione sia precluso ai giudici non appartenenti al plesso della magistratura ordinaria, come saranno quelli tributari, pur sempre qualificati come speciali, tranne ovviamente il caso eccezionale e come tale da considerarsi asistematico dei meriti insigni (art. 106, comma 3 Cost.; legge n. 303/1998).
In tale prospettiva, peraltro, non si può fare a meno di rilevare come, in futuro, appaia inevitabile una evoluzione nel senso di consentire l’accesso alla sezione specializzata tributari della Cassazione di magistrati tributari di merito che abbiano maturato pertinenti profili di esperienza e professionalità. Si produrrebbe, altrimenti, l’illogica situazione in cui a decidere nel supremo grado le controversie in una certa materia sarebbero giudici che mai di quella materia si sono professionalmente occupati. Infatti, con la riforma dell’ordinamento dei giudici tributari, sarà in futuro precluso ai magistrati ordinari di svolgere anche la funzione di giudice tributario di merito, sicché si disperderebbe anche quel grado, pur insufficiente, di continuità che attualmente almeno in parte può esistere tra esperienza di esercizio in materia tributaria delle funzioni giudicanti di merito e di legittimità. Non appare sufficiente, in tale prospettiva, che tra i compiti del Primo Presidente l’art. 3 preveda anche quello di favorire «l’acquisizione di una specifica competenza» da parte dei magistrati assegnati alla sezione specializzata tributaria, poiché appare evidente che le competenze per svolgere funzioni giudicanti di legittimità in una materia complessa com’è quella tributaria non si possono acquisire unicamente sui libri o mediante corsi di formazione, ma richiedono una esperienza operativa approfondita sul campo. Né appare incompatibile con la Costituzione il fatto che possano accedere al supremo organo giudiziario del plesso ordinario magistrati di provenienza di plessi giurisdizionali speciali, come sarà a pieno titolo quello tributario per effetto della riforma. Invero, ciò non avviene per i giudici amministrativi e contabili poiché come si è rilevato per le controversie assegnati alla loro giurisdizione la Corte di Cassazione non svolge il ruolo di nomofilachia, posto che – come noto – le sentenze amministrative e contabili non sono soggette al controllo della Cassazione se non per le questioni di giurisdizione (art. 111, ultimo comma Cost.): non si manifesta, dunque, quell’esigenza di maturazione di specifiche esperienze giudicanti dei magistrati di Cassazione che, invece, si è detto essere indispensabili per il tributario nel momento in cui si assoggettano le decisioni del giudice tributario a un controllo pieno di legittimità da parte della Cassazione.
Con l’entrata in funzione a pieno regime della nuova magistratura tributaria, pertanto, risulterà naturale aprire i ranghi della sezione specializzata tributaria della Corte di Cassazione anche e almeno in parte a magistrati di provenienza del plesso giudiziario tributario.
Sarà sufficiente, al riguardo, una modifica legislativa, posto che la riserva di legge di cui all’art. 108 Cost. non assegna specifici contenuti di merito alla normativa in materia di ordinamento giudizio, lasciando in ciò ampia discrezionalità al legislatore, negli ovvi limiti della ragionevolezza, che in questa prospettiva appaiono pienamente rispettati, e posto che le clausole dell’art. 106 Cost. valgono semplicemente a derogare la regola del concorso per l’accesso in magistratura, ma non anche a delimitare i casi in cui, senza derogare a criteri selettivi di carattere concorsuale, possano accedere alla Corte di legittimità anche magistrati provenienti da plessi giudiziari diversi da quello ordinario.
In questa prospettiva, forse, potrebbe già risultare concepibile un intervento in sede di attuazione della delega alla riforma dell’ordinamento giudiziario contenuta nella l. n. 71/2022, che prevede la necessità di interventi di riforma sui criteri d’accesso dei giudici alla Corte di Cassazione e, quindi, proprio sulle norme che richiederebbe la (minima) modifica suddetta per aprire i ranghi della neo-istituita sezione specializzata tributaria anche ai magistrati tributari, quanto meno per costituire almeno in un prima fase una sezione specializzata a composizione mista di magistrati ordinari e magistrati specializzati.
- Le correlate riforme del processo tributario: l’introduzione della testimonianza
Accanto alle riforme attinenti al versante organizzativo della giustizia tributaria, che si sono sopra esaminate, il legislatore della riforma è intervenuto anche sul testo del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, contenente la disciplina del processo tributario[14].
In questo ambito, una delle disposizioni di maggior interesse, in vigore dal 16 settembre 2022, è l’art. 4 co. 3 lett. c) della legge in commento, mediante il quale viene novellato l’art. 7 co. 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, ovverosia la norma processuale che disciplina i poteri delle commissioni tributarie, ora ribattezzate corti di giustizia tributaria.
Il testo previgente della disposizione menzionata stabiliva che nel processo tributario «non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale», in ossequio a quella concezione per cui tale processo avrebbe natura sostanzialmente documentale[15], secondo una impostazione che lascia trasparire una certa diffidenza verso la prova testimoniale, radicata nell’assunto per cui il testimone avrebbe maggiormente a cuore le sorti del privato rispetto all’interesse erariale.
La sostanziale assenza di prove costituendae ha peraltro consentito al sistema processuale tributario di caratterizzarsi per una particolare velocità, in aperta controtendenza con le altre giurisdizioni, che da sempre soffrono del morbo atavico dell’irragionevole durata. D’altro canto però alla speditezza di processi tributari – di solito il primo grado si esaurisce entro un anno dalla proposizione del ricorso introduttivo, e un altro anno è necessario per l’appello – ha spesso fatto da contraltare la non particolare qualità della media delle sentenze rese dai giudici tributari di merito, confermata dall’elevato numero di ricorsi in Cassazione, peraltro favorito anche dal fatto che una delle parti in causa dispone gratuitamente dei servizi legali ed è quindi incentivata a ricorrere contro ogni tipo di decisione a sé sfavorevole, così moltiplicando il numero dei ricorsi pendenti davanti alla sezione tributaria della Cassazione.
Inoltre, l’approccio formalistico legato a un’istruttoria quasi esclusivamente documentale ha in molti casi giustificato le doglianze dei contribuenti che lamentavano il sacrificio delle regole del giusto processo (enunciate in Costituzione e nelle fonti sovranazionali) sull’altare dell’interesse erariale.
Tali rimostranze sono state alimentate nel tempo dal progressivo consolidarsi nella materia processual-tributaria di uno schema impugnatorio per cui, salvo il caso dei ricorsi contro il silenzio rifiuto in materia di rimborsi, attore in senso formale è il contribuente che impugna l’atto impositivo, ma attore in senso sostanziale è l’amministrazione finanziaria, come tale onerata di fornire nel giudizio la prova delle circostanze di fatto che sostengono le contestazioni di maggior imponibile, le riprese a tassazione di minori costi, e via dicendo.
Questo schema teorico di fondo in punto di onere della prova è stato tuttavia alterato nel corso degli anni dal sempre maggiore ricorso da parte dell’amministrazione finanziaria allo strumento delle presunzioni, previste in maniera massiccia nella normativa di riferimento, ad esempio nel d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Ne consegue il ribaltamento dei carichi probatori, col contribuente onerato di offrire al giudice la prova contraria rispetto a quanto contestato dalla parte pubblica nell’avviso di accertamento per effetto del massivo utilizzo di presunzioni semplici o, addirittura, semplicissime, di cui si dirà nel paragrafo successivo.
In questo contesto il divieto della prova testimoniale costituiva una limitazione di non poco conto per l’attività difensiva del contribuente, difficilmente conciliabile anche con la previsione di cui all’art. 2729 co. 2, cod. civ., secondo il quale «le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni». Va peraltro dato conto del fatto che «la giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che contro la limitazione probatoria in esame non si può invocare neppure la irragionevole disparità di trattamento rispetto al giudizio civile. L’inesistenza di un principio costituzionalmente garantito di necessaria uniformità delle regole tra i diversi tipi di processo può condurre ad una differenziazione degli ordinamenti processuali secondo le scelte operate dal legislatore che rientrano nella sua discrezionalità in quanto non manifestamente arbitrarie (in argomento Corte cost. 12 gennaio 2000, n. 18)»[16].
Altro dato rilevante è che secondo la giurisprudenza l’esclusione della prova testimoniale non comporta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei terzi riprodotte nei processi verbali della Guardia di Finanza o dell’amministrazione finanziaria, anche se non rese in contraddittorio con il contribuente. Le dichiarazioni di terzi entrano quindi nel processo tributario, ma in maniera asimmetrica, in concreto sempre a supporto della pretesa dell’ente impositore.
Queste dichiarazioni rese dai terzi anche non in contraddittorio con il contribuente – inserite nel processo verbale di constatazione e recepite nell’avviso di accertamento – hanno valore meramente indiziario e possono assurgere a fonte di prova presuntiva, concorrendo a formare il convincimento del giudice.
Per questo la Corte di Cassazione si è preoccupata di riequilibrare almeno in parte i rapporti tra ente impositore e contribuente «affermando che, nel processo tributario, il potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale – con il valore probatorio proprio degli elementi indiziari – va riconosciuto non solo all’amministrazione finanziaria, ma anche al contribuente, dovendosi dare attuazione ai principi del giusto processo, come riformulati nel nuovo testo dell’art. 111 Cost., e garantire il principio della parità delle armi processuali nonché l’effettività del diritto di difesa»[17].
Si è così giunti ad ammettere la produzione da parte del contribuente di dichiarazioni rese da terzi nella forma dell’atto notorio, con il medesimo valore indiziario attribuito alle dichiarazioni rese in sede extraprocessuale e raccolte nel processo verbale di costatazione e nell’avviso di accertamento.
Di fatto, tuttavia, la giurisprudenza risulta particolarmente restia nel valutare le dichiarazioni di terzi presentate dai contribuenti a sostegno delle proprie difese.
La Legge 21 agosto 2022 n. 130 riscrive il testo dell’art. 7 co. 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che – per effetto della novella – oggi stabilisce quanto segue: «Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale».
Il Dossier elaborato dai Servizi Studi di Camera e Senato e pubblicato lo scorso 6 agosto 2022 commenta la norma come segue: «La lett. c) del comma 1, nel confermare l’inammissibilità del giuramento, consente l’assunzione della testimonianza in sede processuale quando la Corte di giustizia tributaria di primo grado lo ritenga necessario ai fini della decisione anche in mancanza di accordo tra le parti. La prova testimoniale deve essere assunta nelle forme della testimonianza scritta, di cui all’art. 257-bis del codice di procedura civile».
A una prima lettura sembrerebbe che la prova testimoniale sia ora ammessa nel processo tributario, con due specifiche limitazioni: una sostanziale, dovendo il giudice ritenere la testimonianza necessaria ai fini del decidere (almeno potenzialmente, visto che si tratta di una valutazione che il giudice deve condurre ex ante); l’altra formale, essendo ammessa solo nella forma scritta ex art. 257-bis cod. proc. civ., anche in assenza dell’accordo tra le parti. Sarebbe proprio questa la principale innovazione rispetto alla prova scritta prevista nel processo civile, e in concreto rarissimamente utilizzata, proprio perché subordinata al necessario accordo delle parti sul punto. La mancata previsione di tale limite dovrebbe rendere lo strumento molto più fruibile nella sede processuale tributaria.
Secondo tale interpretazione si tratterebbe in ogni caso di un intervento legislativo minimale, tale da consentire l’introduzione nel processo tributario di una dichiarazione scritta che – in quanto resa nelle forme dell’art. 257-bis cod. proc. civ. – avrebbe valore probatorio e non semplicemente indiziario, senza con ciò alterare la struttura del processo disciplinato nel decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, e presumibilmente senza minarne la comprovata celerità.
Tuttavia, e in attesa di registrare i primi interventi giurisprudenziali su una norma processuale che è già in vigore dallo scorso 16 settembre 2022, l’esegesi ora prospettata sembra non essere l’unica possibile; al contrario, vi è chi in dottrina, muovendo dall’autonomia lessicale del primo periodo del nuovo art. 7 co. 4 (ove è scomparso l’espresso divieto di prova testimoniale), ritiene che la novella abbia reso ammissibile nel processo tributario non solo la prova testimoniale scritta ma anche quella orale[18]. Ciò per effetto della riespansione delle regole generali contenute nel codice di procedura civile agli art. 244 e ss.
Come noto, infatti, i giudici tributari «applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile» (art. 1 co. 2 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546) e il codice di procedura civile consente l’assunzione della prova testimoniale sia nella forma orale (generale) che scritta (nel solo caso di accordo delle parti sul punto).
Secondo tale esegesi, il citato primo periodo del nuovo art. 7 co. 4 godrebbe di sostanziale autonomia; conseguentemente, il successivo secondo periodo non conterrebbe i limiti generali entro i quali è ammessa la prova testimoniale nel processo tributario, ma più semplicemente i limiti entro i quali in detto processo è ammessa la testimonianza scritta (diversi da quelli stabiliti per il processo civile dall’art. 257-bis cod. proc. civ.)[19], senza tuttavia intaccare la generale ammissibilità della prova testimoniale orale, in conseguenza del venir meno dell’espresso divieto in precedenza contenuto nel previgente testo della norma novellata e del generale rinvio alle norme del codice di procedura civile, di cui al richiamato art. 1 co. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
Secondo questa interpretazione, la nuova prova testimoniale – sia essa scritta o orale – sconterebbe poi in ogni caso il limite di cui al terzo periodo dell’art. 7 co. 4 («Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale»).
Un’esegesi di questo tipo, pur autorizzata dal dato testuale, avrebbe evidentemente effetti dirompenti sul sistema processuale tributario. Potrebbe incidere, è vero, sulla durata del processo, i cui tempi si allungherebbero inevitabilmente per la necessità di assumente la prova orale; definirebbe, però, un sistema processuale sicuramente più garantista per il contribuente, cui sarebbe attribuita – almeno in alcune tipologie di contenziosi – un’importante arma di difesa, da utilizzare nell’interesse proprio, ma più in generale nell’interesse collettivo alla “giusta imposizione”.
Va peraltro tenuto presente che tale interpretazione sembra andare oltre l’intenzione espressa del legislatore, di cui comunque si deve ancora una volta evidenziare il ricorso a una tecnica di redazione del testo di legge non particolarmente brillante per chiarezza e immediatezza di comprensione.
- La regola speciale sull’onere della prova
Accanto alla sopra esaminata modifica relativa ai mezzi di prova, la Legge 21 agosto 2022 n. 130 ha anche introdotto nell’art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 un nuovo comma 5-bis del seguente tenore: «l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati» (v., in proposito, art. 6 Legge 21 agosto 2022 n. 130).
La norma non sembra raccogliere i favori della critica; le prime voci di dottrina sono, infatti, assai severe nei riguardi del legislatore, vuoi perché «questa innovazione legislativa suona del tutto inaspettata – non si trova, difatti, riferimento alcuno ad essa nella relazione parlamentare – e quindi assai poco meditata»[20], vuoi perché «questa è una norma che non doveva essere scritta – se effettivamente si fosse voluto codificare un principio di questo genere – non andava scritta nella normativa processuale, andava scritta forse nella normativa sull’accertamento, forse nello statuto dei diritti del contribuente, quella sarebbe stata una sua corretta collocazione. Ma soprattutto questa è una norma di carattere generale: cosa vuol dire? Le norme contenute nella disciplina sull’accertamento e nelle singole leggi d’imposta essendo norme di tipo speciale prevalgono su questa»[21].
In sintesi, la dottrina denuncia la sostanziale afasia di una norma tanto pomposa, quanto apparentemente priva di consistenza dal punto di vista effettuale.
Proviamo a esaminare più nel dettaglio la questione. Si è già detto nel precedente par. 4 che, in punto strettamente teorico, alla struttura impugnatoria del processo tributario consegue che attore in senso sostanziale è l’amministrazione finanziaria, come tale onerata di fornire nel giudizio la prova delle circostanze di fatto che sostengono le contestazioni di maggior imponibile, le riprese a tassazione di minori costi, e via dicendo.
Questo schema teorico è tuttavia alterato attraverso il sempre maggiore ricorso da parte dell’amministrazione finanziaria allo strumento delle presunzioni, previste in maniera massiccia nella normativa di riferimento, a partire dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ulteriormente accresciute nella prassi amministrativa e giurisprudenziale delle presunzioni semplici.
In buona sostanza, nel rapporto tra Fisco e contribuente, quando le dinamiche fuoriescono dal fisiologico e si incanalano nel binario del contezioso, bisogna fare i conti con il fatto che l’amministrazione finanziaria può quasi sempre valersi delle cc.dd. “prove per induzione”, ovverosia di «quei mezzi di prova che consistono essenzialmente in una inferenza che muove da determinate premesse, rappresentate da enunciati relativi a circostanze di fatto, per giungere – sulla base di idonei criteri – alla formulazione di conclusioni relative alla verità o alla falsità di un diverso enunciato relativo ad un fatto della causa»[22].
Le presunzioni (semplici, a volte addirittura semplicissime), sono lo strumento attraverso il quale il legislatore vuole riequilibrare la situazione di asimmetria informativa tipica del processo tributario, nel quale il contribuente ha immediata, “naturale” disponibilità dei fatti di causa (in quanto inerenti a situazioni che lo riguardano direttamente), e la parte pubblica il non semplice compito di ricostruirli, laddove intenda contestare quanto dichiarato (o omesso di dichiarare) dal contribuente medesimo.
Così, attraverso il meccanismo presuntivo, si semplifica l’onere della prova gravante sull’amministrazione finanziaria, rendendo sufficiente la prova dell’esistenza di alcuni fatti per poter inferire l’esistenza di altri, e contestualmente se ne ribalta una parte – sub specie di prova contraria – a carico del contribuente, talora sul presupposto dell’applicabilità del criterio di c.d. prossimità della prova.
Tutto ciò dovrebbe trovare limiti precisi e vincolanti, quali ad esempio il principio di non accollare al contribuente probationes diabolicae e di non dar corso a cc.dd. praesuntiones de praesumpto: «si afferma tradizionalmente che praesumptum de praesumpto non admittitur, limitando quindi l’impiego delle presunzioni semplici ai casi nei quali il fatto noto è dimostrato con prove diverse dalle presunzioni o è percepito direttamente dal giudice, ed escludendo le “presunzioni di secondo grado”»[23]. Ab esse ad posse valet illatio, secondo un noto brocardo.
Il tema è assai delicato. L’equilibrio che governa il riparto dei carichi probatori tra le parti del processo tributario, come di qualsiasi altro processo, è spesso determinante, perché il giudice dovrebbe decidere la controversia dichiarando soccombente la parte che non sia stata in grado di dimostrare la sussistenza del fatto costituivo del diritto vantato.
In materia tributaria, in tutti quei casi in cui l’attività di accertamento è assistita da presunzioni, grava sul contribuente l’onere della prova contraria e quindi grava sul contribuente il rischio di non riuscire a raccogliere – nella sede processuale – il materiale sufficiente a convincere il giudice circa la effettiva sussistenza del fatto contrario che è onerato di dimostrare.
Un carico che non appare sempre idoneo a garantire sufficientemente criteri di giustizia, poiché spesso troppo gravoso e insidioso.
Gravoso, perché il processo tributario è sostanzialmente un processo documentale, stante il limite all’assunzione di prove costituende e, in particolare, della prova testimoniale[24].
Insidioso, perché le inferenze cui le singole leggi d’imposta attribuiscono giuridica rilevanza «appartengono proprio a quel tipo che sappiamo essere il più insidioso per il senso comune: il ragionamento probabilistico»[25] (si pensi, per fare alcuni esempi, agli accertamenti fondati sul c.d. redditometro, a quelli da studio di settore o ricarico medio di settore, etc.).
In questo contesto, il giudice gioca un ruolo decisivo, in quanto il grado di rigore con cui valuta il compendio probatorio offerto dalle parti determina di fatto l’esito del giudizio.
Se questo è lo scenario, allora, in una prospettiva di attuazione della giusta imposizione, sarebbe certamente auspicabile un intervento normativo che ridefinisse almeno in parte quell’assetto processuale per cui ora molto spesso si ha la percezione che non sia assicurata alle parti del processo tributario quella “parità di armi” che invece dovrebbe essere garantita dall’art. 111 della Costituzione.
In questo contesto, il nuovo comma 5-bis sembra prima facie incidere in modo marginale. Tale norma, infatti, appare scritta per una casistica diversa da quella alla quale si è appena fatto riferimento, atteso che essa si rivolge in positivo a tutte quelle fattispecie in cui l’amministrazione è – in punto di diritto e di fatto – onerata di provare i fatti che pone a fondamento del suo atto di accertamento. In buona sostanza, la norma si riferisce a tutte quelle ipotesi in cui l’azione di accertamento erariale non risulta basata su presunzioni. Per tali ipotesi, la norma ribadisce una conclusione che discende da sempre dai principi generali (art. 2697 c.c.): l’attore in senso sostanziale deve provare i fatti che pone a fondamento della sua domanda giudiziale e lo deve fare in maniera rigorosa, sicché «se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria» o «se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva» il giudice è tenuto a rigettare la domanda (a dichiarare l’infondatezza della pretesa impositiva, nel caso del giudizio tributario)[26].
In relazione ai casi in cui, invece, l’azione impositiva si basa su presunzioni, il tenore letterale della norma in commento non sembra autorizzare la conclusione secondo cui il legislatore avrebbe inciso sul criterio con cui il giudice tributario dovrebbe valutare la prova contraria offerta dal contribuente.
Una tale interpretazione imporrebbe di ritenere che il legislatore, nello scrivere il comma 5-bis, minus dixit quam voluit. Sicché nella ratio della norma si dovrebbe rintracciare una specifica volontà del legislatore della riforma di rimodulare l’equilibrio tra le parti del processo tributario, secondo un’ermeneutica che sembra tuttavia incerta, anche per la collocazione sistematica della norma in commento nella legge processuale (piuttosto che nello Statuto dei diritti del contribuente), che comunque aprirebbe lo scenario a ulteriori riflessioni circa il rapporto tra norma di carattere generale e norme speciali, cui sopra si è già fatto cenno.
In questo senso, la Corte di Cassazione si è affrettata a ribadire il principio per cui «il comma 5 bis dell’art. 7 D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto con l’articolo 6 della L. n. 130 del 2022, ha semplicemente ribadito, in maniera circostanziata, l’onere probatorio gravante in giudizio sull’amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio. Pertanto, la nuova formulazione legislativa non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria un ruolo centrale»[27].
Secondo la Cassazione, dunque, la norma non si applica in tutti quei casi in cui una presunzione inverte l’onere della prova, ponendolo sul contribuente.
Bisogna tener conto, tuttavia, che l’interpretazione di un enunciato normativo non si limita alla semplice lettura testuale, ma richiede sempre una interpretazione sistematica che permetta di coglierne il significato nel contesto complessivo dell’ordinamento.
In questa prospettiva, dall’inserimento all’ultima ora della norma in commento nel testo della riforma tributaria vi è chi – tra i primi e più autorevoli commentatori – ha derivato l’impressione che si tratti del «tentativo in extremis da parte del Legislatore di codificare l’esigenza di limitare un sistema diffusamente improntato all’accertamento presuntivo ed una giurisprudenza di legittimità che prevalentemente interpreta il riparto dell’onere probatorio in senso statisticamente favorevole all’Erario»[28].
Secondo questa impostazione, quindi, la norma potrebbe costituire un importante snodo per riequilibrare gli abusi delle presunzioni fiscali che, negli ultimi anni, sono stati avallati anche da parte della giurisprudenza. Come rilevato da autorevole dottrina: «Il testo del comma 5-bis dell’art. 7 D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dalla L. n. 130/2022 dovrebbe, se correttamente inteso, fare giustizia di tali errori, visto che ribadisce che l’Agenzia deve provare il fondamento della sua pretesa in conformità della disciplina sostanziale. Con ciò ribadendo che a) la prova è oggetto di un giudizio di fatto singolo, per ogni singolo processo, insuscettibile di standardizzazioni; b) la regola dell’onere della prova ha fonte legislativa; c) debbono essere oggetto di prova tutti gli elementi della fattispecie sostanziale (ivi compresa, nell’esempio delle società, la distribuzione, che è il fatto su cui si fonda l’imposizione del socio). Una luce in fondo al tunnel? Si spera non sia il treno che arriva nella direzione opposta»[29].
- Le modifiche in tema di mediazione e conciliazione
Uno dei passaggi più deludenti della riforma tributaria di fine agosto è senz’altro quello che concerne gli strumenti deflattivi del giudizio, in particolare la mediazione.
Introdotta nel testo del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 dall’art. 39, co. 9, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (poi convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111), la mediazione tributaria è oggi disciplinata dall’art. 17-bis del summenzionato decreto, a mente del quale «per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa».
La norma prevede che il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica dello stesso; entro detto termine l’ente impositore esamina i contenuti del ricorso e, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione articolata dal contribuente, formula d’ufficio una propria proposta «avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse».
La finalità deflattiva che aveva indotto il legislatore del 2011 a scrivere una norma di questo tenore, pur apprezzabile in punto teorico, ha però riscontrato in concreto una scarsa applicazione pratica, a causa di manifesti limiti, puntualmente evidenziati dagli operatori.
Una prima ragione di tale insuccesso può risiedere in considerazioni di carattere metagiuridico: in termini generali, gli strumenti risolutivi delle controversie alternativi al contenzioso (c.d. ADR, alternative dispute resolution) hanno da sempre trovato il loro campo d’elezione in quei «rapporti destinati a prolungarsi nel tempo o in cui sono coinvolti soggetti appartenenti alla stessa famiglia, gruppo sociale o area territoriale, per i quali appaiono preferibili soluzioni extragiudiziali che meglio consentono la prosecuzione del rapporto (condominio, locazione, comodato, affitto di azienda, diritti reali, divisione, successioni, patto di famiglia)»[30]. Un aspetto, questo, che contiene in sé un quid di diverso e più profondo rispetto alla semplice chiusura (o prevenzione) della lite: una prospettiva di pacificazione tra soggetti che condividono e continueranno a condividere esperienze di vita all’interno di un medesimo corpo sociale (famiglia, condominio, etc.) e che fa sì che ogni litigante abbia in un certo qual modo interesse a sapere che anche il suo interlocutore ne sta uscendo almeno parzialmente soddisfatto (perché una vera reciproca soddisfazione andrà a beneficio di entrambi, evitando nuovi conflitti futuri).
Questa prospettiva non può essere riprodotta tal quale in altri contesti dove la mancanza di prossimità tra le parti le rende sostanzialmente indifferenti una all’altra, anche se in contatto giuridico-ordinamentale. Si pensi alle controversie in materia di diritto bancario o assicurativo, ambiti nei quali la mediazione è da sempre poco efficace. Lo stesso discorso – mutatis mutandis – può essere riferito ai rapporti di diritto pubblico e, in particolare, al contesto tributario: in questi casi, la mediazione non riesce a penetrare la sostanza dei rapporti, e ciascuna delle parti è mossa da una semplice (quasi statistica) ponderazione dei costi e benefici conseguenti alla possibile definizione anticipata della lite, che cercherà di negoziare nei termini più prossimi alla totale affermazione della propria pretesa.
In ambito tributario, poi, a questa prima considerazione si affiancano ulteriori aspetti di carattere più strettamente tecnico e giuridico, che frenano ancor più le potenzialità dell’approccio media-conciliativo.
Al di là del valore concernente le controversie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità (non superiore a € 50.000,00), vi è da considerare anzitutto che in materia tributaria il reclamo di cui all’art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 segue una fase precontenziosa, nel corso della quale il contribuente ha comunque la possibilità di attivare un’interlocuzione con l’Ufficio, articolando una apposita istanza di annullamento dell’atto in autotutela (art. 2 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997 n. 37), ovvero avviando la procedura di accertamento per adesione (art. 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, che determina peraltro la automatica sospensione del termine di impugnazione dell’atto per la durata di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza).
Se accanto a tali osservazioni si pone poi la nota querelle sul tema dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, ci si rende conto che le argomentazioni sviluppate dal contribuente nel ricorso-reclamo si risolvono molto spesso in una mera riproposizione di elementi già portati all’attenzione della parte pubblica nella fase precontenziosa e valutati dall’Ufficio insufficienti ai fini di una definizione bonaria della vertenza (quantomeno nei termini prospettati dal contribuente).
L’altro grande limite dello strumento deflattivo in commento è stato sin da subito individuato nel fatto che l’iter disciplinato dalla norma de qua non prevede la figura del mediatore, quale soggetto terzo e imparziale, che possa ascoltare le ragioni delle parti ed eventualmente sintetizzare le stesse in un documento di proposta, secondo uno schema non troppo diverso da quello strutturato con il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, istitutivo del procedimento di mediazione e conciliazione in materia civile e commerciale.
La legge 21 agosto 2022 n. 130 non affronta nessuna di queste questioni, intervenendo sulla norma in commento in maniera del tutto marginale, con la sola introduzione del comma 9-bis, ove si prevede che «in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione».
Niente di rilevante, dicevamo, se si considera che il principio per cui le spese seguono la soccombenza, esisteva già sia nel processo civile (v., in proposito, artt. 91 e 92 cod. proc. civ.) che nel processo tributario, ove l’art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 espressamente prevede che «la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza»[31].
Peraltro, l’esperienza concreta dimostra come tale regola sia da sempre applicata con parsimonia dal giudice tributario, soprattutto laddove a soccombere risulti essere la parte pubblica, in virtù di un diffuso quanto ingiustificato favor per quest’ultima, che si traduce molto spesso in compensazioni delle spese di lite o in liquidazioni “simboliche” delle stesse.
L’intenzione manifesta del legislatore della riforma è, ovviamente, quella di sollecitare una effettiva rivalutazione della questione da parte dell’Ufficio preposto a gestire la fase della mediazione, nel tentativo di assicurare concreta – e non solo formale – applicazione all’istituto.
Un’idea che era anche nel previgente testo della norma, laddove già si prevedeva che le Agenzie fiscali (Entrate, Dogane, Monopoli) «provvedono all’esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili» (v., in proposito, art. 17-bis, co. 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546; per gli altri enti impositori tale disposizione «si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa»).
Con la riforma si vuole valorizzare tale profilo, mediante l’espresso richiamo alla responsabilità amministrativa del funzionario che immotivatamente rigetta il reclamo o la proposta di mediazione; anche in tal caso, tuttavia, l’inciso non sembra aggiungere molto, se è vero che già nel Dossier del 6 agosto 2022, elaborato dai Servizi Studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, si era evidenziata «l’opportunità di specificare se questa responsabilità amministrativa si configura come ulteriore rispetto a quella ordinariamente prevista per la mancata motivazione degli atti» (v., in proposito, p. 59 del documento in menzione); precisazione che, tuttavia, manca nel testo definitivo dalla norma.
La sensazione che ci si trovi di fronte a un’occasione persa trova riscontro anche nei primi commenti di dottrina; scrive, ad esempio, Cesare Glendi: «Il Parlamento non ha evidentemente saputo emanciparsi dalla riproduzione maldestramente attivata dall’Amministrazione di ritagliare la funzione deflativa entro il vecchio armamentario della “mediazione tributaria”, ex art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992, che costituiva un vero e proprio retaggio arcaico del contenzioso tributario di stampo amministrativo ed era per di più ridotto a inutile ingombrante doppione dell’accertamento per adesione, anziché disporre l’obbligatorietà, e non la mera facoltatività, della conciliazione nella prima fase del giudizio di primo grado, istituzionalizzandone l’esercizio attraverso l’introduzione all’interno del processo della figura del c.d. giudice di pace tributario, quale componente interno al Collegio del 1° grado per tutte le controversie attualmente reclamabili e magari anche alle controversie c.d. seriali, come quelle catastali, onde allargare significativamente l’ambito delle controversie conciliabili con evidenti vantaggi per una ben organizzata deflazione in limine del contenzioso»[32].
Anche rispetto all’altro istituto oggetto di riforma, la conciliazione giudiziale, la l. n. 130/2022 non opera stravolgimenti, limitandosi a introdurre il nuovo art. 48-bis.1, dedicato alla proposta di conciliazione formulata dalla Corte di giustizia tributaria, che riproduce nella sostanza il modello della proposta di conciliazione del giudice di cui all’art. 185-bis cod. proc. civ.
L’istituto è, ancora una volta, dedicato alle controversie soggette a reclamo ai sensi dell’art. 17-bis; per tale categoria di vertenze, la Corte di giustizia tributaria «ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione»[33].
Anche in tal caso, la proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza e la causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo.
Per una compiuta riflessione sul nuovo art. 48-bis.1 si deve tenere anzitutto a mente che in origine, con l’introduzione della mediazione obbligatoria per le controversie di minor valore (prima non superiore a € 20.000,00, ora non superiore a € 50.000,00), si era esclusa la possibilità per le parti di accedere all’istituto della conciliazione giudiziale di cui all’art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546[34]. Vi era, quindi, una alternatività tra i due istituti, con la mediazione riservata alle controversie di minor valore e la conciliazione giudiziale a tutte le altre vertenze tributarie.
Successivamente, «a seguito delle modifiche introdotte con d.lgs. n. 156 del 2015, la disposizione che imponeva l’alternatività tra reclamo/mediazione e conciliazione non è stata riproposta in ragione dell’esigenza di potenziare gli istituti deflativi sia nella fase anteriore al giudizio sia in pendenza di causa. Ne consegue che le controversie instaurate a seguito di rigetto dell’istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell’accordo di mediazione rientrano nell’ambito di applicabilità della conciliazione, disciplinata dagli artt. 48, 48-bis e 48-ter, d.lgs. n. 546 del 1992, come modificati dal d.lgs. n. 156 del 2015»[35].
Nel contributo ora citato, il Prof. Corasaniti riprende l’affermazione secondo cui, una volta abolita l’esclusione della conciliazione giudiziale nelle controversie soggette alla mediazione tributaria obbligatoria, «quella che ancora pomposamente, ma impropriamente, si pretende di chiamare ‘mediazione tributaria’, realisticamente si configura come nient’altro che un pressoché inutile, ma nocivo, intralcio amministrativistico al normale progredire del processo tributario»[36].
Come si pone il nuovo art. 48-bis.1 rispetto a quest’ultima “contestazione”? Proviamo a rispondere muovendo da una considerazione sostanziale: diversamente da quanto avviene nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 48 e 48-bis, l’istituto di cui all’art. 48-bis.1 prevede che a dare impulso alla fase conciliativa non siano le parti, ma la Corte di giustizia tributaria «avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione».
Ciò implica che il giudice tributario debba necessariamente avere contezza dell’oggetto del giudizio e delle posizioni delle parti rispetto alla questione al medesimo devoluta. In buona sostanza, il giudice che formula la proposta conciliativa deve aver esaminato gli atti di causa, quantomeno sottoponendoli a una sommaria analisi.
Se è così, allora forse sarebbe stato più opportuno prevedere che la proposta di conciliazione fosse stata articolata dalla Corte di giustizia tributaria sempre fuori e prima dell’udienza, entro un ben preciso termine (ad esempio, sei mesi dal deposito del ricorso), al fine di serrare i tempi del giudizio e incalzare le parti, nella prospettiva di realizzare un’economia processuale data anche e soprattutto dal fatto che in caso di conciliazione l’udienza si sarebbe risolta in un mero passaggio formale, per il quale si sarebbe potuto ipotizzare anche il ricorso alla modalità cartolare, già utilizzata durante la pandemia (la Corte infatti avrebbe dovuto dichiarare la semplice cessazione della materia del contendere).
Per contro, così come strutturato dalla legge 21 agosto 2022 n. 130, l’istituto sembra tutt’altro che utile a favorire il raggiungimento dell’obiettivo della ragionevole durata del processo, che rischia di articolarsi in più udienze e dilatarsi nel tempo, essendo giustappunto prevista la possibilità di un rinvio a successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo. Ça va sans dire, viene così alterato in peius il normale progredire del processo tributario proprio con riferimento a quelle controversie di minor valore, che invece dovrebbero fluire spedite.
Riprendo, per concludere, un’ulteriore considerazione sull’inciso «questioni di facile e pronta soluzione» di cui al menzionato art. 48-bis.1. Dice bene Antonio Perrone: «cosa la corte di giustizia tributaria dovrà intendere con quest’ultima espressione? Sebbene, infatti, la formula sia stata tralaticiamente riportata dal rito civile a quello fiscale, essa dovrà certamente essere adattata alle particolarità di quest’ultimo e, prima fra esse, la circostanza che una delle parti è pubblica ed è portatrice della funzione istituzionale di attuare la norma tributaria e di amministrare i tributi.
Invero, le risposte a tali quesiti parrebbero a portata di mano. Facile e pronta soluzione, infatti, altro non dovrebbe significare se non che è chiaro chi abbia ragione e chi torto o che (in diritto) si tratta di una questione che ha una tale sedimentazione giurisprudenziale (magari in un costante orientamento della Corte di cassazione) – da cui il giudice non ravvisa ragioni per discostarsi – che la soluzione della controversia non potrà che ancorarsi alla stessa, o che ancora – ma ci sembra un’ipotesi di difficile fattura – una delle parti abbia ipotizzato l’applicazione di una norma palesemente inconferente con la fattispecie o abbia dato una valutazione palesemente errata di una disposizione. Insomma, la locuzione in esame, nella sua forma letterale, indurrebbe a ritenere che la corte di giustizia tributaria abbia facoltà di formulare la proposta conciliativa quante volte risulti indubbiamente evidente, al di là di ogni dubbio, come la controversia debba essere decisa perché è chiaro dove sta la ragione e dove il torto.
A questo punto, però, l’inevitabile domanda che sorge nella mente dell’interprete è perché mai un giudice, che abbia così chiara contezza su come la controversia debba essere decisa, dovrebbe formulare una proposta conciliativa. Ma soprattutto occorre chiedersi come potrebbe quegli formulare la proposta senza, di fatto, anticipare la sua decisione, così compromettendo quell’imparzialità che non è solo principio di civiltà giuridica ma è anche canone di rilevanza costituzionale (art. 111 Cost.).
Pertanto, se si dovesse attribuire all’inciso facile e pronta soluzione il significato letterale che ha tale espressione, non solo si porrebbe un’evidente questione di legittimità costituzionale della norma, ma si dovrebbe ammettere che il novello istituto della conciliazione del giudice è stato introdotto nel rito fiscale con il solo scopo di scoraggiare liti temerarie, in cui il ricorrente (recte: il suo difensore) è conscio della scarsa probabilità di successo, ma impugna per prender tempo. Un istituto che opererebbe quindi a senso unico e di cui, a mio sommesso avviso, non si sentiva davvero il bisogno»[37].
L’assunto del Prof. Perrone sembra in effetti pertinente, ed è innegabile che la nozione di questione di facile e pronta soluzione stride con quell’aliquid incertum che di solito induce le parti a conciliare la lite, così evitando il rischio di trovarsi a soccombere in sentenza.
Se si considera poi la sufficiente speditezza del processo tributario e – soprattutto – il fatto che, anche in ragione della già richiamata indisponibilità (o comunque delimitata disponibilità) dell’obbligazione tributaria, dal tavolo conciliativo resta fuori ogni valutazione inerente alla solvibilità del contribuente e alle eventuali problematiche legate alla riscossione forzosa dell’imposta su cui si controverte, non si vede proprio quale possa essere la ragione per cui le parti, ricevendo la proposta della Corte di giustizia tributaria in sede d’udienza, debbano conciliare una lite ormai giunta alla soglia della decisione.
- La definizione delle liti pendenti in Cassazione
Alcune considerazioni conclusive meritano di essere svolte relativamente all’art. 5 della legge di riforma della giustizia tributaria, che prevede la possibilità di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione. Si tratta dell’ultima di una lunga serie di definizioni agevolate delle liti che si sono susseguite nella legislazione degli ultimi anni (art. 16 l. n. 289/2002; art. 39, comma 12 del d.l. 98/2011, che alla precedente pressoché integralmente si richiamava; art. 11 del d.l. n. 50/2017; art. 6 del d.l. n. 119/2018).
Trattasi di una normativa che può considerarsi ormai consolidata, ma anche stratificata, e questo reca con sé difetti tralatizi che la prassi sembra avere nel tempo assestato, ma che non sarebbe inopportuno risolvere anche a livello normativo.
Vi è infatti, ad esempio, una differenza strutturale tra le definizioni dell’istituto fornite dal legislatore del 2002 e del 2011, per le quali la formulazione legislativa appare maggiormente curata, e le definizioni di cui alla legge del 2017, meno chiare e quindi anche, giocoforza, potenzialmente più rischiose per i contribuenti. La nuova definizione agevolata di cui all’art. 5 della l. n. 130/2022, per l’appunto, si ispira proprio a quest’ultimo modello di definizioni e, in particolare, richiama da vicino per molti aspetti proprio l’art. 6 del d.l. n. 119/2018.
Si pensi, a titolo esemplificativo, al comma 13 dell’art. 5 l. n. 130/2022 (“La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8”) dove appare priva di significato la clausola di salvezza delle disposizioni del secondo periodo del comma 8, il quale a propria volta recita “Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato”. Tale rinvio poteva avere un senso nel comma 11 dell’art. 11 del d.l. n. 50/2017 (dove si escludevano gli effetti del condono per i coobbligati che avessero avuto sentenza personale negativa passata in giudicato, in conformità ai principi dell’art. 1306 c.c.), ma non in questa sede, dove il rinvio al comma 8 varrebbe a escludere gli effetti del condono per i coobbligati nel caso in cui gli atti siano diversi, ossia nella larga maggioranza dei casi di coobbligazione tributaria. Sennonché, a un più attento esame si nota che questo passaggio del comma 13 dell’art. 5 della l. n. 130/2022 risulta integralmente “copiato” dall’art. 6, comma 14 del d.l. n. 119/2018 e anch’esso conteneva identico errore, tanto che la stessa Agenzia delle Entrate, in sede di circolare illustrativa (circ. n. 6/E/2019, par. 7.1.1.), aveva dovuto correggere il riferimento come se valesse per il comma 9, a sua volta analogo al comma 9 dell’art. 5 della l. n. 130/2022 (secondo cui, per quanto d’interesse, “gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”), anziché per il comma 8. Sarebbe stato opportuno che, in sede di nuova normativa, almeno gli errori più evidenti venissero corretti, ma così non è stato.
Del pari, è stata mantenuta per il comma 12 dell’art. 5 in commento («In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L’impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione») una formulazione analoga a quella del comma 14 dell’art. 6 del d.l. n. 113/2018 che, letta letteralmente, potrebbe condurre a ritenere che le controversie astrattamente condonabili ma che mai il contribuente abbia inteso condonare sarebbero comunque estinte qualora egli non abbia presentato istanza di trattazione entro un certo termine. Ciò che produrrebbe conseguenze abnormi poiché, come noto, con l’estinzione del giudizio tributario al di fuori dei casi di annullamento in autotutela o forme di novazione (tra cui quelle della definizione agevolata) “rivive” l’originaria pretesa impositiva. Solo il coordinamento con i commi precedenti, dove si prevede che il contribuente interessato al condono “possa” (non già “debba”) presentare istanza di sospensione del giudizio, permette una interpretazione razionale, secondo la quale il giudizio si estingue anche al di fuori del perfezionamento del condono solo nel caso in cui il contribuente, che avesse manifestato l’intento di condonare presentando istanza di sospensione del giudizio, ma poi di fatto non abbia condonato o non abbia validamente perfezionato la procedura, non formalizzi poi il suo interesse a proseguire la lite mediante istanza di trattazione. Anche qua, fu la stessa Agenzia delle Entrate a chiarire che il meccanismo dell’estinzione in caso di mancata presentazione di istanza di trattazione valeva soltanto per i giudizi nei quali era stata presentata istanza di sospensione (cfr. circ. n. 6/E/2019), ma non avrebbe guastato prendere atto dell’inadeguatezza della formulazione legislativa e chiarire direttamente in tale sede questo fondamentale aspetto.
Ancora, il comma 9 prevede tout court che «la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa», senza curarsi di far salvi i «casi di soccombenza dell’amministrazione finanziaria dello Stato» come, invece, facevano l’art. 16, comma 5 della l. n. 289/2002 e l’art. 39, comma 12 del d.l. 98/2011. Così, risulterebbe precluso il giudizio d’ottemperanza nel caso in cui il contribuente abbia diritto alla restituzione delle somme pagate a titolo provvisorio e ciò si presta indubbiamente a limitare l’appetibilità della definizione stessa.
La vera particolarità che si rinviene nella “nuova” definizione agevolata introdotta dal legislatore del 2022 consiste nell’ambito applicativo particolarmente ristretto previsto dalla norma in commento. Mentre per le altre ipotesi di definizione agevolata delle liti, via via ideate e normate, la soccombenza dell’amministrazione in alcuni gradi di giudizio non definitivi incideva soltanto sul quantum della definizione (che diminuiva più erano i gradi di soccombenza per l’amministrazione e più avanzato era lo stato del giudizio), in questa occasione la stessa incide anche sull’an. A tenore dell’art. 5 della l. n. 130/2022, infatti, si possono definire in via agevolata soltanto le cause che, non solo pendano esclusivamente in Cassazione e non anche nei gradi di giudizio di merito, ma con l’ulteriore condizione che l’amministrazione sia risultata soccombente in almeno un grado di giudizio di merito precedente e sempre che il valore della controversia sia contenuto entro certo limiti, peraltro abbastanza ridotti.
Ciò conduce a ravvisare la finalità principale di questo nuovo istituto, piuttosto che nel gettito suscettibile di essere ritratto dalla misura condonistica, nel fine di smaltimento del contenzioso tributario pendente presso la Suprema Corte. Ciò, del resto, è espressamente chiarito nella relazione illustrativa al d.d.l. A.S. 2636, poi sfociato nella legge 130/2022, alla pagina 12, dove si afferma la necessità di «incisive disposizioni legislative per la definizione agevolata delle controversie pendenti avanti la sezione specializzata, pur limitandole allo stretto necessario per raggiungere una «soglia critica» di deflazione immediata che consenta, de residuo, l’impostazione di un programma triennale di smaltimento dell’arretrato e di stabilizza zione operativa con ragionevoli probabilità di successo».
Anche il contesto in cui la norma è stata approvata, cioè la riforma della giustizia tributaria, a sua volta collegata al PNRR, fa comprendere come la finalità sia essenzialmente lo smaltimento dell’arretrato. Veniva previsto, infatti, già al par. 1.2.7. della Parte Seconda del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (pag. 68).
È ragionevolmente dubitabile, peraltro, che la nuova disposizione legislativa riesca a ottenere l’obiettivo ricercato, poiché i problemi di pendenza di arretrato anche presso la Suprema Corte sono strutturali e non contingenti, nonostante che la norma in analisi contenga alcuni accorgimenti particolarmente stringenti sull’argomento.
In specie, il comma 15 dell’art. 5 prevede che ciascun ente territoriale «stabilisce» l’applicazione della definizione alle controversie che lo riguardano, il che significa che “deve stabilire” la possibilità di condonare le proprie liti. Mentre negli altri casi l’estensione della definizione alle liti di pertinenza degli enti locali era rimessa alla valutazione discrezionale dell’ente locale stesso (cfr. art. 11, c. 1-bis del d.l. n. 50/2017, art. 6, c. 16 del d.l. n. 119/2018), la presente normativa sembra vincolare gli enti locali a consentire la definizione dei contenziosi che li riguardano, ciò con possibili profili di frizione con i principi del federalismo fiscale e, in ultimo, con gli artt. 117 e 119 Cost.
Se in ogni caso appare assai poco certo che, nonostante le forzature, la nuova definizione agevolata dei contenziosi tributari pendenti innanzi ai giudici di legittimità riesca a conseguire l’obiettivo realmente prefissato di ridurre le pendenze tributarie della Suprema Corte, occorre comprendere le ragioni di tale fenomeno e verificare se vi siano modalità per superarle sì da realmente ed efficacemente concorrere allo scopo di cui s’è detto, ossia lo smaltimento dell’arretrato tributario pendente dinnanzi alla Suprema Corte.
Possono delinearsene almeno due.
In primo luogo, non può farsi a meno di considerare che una delle parti dei giudizi tributari ricorre sistematicamente in cassazione, perché ha l’avvocato gratis: ciò spiega, e non è un discorso semplicistico, perché il contenzioso tributario in cassazione supera il contenzioso di tutte le altre materie.
I numeri che l’Avvocatura di Stato informalmente divulga attestano una prevalenza delle ragioni erariali in circa il 70% nei processi di ultimo grado. Se si considera che, secondo i dati (cfr. PNRR, pag. 68, cit.), la percentuale di cassazione delle sentenze di merito si attesta sempre intorno al 50%, lo scarto di circa il 20% a favore delle tesi erariali suscita alcune riflessioni. Su molti temi (si possono citare, a mero titolo d’esempio, l’asserita inapplicabilità del contraddittorio preaccertativo come principio generale, l’asserita inapplicabilità dell’esenzione dell’IMU sulla prima casa in caso di coniugi residenti in comuni diversi, l’asserita idoneità della notifica di un atto impositivo nei confronti di un condebitore in solido a impedire la decadenza nei confronti di tutti, l’asserita non necessità di motivazione sul rigetto delle osservazioni presentate dal contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 7, oltre a molti e gravi errori sistematici come quello che ha ritenuto applicabile la disciplina italiana del reddito d’impresa per le società straniere prive di stabile organizzazione in Italia, ma molti altri esempi potrebbero essere svolti), la dottrina sottolinea da tempo come potrebbero esservi anche soluzioni più conformi a diritto rispetto agli orientamenti assunti negli anni dalla Suprema Corte, sebbene meno favorevoli all’interesse fiscale. In svariate occasioni, inoltre, la stessa Corte Costituzionale ha dovuto fatto chiarezza su tali questioni, spesso appunto sulla scorta di riflessioni dottrinarie (talora espressamente citate in sentenza, come nel caso della sent. n. 209/2022 sul tema dell’IMU per i coniugi), conducendo a rivedere indirizzi fortemente pregiudizievoli per i contribuenti ma che apparivano consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte. Appare dunque necessario recuperare a ogni livello, anche giudiziale, serenità nel rapporto tra fisco e contribuenti guardando con reale imparzialità alla pur diversa posizione delle parti in contesa e così essendo più liberi e propensi ad assumere decisioni maggiormente conformi a diritto e a giustizia.
Sotto un secondo profilo, non è osservazione banale né tralaticia ma purtroppo realistica e concreta quella per cui il numero dei giudici addetti al contenzioso tributario in Cassazione appare insufficiente per garantire la ricorribilità di ogni decisione (sul tema, in generale, CSL, Recovery Fund e giustizia, 10 febbraio 2021; CSL, Giustizia e Recovery Plan: se non cambia restano sprechi e inefficienze, 26 aprile 2021). Da qui la riflessione, che può apparire paradossale: o si modifica la Costituzione, trasformando la cassazione in una corte suprema che sceglie i casi sui quali pronunziarsi (e allora si apre il problema, di complessa soluzione in uno Stato che pone tra i propri principi fondamentali quello dell’uguaglianza sostanziale fra tutti i cittadini, dei criteri di selezione e scelta dei casi da decidere), oppure si prende atto della necessità di aumentare l’organico. E in ciò, si ricorda, dovrebbero certamente essere tenute in considerazioni le esigenze di apertura della sezione specializzata tributaria anche ai nuovi magistrati tributari, già evidenziate nel precedente par. 3.
Al riguardo, non pare inopportuno ribadire che istituti ideati negli ultimi anni quali lo svolgimento di tirocini da parte di giovani laureati ovvero l’introduzione dell’ufficio per il processo si appalesano inadeguati allo scopo e incapaci di risolvere problemi strutturali del comparto giudiziario, che vengono piuttosto in tal modo “glissati” pensando di poter imbastire un abito esclusivamente con delle piccole toppe.
Per lavorare serenamente e avere tempo di studiare e riflettere adeguatamente sulla soluzione “giusta” e “conforme a diritto” delle controversie sottopose al suo esame, un giudice non può essere subissato di cause: ed è parimenti evidente che, per quanto possano costituire valido ausilio ad esempio nella ricerca di precedenti giurisprudenziali o di orientamenti dottrinari, soggetti quali tirocinanti o addetti all’ufficio per il processo mai potranno sostituirsi al giudice persona fisica nello studio approfondito del singolo caso e nella funzione prettamente e propriamente decisionale, a lui solo riservata[38].
La definizione delle liti pendenti in cassazione di cui all’art. 5 della l. n. 130/2022, pertanto, appare misura non del tutto idonea a conseguire i fini per cui è stata concepita e sconta significativi difetti di formulazione normativa.
Diversamente da quanto talora si ritiene, le definizioni agevolate e i condoni non sono necessariamente un premio per gli evasori, ma possono avere una utilità strutturale per l’interesse pubblico. A tal fine, tuttavia, occorre dedicare a essi una disciplina adeguata e curata, cosa che non sempre negli ultimi anni è avvenuto.
Non appare un caso, a questo riguardo, che il nuovo Governo, non appena entrato in carica, abbia dovuto ridisegnare alla radice il perimetro della definizione agevolata delle liti pendenti, con norma in corso di approvazione nel momento in cui si scrive, superando così la critica formulazione prevista dall’art. 5 della l. n. 130/2022 sopra esaminata.
* Contributo sottoposto a valutazione.
L’articolo è frutto di una riflessione comune tra gli autori e, nello specifico, i paragrafi 1, 3 e 7 sono stati redatti da Angelo Contrino e Francesco Farri, mentre i paragrafi 2, 4, 5 e 6 da Angelo Salvi.
[1] M. Villani, La Giustizia Tributaria tra esigenze pratiche e vincoli di diritto interno ed europeo del «giusto processo», in Diritto e Pratica Tributaria, 3/2016, p. 1005.
[2] M. Logozzo, L’Amministrazione Finanziaria come organo di giustizia nel pensiero di Enrico Allorio, in Diritto e Pratica Tributaria, 6/2015, p. 831.
[3] C. Glendi, Nuovi fermenti legislativi sulla giurisdizione tributaria, in Ipsoa Quotidiano, 7 maggio 2016.
[4] Anche in considerazione del fatto che – come noto – le sentenze del Consiglio di Stato, giudice amministrativo di secondo grado, sono ricorribili in Cassazione solo per motivi concernenti la giurisdizione, contrariamente a quanto è sinora avvenuto con riguardo alle sentenze delle commissioni tributarie regionali, rispetto alle quale non vi era alcun limite di impugnazione, se non quello di sviluppare una critica “vincolata” nell’ambito di quanto previsto dall’art. 360 cod. proc. civ..
[5] Il tema è ben sviluppato in F. Farri, Giurisprudenza delle imposte, 1/2022, alla cui lettura rimando. Segnalo, peraltro, che non tutti in dottrina danno per scontato che la riforma superi il vaglio di costituzionalità in relazione a quanto in discorso; scrive, infatti, C. Glendi, La novissima stagione della giustizia tributaria riformata, in Diritto e pratica tributaria, 4/2022, pp. 1141-1142 «Nel complesso, una disciplina ragionata, che, inevitabilmente, accontenterà qualcuno e scontenterà invece altri, ma, che, in sostanza, sembra poter essere in grado di consentire un funzionale avvio di questa nuova stagione riformata. Pur non potendosi, in apicibus, aprioristicamente, accantonare il non manifestamente infondato dubbio, in specie, che quelle che ora si sono volute considerare quali “Corti di giustizia tributaria” di primo e di secondo grado, abbandonando così la vecchia denominazione di “Commissioni tributarie”, senza peraltro accedere alle più comuni accezioni di “Tribunali” o “Corti d’appello”, possano eccedere dal pur allentato perimetro di cui alla sesta disposizione transitoria e finale della nostra Costituzione finendo così per incorrere nel divieto di cui all’art. 102, 2° comma, Cost. Non potendosi dare per scontato la riportabilità della disciplina che ne occupa al perimetro della “revisione”, anziché a quella di una reale “novità” rispetto ai preesistenti organi speciali della giurisdizione tributaria».
[6] R. Succio, La riforma del processo tributario: i nuovi giudici tributari, in Il Quotidiano Giuridico del 6 settembre 2022.
[7] Si veda in proposito A. Giovanardi, La riforma della giustizia tributaria nel disegno di legge di iniziativa governativa AS/2636: decisivo passo in avanti o disastrosa iattura?, in Rivista Telematica di diritto tributario dell’8 luglio 2022.
[8] F. Farri, Giurisprudenza delle imposte, 1/2022, p. 46.
[9] E. De Mita, Processo Tributario, una riforma con troppe voci, in Il Sole 24 Ore del 22 aprile 2016.
[10] V., in proposito, A. Giovanardi, op. cit.
[11] A. Leone, Relazione del Presidente alla Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario 2022 del 5 aprile 2022.
[12] Così A. Giovanardi, op. cit.
[13] F. Farri, Giurisprudenza delle imposte, 1/2022, p. 42.
[14] Per una prima riflessione sull’intervento legislativo in questione, si rimanda all’articolo F. Farri, A. Contrino, Una riforma da completare, pubblicato sul sito del Centro Studi Livatino il 20 settembre 2022, in https://bit.ly/3TKJeWg
[15] Sul tema cfr. L. Lombardo, Le prove nel processo tributario, relazione al seminario “Questioni attuali di diritto tributario sostanziale e processuale” organizzato a Catania dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 21 e 22 ottobre 2016.
[16] V., da ultimo, R. Succio, In vigore la riforma del processo tributario: prova testimoniale e definizione delle controversie, in Il Quotidiano Giuridico del 16 settembre 2022.
[17] V., in proposito, L. Lombardo, op. cit.
[18] In tal senso, G. Tinelli, intervento al convegno La riforma del processo tributario: la prova e la nuova conciliazione, tenutosi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 6 settembre 2022.
[19] Costituirebbe, cioè, una norma speciale rispetto a quella contenuta nel testo dell’art. 257-bis cod. proc. civ.
[20] R. Di Succio, Riforma processo tributario: l’onere della prova prevista dalla L. 130/2022, in Il Quotidiano Giuridico del 28 settembre 2022, reperibile al seguente link: https://bit.ly/3TFf1Yk
[21] Intervento di Prof. G. Tinelli al convegno La riforma del processo tributario: la prova e la nuova conciliazione, tenutosi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 6 settembre 2022 e ascoltabile al seguente link: https://bit.ly/3FL0TqX
[22] M. Taruffo, La prova nel processo civile, Milano, 2012, p. 1101.
[23] M. Taruffo, op. cit., p. 1113.
[24] Ma sul punto v. A. Salvi, La nuova giustizia tributaria-2. la prova testimoniale, scritta e orale, cit.
[25] P. Garbolino, La logica del probabile e la prova giuridica, in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, anno 1999, n. 108, p. 448.
[26] In tal senso, espressamente, anche P. Russo, Problemi in tema di prova nel processo tributario dopo la riforma della giustizia tributaria, in Riv. telem. dir. trib., 7 dicembre 2022.
[27] Si veda in proposito Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/10/2022, n. 31878.
[28] C. Califano, Recentissime dalla Cassazione tributaria – un (tentativo di) dialogo tra dottrina e giurisprudenza – Cass., ord. 27 ottobre 2022, n. 31878, in Rivista telematica di diritto tributario del 28 novembre 2022.
[29] A. Marcheselli, Onere della prova, orecchio assoluto, riforma della giustizia tributaria e auspicabile de profundis per le c.d. presunzioni giurisprudenziali, in Riv. telem. dir. trib., 15 dicembre 2022.
[30] V., in proposito, quanto riportato sul sito della Camera dei deputati, nella sezione relativa ai Temi dell’attività Parlamentare, in proposito del procedimento di mediazione civile e commerciale disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28; il documento è consultabile al seguente link: https://bit.ly/3Uf1APe.
[31] Detta disposizione è stata novellata dalla legge 21 agosto 2022 n. 130, che ha introdotto tra l’altro i commi 2-septies, con cui è stata introdotta una maggiorazione delle spese di lite per le controversie sottoposte a mediazione («Nelle controversie di cui all’articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento») e 2-octies, avente a oggetto la regolamentazione delle spese di giudizio in caso di mancata conciliazione giudiziale («Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione»).
[32] C. Glendi, La novissima stagione della giustizia tributaria riformata, in Diritto e Pratica Tributaria, 4/2022, pp. 1143-1144.
[33] Resta, comunque, ferma la generale applicazione a tutte le controversie degli istituti di conciliazione giudiziale (fuori e in udienza) definiti agli artt. 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
[34] Si legga, in proposito, la prima versione dell’art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546: «Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48».
[35] G. Corasaniti, Mediazione e conciliazione nel processo tributario: lo stato dell’arte e le prospettive di riforma, in Diritto e Pratica Tributaria, 3/2020, pp. 980-981
[36] C. Glendi, Il reclamo e la mediazione, in Abuso del diritto e novità sul processo tributario, (a cura di) C. Glendi – C. Consolo – A. Contrino, p. 176, richiamato anche da G. Corasaniti, op. cit.
[37] A. Perrone, Prime riflessioni sulla nuova conciliazione proposta dalla Corte di giustizia tributaria, reperibile al seguente link: https://bit.ly/42C1epw
[38] Cfr., sul punto, Farri, Gli Uffici per il processo: un’analisi di (in)efficienza economica, in L-Jus, 1, 2022, p. 43 ss.