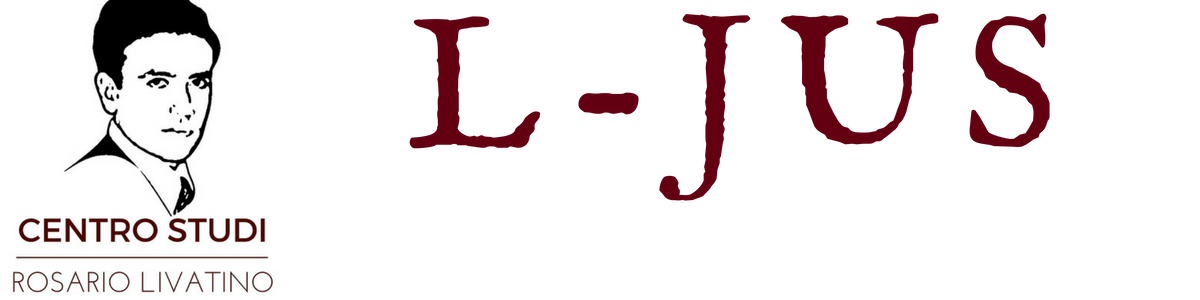Card. Mauro Piacenza
Penitenziere Maggiore
Il mio pensiero iniziale non potrebbe non andare a Rosario Livatino, titolare del Centro Studi che ha organizzato questo Convegno e la cui memoria costituisce un vero e proprio tesoro per tutti, tanto più per quanti si riferiscono alla stessa fede che ha lievitato la sua ricca personalità, che rimane in benedizione.
Ringrazio il Dott. Domenico Airoma, Vice Presidente del Centro, che tanto appropriatamente ha introdotto i lavori e il Presidente prof. Mauro Ronco, che avremo il privilegio di ascoltare a breve.
Mi sia concesso anche un saluto beneaugurale al dott. Alfredo Mantovano impegnato, come tutti ben sappiamo, a rispondere al grave dovere di alta collaborazione per il bene comune del nostro Paese. Un cordiale saluto a tutti voi qui convenuti.
La tutela del segreto. Perché un Convegno su questo tema?
Nell’attuale contesto socio-culturale ed anche ecclesiale, globalizzato e fortemente mediatico, parlare di “segreto” può apparire come una contraddizione in termini se consideriamo inoltre che Dio stesso ha preso la decisione di parlare, di rivelarsi e di inviare nel mondo il suo Figlio Unigenito, Gesù Cristo, che nella loro professione di fede i cristiani riconoscono come il “Verbo di Dio fatto carne”.
Al proposito, nell’Istruzione Pastorale Communio et progressio sugli strumenti della comunicazione sociale, pubblicata nel 1971 dalla allora Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali, è detto: «Il più solido fondamento e il supremo modello di unione fra gli uomini si trovano in Dio, il quale è diventato loro Fratello e ha dato l’ordine ai suoi discepoli di portare l’annuncio di gioia a tutti i viventi, senza distinzione di epoca o di luogo, proclamandolo “nella luce” e “sopra i tetti”. Durante l’esistenza terrena Cristo si è rivelato il perfetto Comunicatore» (nn. 10-11).
Occorre allora dissipare subito ogni sospetto circa il fatto che il sistema di segretezza che l’ordinamento ecclesiale, come ogni ordinamento giuridico si dà, sia volto a coprire trame, complotti o misteri, come talvolta ingenuamente l’opinione pubblica è portata o, più facilmente, è suggestionata a credere. Il sostantivo segreto deriva dal participio passato latino secretum, che significa ciò che è stato messo da parte o separato. Ognuno ha segreti personali, che confida solamente a persone fidate e discrete; nello stesso tempo desidera e confida che questi non vengano violati o traditi per ingerenze di terzi o per superficialità o sprovvedutezza. Pertanto, chi mette a parte qualcuno di un segreto e chi ne diviene fiduciario, si obbligano, per patto implicito o esplicito, alla riservatezza e alla segretezza. Violare o tradire un segreto senza il permesso dell’interessato è, di per sé, un male sotto il profilo morale e, se tale segreto è poi protetto dal diritto penale, la violazione diviene delitto (cfr. «Quaderni di Diritto Ecclesiale», 1/2013, p. 3).
Ecco perché grandi e salutari sono gli effetti che con il segreto e la riservatezza si desiderano proteggere e custodire per salvaguardare la fama e la reputazione di qualcuno o rispettare diritti di singoli e di gruppi (cfr. Communio et progressio, n. 121).
Penso per esempio all’ufficio di parroco. Il contatto con tanti fedeli, la vicinanza ai loro problemi e alle loro sofferenze e, soprattutto, l’aiuto spirituale e materiale che può loro offrire, come pure le confidenze che riceve e la stessa celebrazione dei sacramenti, dovranno passare attraverso la delicatezza e la riservatezza del suo ministero. Il termine “riservatezza” (attualmente più usato come “privacy”), in latino è reso con “verecundia” o “pudor”. L’altro vocabolo latino usato è “intimitas”. Questo ha origine dal superlativo di “inter”, a indicare la parte massimamente propria, interna, riservata, così come l’ambito più familiare. Si potrebbe anche definire lo spazio «dove, in segreto, [il parroco] vive il suo io più vero e più profondo, sacro. Tutti hanno qualcosa di sacro da conservare» (cfr. F. Marini, L’ufficio del parroco tra segreto e riservatezza, in «Quaderni di diritto ecclesiale», 1/2013, pp. 85-86).
Compito non solo del parroco ma di ogni sacerdote è quello di tutelare e difendere l’intimità della persona, cioè custodire la presenza di Dio nell’intimo di ogni uomo, come ricorda S. Agostino che nel celebre passo delle sue Confessioni descrive Dio come interior intimo meo et superior summo meo, più intimo della mia parte più intima, più alto della mia parte più alta. Chi viola questa sfera personalissima e sacra compie non solo un atto di ingiustizia, un delitto canonico, ma un vero e proprio atto di irreligiosità.
La Penitenzieria Apostolica, che da otto secoli è il Tribunale Apostolico deputato alla trattazione delle materie che concernono il foro interno, conosce molto bene l’inestimabile valore morale e spirituale del segreto sacramentale, della riservatezza, dell’inviolabilità della coscienza e le sue ricadute positive nella vita dei singoli fedeli. Quanti veri e propri miracoli della grazia di Dio avvengono nel segreto di un confessionale, nel colloquio confidenziale che caratterizza la relazione di accompagnamento spirituale, nell’intimo del cuore che, pur ferito dal male, si apre alla verità dell’amore di Dio!
Quanto fin qui affermato ci suggerisce il modo con cui affrontare il tema centrale del sigillum confessionis. Da sempre la Chiesa ha attribuito sovreminente rilevanza alla riservatezza dell’incontro tra il fedele ed il sacerdote nell’amministrazione del sacramento della Penitenza o Riconciliazione e alla tutela del segreto confessionale. La tutela di tale segreto addirittura si intreccia con lo sviluppo storico della forma del sacramento. Chi volesse seguire un percorso storico-genetico potrebbe allora chiaramente cogliere l’affiorare dell’autoconsapevolezza ecclesiale dell’indisponibilità di quanto il penitente confida in Confessione, una autoconsapevolezza che proviene direttamente dal diritto divino rivelato ed affonda le radici nella stessa natura del sacramento, al punto da non ammettere eccezione alcuna nell’ambito ecclesiale, né, tantomeno, in quello civile. Nella celebrazione della Riconciliazione è come racchiusa, infatti, l’essenza stessa del cristianesimo e della Chiesa: il Figlio di Dio si è fatto uomo per salvarci ed ha deciso di coinvolgere, quale “strumento necessario” in quest’opera di salvezza, la Chiesa e, in essa, quelli che Egli ha scelto, chiamato e costituito quali suoi ministri.
Per esprimere questa verità, la Chiesa ha sempre insegnato che i sacerdoti, nella celebrazione dei sacramenti, agiscono “in persona Christi capitis”, ossia nella persona stessa di Cristo capo: «Cristo ci permette di usare il suo “io”, parliamo nell’“io” di Cristo, Cristo ci ‘tira in Sé e ci permette di unirci, ci unisce con il suo ‘io’ (…) È questa unione con il suo “io” che si realizza nelle parole della consacrazione eucaristica. Anche nell’“io ti assolvo” – perché nessuno di noi potrebbe assolvere dai peccati – è l’“io” di Cristo, di Dio, che solo può assolvere» (Benedetto XVI, Colloquio con i sacerdoti, 10 giugno 2010).
Ogni penitente, che umilmente si rechi dal sacerdote per confessare i propri peccati, testimonia in tale modo il grande mistero della Incarnazione e l’essenza soprannaturale della Chiesa e del sacerdozio ministeriale, per mezzo del quale Cristo Risorto viene incontro agli uomini, tocca sacramentalmente – ovvero realmente – la loro vita e li salva. Per tale ragione, la difesa del sigillo sacramentale da parte del confessore, se fosse necessario usque ad sanguinis effusionem, rappresenta non solo un atto di doverosa lealtà nei confronti del penitente, ma molto di più: una necessaria testimonianza – un martirio – resa direttamente all’unicità e all’universalità salvifica di Cristo e della Chiesa.
Le prime tracce del sigillum confessionis si possono rinvenire negli scritti di Afraate il Saggio a metà del IV secolo. Afraate era originario di una comunità ecclesiale che si trovava alla frontiera tra il giudaismo e il cristianesimo. Era una comunità molto legata alla Chiesa-Madre di Gerusalemme, e i suoi vescovi venivano scelti tradizionalmente fra i cosiddetti “familiari” di Giacomo, il “fratello del Signore” (cf Mc 6,3): erano cioè persone collegate per sangue e per fede alla Chiesa di Gerusalemme. Afraate definisce i sacerdoti “medici delle anime” esortando i penitenti a riporre fiducia nel loro ascolto, consapevoli del fatto che esiste un vincolo che li lega al segreto circa quanto appreso in confessione.
Siamo qui alla scaturigine della disciplina sul segreto confessionale, siamo alle origini che ci assicurano la genuinità. Ne parleranno con significativa dovizia poi Ambrogio, Agostino, Origene, come in pieno Medioevo Icmaro di Reims e Lanfranco, Arcivescovo di Canterbury, che scrive un’opera dal titolo “De celanda confessione”.
Sarà poi con il Concilio Lateranense IV (1215) che avremo un canone che sancisce per la prima volta l’obbligo morale e giuridico come legge universale della Chiesa, prevedendo gravi sanzioni per i sacerdoti inadempienti. Così infatti sancisce il cap. 21 del decreto Omnis utriusque sexus, già famoso nella storia del diritto per l’estensione dell’obbligo della confessione annuale: «Caveat autem omnino ne verbo vel signo vel alio quovis modo prodat aliquatenus peccatore… quatenus qui peccatum in poenitentiali iudicio sibi detectum praesumpserit revelare, non solum a sacerdotali officio deponendum decernimus, verum etiam ad agendam perpetuam poenitentiam in arctum monasterium detrudendum».
Possiamo altresì ricordare anche che, già prima del Lateranense IV, la cost. 38 del Sinodo di Parigi (1203-1214) così si esprimeva: «Nullus ira vel odio vel etiam metu mortis, in aliquo aurea revelare confessionem signo vel verbo, generaliter vel specialiter; ut dicendo “Ego scio quale estis”; et, si revelaverit, absque misericordia debet degradari».
Del tema tratta anche S. Tommaso d’Aquino, il quale mostra come l’obbligo del sigillo sacramentale sia di diritto divino, in quanto scaturisce direttamente dalla stessa divina istituzione del sacramento della Penitenza: «primo quidam et principaliter, quia illud ut occultatio est de essentia Sacramenti, in quantum scit illud ut Deus, cuius vicem gerit in confessionis; alio modo, propter scandalum vitandum» (S. Th., q.11, art.4). Ne deriva che tutto ciò che ostacola l’esercizio di quest’ultima, come la violazione del sigillo, è proibito dallo stesso diritto divino. La natura e l’estensione di tale obbligo si percepisce anche considerando il divieto che ne deriva per il giudice ecclesiastico di condannare un reo sulla base di quanto confidato in confessione: «Nec tamen sigillum confessionis contra caritatem militat, quia caritas non requirit ut apponatur remedium peccato quod homo nesciat illud autem quodo sub confessione scitur, est quasi nescitum, cum non sciat ut homo, sed ut Deus».
Nei secoli seguenti si insisterà sempre più energicamente sulla necessità di dare adeguata rilevanza al sigillo sacramentale. Al proposito si può ricordare un Decreto dell’allora Sant’Uffizio, del 18 novembre 1882, in cui si affermava che nessun confessore può fare uso della scienza acquisita in confessione cum gravamine poenitentis, rigettando la liceità delle future ed eventuali opinioni contrarie e sottolineando l’intrinseco legame presente in foro interno tra l’elemento giuridico e quello morale.
Tutte queste istanze hanno trovato il loro luogo naturale nella composizione del Codex Iuris Canonici del 1917. In tale edizione erano i canoni 889 e 890 che disciplinavano il sacramento della Penitenza. Dal can. 889 emerge come non fosse lasciato al confessore alcun margine di discrezionalità nell’osservanza del sigillo, la quale doveva essere assoluta: il sigillo sacramentale coincide e si sovrappone con l’obbligo di “non prodere peccatorem”. Obbligo esteso anche all’interprete e a tutti coloro ai quali fosse giunta notizia dei peccati rivelati in Confessione.
E si arriva così al Codice vigente che, circa il sigillo sacramentale, ai canoni 983 e 984 riprende sostanzialmente la precedente normativa. In particolare, il canone 984, speculare al canone 890 del precedente Codex, prescrive la tutela offerta al sigillo sacramentale:
- 1 È proibito al confessore fare uso delle conoscenze acquisite dalla confessione con aggravio del penitente, anche escluso qualsiasi pericolo di rivelazione.
- 2 Colui che è costituito in autorità ed ha avuto notizia dei peccati in una confessione ricevuta in qualunque momento, non può avvalersene in alcun modo per il governo esterno.
L’obbligo di non usare di quanto acquisito in confessione, anche qualora fosse escluso qualsiasi pericolo di violazione, è confermato dal can. 1550, che definisce l’incapacità per i ministri del sacramento di essere testimoni davanti al Giudice ecclesiastico etsi poenitens eorum manifestationem petiterit, anche qualora il penitente li avesse sciolti dall’osservanza del rigoroso sigillo confessionale o avesse addirittura chiesto loro di deporre.
L’attuale Codice ripropone altresì gravi sanzioni per chi vìoli il sigillo. Nel can. 1388, che fa da specchio al vecchio canone 2369, si distingue fra violazione diretta, punita con la scomunica latae sententiae riservata alla Santa Sede, e violazione indiretta, punita con una pena ferendae sententiae, indeterminata, obbligatoria, commisurata alla gravità del delitto, tenuto conto delle circostanze di probabilità di divulgazione, di scandalo provocato e di altri fattori.
La disciplina della Chiesa in subiecta materia è dunque rimasta sempre sostanzialmente la medesima, salvo la specificazione di altre fattispecie, come l’assoluzione del complice, fin in antico, ovvero, più recentemente, la dilatazione della violazione del sigillo mediante strumenti tecnici.
La Riconciliazione è un bene che la sapienza della Chiesa ha sempre salvaguardato con tutta la propria forza morale e giuridica con il sigillo sacramentale. Esso, anche se non sempre compreso da una certa mentalità moderna, è indispensabile per la santità del sacramento e per la libertà di coscienza del penitente, il quale deve essere certo, in qualunque momento, che il colloquio sacramentale resterà nel segreto del confessionale, tra la propria coscienza che si apre alla grazia di Dio, con la necessaria mediazione del sacerdote. Il sigillo è indispensabile e nessun potere umano ha giurisdizione, né può rivendicarla, su di esso.
Nelle attuali circostanze, la Penitenzieria Apostolica, incoraggiata dal Sommo Pontefice, ha recentemente elaborato una Nota sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale, pubblicata per mandato dello stesso Pontefice il 29 giugno 2019. Nella elaborazione di tale Nota si è inteso rendere un servizio di chiarificazione dirimente nel contesto di grave disorientamento, favorendo altresì una migliore comprensione di concetti fondamentali attualmente largamente incompresi o addirittura, in taluni casi, avversati. Il documento prende le mosse dalla constatazione che nella odierna società fortemente “mediatizzata”, in genere, allo sviluppo tecnologico e all’implementazione dei mezzi di comunicazione non corrisponde un analogo impegno per la ricerca sincera della verità, quanto piuttosto il desiderio morboso di far circolare le notizie, vere o false che siano, amplificate o sminuite secondo gli interessi. Oggi tutto è in mostra, tutto si deve far sapere. Invocando, di fatto, quale ultimo tribunale, il giudizio dell’opinione pubblica, troppo sovente sono diffuse informazioni di ogni genere, attinenti anche alle sfere più private e riservate, che inevitabilmente inducono – o quanto meno favoriscono – giudizi temerari, ledono illegittimamente ed in modo anche irreparabile la buona fama altrui. Tale diffuso atteggiamento si riflette anche sulla Chiesa, il cui ordinamento giuridico si vorrebbe talvolta conformato a quello degli Stati in cui essa vive, in nome di una pretesa correttezza e trasparenza.
In tale contesto, la Penitenzieria Apostolica ha anzitutto ritenuto urgente ricordare l’assoluta inviolabilità del sigillo sacramentale che, come detto, è fondata sul diritto divino e non ammette alcuna eccezione.
È essenziale, al riguardo, insistere sull’incomparabilità del sigillo confessionale con il segreto professionale cui sono tenute alcune categorie professionali (per es. medici, farmacisti, avvocati, ecc.), onde evitare che le legislazioni secolari applichino al sigillo – sempre inviolabile – le deroghe legittimamente previste per il segreto professionale. Il segreto della confessione non è un obbligo imposto dall’esterno, ma una esigenza intrinseca del sacramento e come tale non può essere sciolto neppure dallo stesso penitente. Il penitente non parla al confessore-uomo, ma a Dio, per cui impossessarsi di quello che è di Dio risulterebbe sacrilego.
In seconda battuta, la Nota considera l’ambito giuridico-morale proprio di quegli atti di foro interno che si compiono al di fuori del sacramento della Penitenza. L’esempio classico è quello della guida spirituale. Anche per questi casi il diritto canonico garantisce una speciale riservatezza al colloquio spirituale, che coinvolge la sfera più intima e personale del fedele in ordine all’ascolto e al discernimento della volontà di Dio. Così, per esempio, in riferimento alla ammissione agli Ordini sacri, è fatto divieto di chiedere il parere non solo del confessore ma anche del direttore spirituale del candidato, per prevenire qualsiasi abuso di potere.
Infine, l’ultimo punto della Nota tratta delle altre “specie” di segreto che esulano dall’ambito del foro interno. Si riafferma al riguardo il principio del diritto naturale a custodire il segreto, tranne quando la custodia del segreto dovesse causare a chi li confida, a chi ne viene messo a parte, o a terzi, danni molto gravi ed evitabili soltanto mediante la divulgazione della verità (cfr. CCC, n. 2491). Più in generale, nel comunicare o nel celare la verità, la Nota propone a criterio generale quello di «conformare la propria vita al precetto dell’amore fraterno, avendo davanti agli occhi il bene e la sicurezza altrui, il rispetto della vita privata e il bene comune».
In hodiernis adiunctis, è opportuno precisare che il testo della Nota non può e non vuole essere in alcun modo una giustificazione o una forma di tolleranza degli esecrabili casi di abusi perpetrati da taluni membri del clero. Nessun compromesso è accettabile nel promuovere la tutela dei minori e delle persone vulnerabili come pure nel prevenire e contrastare ogni forma di abuso, nello spirito di quanto recentemente regolato con il motu proprio Vox estis lux mundi (7 maggio 2019).
Nel pubblicare la Nota, la Penitenzieria Apostolica ha espresso il convincimento che «la difesa del sigillo sacramentale e la santità della confessione non potranno mai costituire una qualche forma di connivenza col male, al contrario rappresentano l’unico vero antidoto al male che minaccia l’uomo e il mondo intero; sono la reale possibilità di abbandonarsi all’amore di Dio, di lasciarsi convertire e trasformare da questo amore, imparando a corrispondervi concretamente nella propria vita».