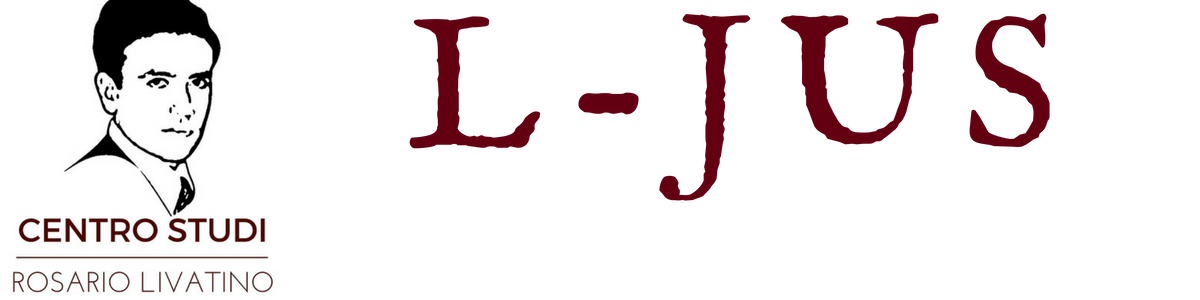Angelo Salvi
Avvocato in Roma
LIBERTÀ DI RELIGIONE E DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NELLO SPAZIO EUROPEO A VENT’ANNI
DALLA DIRETTIVA 2000/78/CE*
Sommario: 1. Premessa – 2. Le fonti del diritto antidiscriminatorio. CEDU, diritto euro-unitario e normativa “interna”. Il rapporto tra le fonti – 3. La nozione di discriminazione. Il fattore religione e i legittimi requisiti occupazionali – 4. La giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte EDU in materia di libertà religiosa e di discriminazione per motivi di religione – 5. Le differenze di trattamento nel caso delle attività professionali delle Chiese e organizzazioni di tendenza – 6. Conclusioni.
- Premessa
Il prossimo 27 novembre ricorrerà il ventennale della direttiva n. 2000/78/CE, c.d. “direttiva quadro”, con cui il Consiglio dell’Unione europea «stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro». Essa, assieme alla coeva 2000/43/CE (c.d. “direttiva razza”), rappresenta un punto di svolta nella legislazione comunitaria per l’affermarsi del principio di non discriminazione «come fonte autonoma di diritti»[1] ed avvia quella nuova stagione della legislazione antidiscriminatoria che, con riferimento al fattore religione, avrebbe condotto a sostenere che «la nuova frontiera del diritto di libertà religiosa è quella, oggi in via di espansione, che parte della dottrina invoca nel nome del diritto antidiscriminatorio»[2].
Senza pretesa di esaustività, il presente lavoro si propone di tratteggiare il quadro dei principali approdi cui, nell’arco temporale in menzione, sono pervenuti il legislatore (nazionale e comunitario) e la giurisprudenza formatasi sul fattore religione, con uno sguardo prospettico al contributo che l’argomento può offrire al dibattito sul futuro dell’Unione, nella convinzione che lo studio della giurisprudenza formata sull’argomento «può rivelarsi valido strumento per rilanciare una riflessione consapevole su temi, oggi, sempre più presenti nell’attualità, quali l’integrazione, la non discriminazione e la tolleranza (religiosa ma non solo). Un discorso che non resti confinato nel ristretto tecnico-giuridico, ma sappia coinvolgere anche la dimensione etico-politica e culturale»[3].
La stessa dottrina giuridica ha, d’altro canto, recuperato a una più appropriata considerazione il tema della c.d. forza sociale delle religioni, da ritenere «elementi fondanti e qualificanti la cultura dei popoli»[4]. Le religioni condizionano i costumi dei popoli, e dunque ne condizionano i consumi e le abitudini di vita privata e lavorativa. Il riconoscimento della libertà religiosa, non solo nel foro interno ma anche nelle forme esterne del proselitismo e del simbolismo (la manifestazione pubblica della propria fede religiosa), è precondizione per poter parlare di discriminazione e di parità di trattamento.
Il riconoscimento della libertà di religione favorisce la pace sociale. Da questa considerazione si sviluppa quel percorso che ha condotto alcune confessioni, storicamente abituate a detenere la posizione di privilegio accordata alla religione di Stato, non solo ad accettare ma finanche a perorare la causa della libertà religiosa come vero e proprio diritto della persona[5]. Con la nascita dello Stato laico e pluralista la libertà religiosa diventa una vera e propria necessità sociale e trova riconoscimento e adeguata collocazione nel sistema dei diritti umani, oggi «sola forma possibile di comunicazione tra popoli che non possieda, nel suo principio, un carattere violento»[6]. Proprio dalle nazioni che hanno sistemi giuridici fortemente influenzati dai diritti confessionali «oggi giungono i grandi flussi migratori che per dimensioni stanno assumendo i contorni di un vero e proprio esodo»[7]. Si pensi alla Libia e alla Siria[8], ma anche alla Nigeria e alla Somalia, tanto per citarne qualcuno; paesi nei quali la libertà religiosa non esiste, a volte, neppure sulla carta.
D’altro canto, l’esperienza di questo ventennio consente di affermare che laicità dello Stato e neutralità religiosa non sono concetti perfettamente sovrapponibili. È questa l’eredità più importante del caso Lautsi contro Italia: «il contributo maggiore del caso Lautsi è così di stabilire chiaramente che la Corte attende dagli Stati che essi agiscano con neutralità, ma non che essi siano neutri essendo la neutralità un concetto essenzialmente relativo. Inoltre, non si esige dagli Stati che agiscano sempre e in tutto con neutralità. Si esige neutralità solo nel caso in cui lo Stato offenda i diritti religiosi personali. Se non sussiste – rispetto alle esigenze della Convenzione – offesa ai diritti religiosi personali, lo Stato non è tenuto ad agire con neutralità»[9].
Puppinck ne chiarisce molto bene le ragioni in questo passaggio: «la laicità è perciò una “visione”, una “convinzione filosofica”, alla stessa stregua di altre convinzioni e credenze che meritano rispetto; la laicità non ha valore di principio generale nel sistema della Convenzione. Questo è uno degli apporti principali del giudizio della Grande Camera. Quest’affermazione è a doppio taglio: permette ai sostenitori della laicità di valersi della libertà di coscienza, ma essi possono farlo quanto credenti tra gli altri. Occorre che accettino il relativismo intrinseco alla libertà religiosa e che agli occhi della Convenzione non possono pretendere di incarnare la neutralità per eccellenza. Questo non mette in discussione la loro possibilità di considerarsi detentori di un sistema ideale e di applicarlo, secondo le circostanze, a livello nazionale; ma per la Corte si tratta di una convinzione rispettabile in quanto compatibile con la Convenzione, così come lo sono altre convinzioni. La loro convinzione laica non è più neutra di una convinzione propriamente religiosa»[10].
In una società pluralista non esiste dunque il dogma della neutralità assoluta, perché il laicismo ha anch’esso un contenuto assiologico. È allora condivisibile l’affermazione secondo cui «il rispetto dell’identità religiosa di un individuo deve essere possibile nel rispetto dell’identità religiosa della società nella quale egli vive»[11].
Negli Stati democratici dello spazio europeo laicismo e pluralismo si declinano e possono declinarsi[12] con diversa intensità, nel rispetto delle millenarie tradizioni culturali dei popoli che partecipano dell’esperienza europea. I singoli Stati possono, in buona sostanza, riconoscere a una determinata confessione religiosa una posizione di “privilegio” nel loro ordinamento, che traduce in norme il sostanziale riconoscimento dell’apporto sociale, culturale e valoriale che quella determinata confessione ha storicamente fornito per la nascita ed il consolidamento dell’identità nazionale del popolo medesimo. Ciò non esclude, peraltro, che lo Stato in questione possa a buon diritto considerarsi comunque uno Stato laico e pluralista, nella misura in cui esso riconosca adeguati spazi di libertà anche alle altre confessioni religiose.
Si tratta di un equilibrio delicato e complicato, che nei paesi dell’Occidente più esposti ai flussi migratori di massa rischia di non trovare adeguata risposta in sistemi giuridici che, seppur figli del modello democratico-pluralista, sono spesso sottoposti alla propaganda che alimenta possibili «scontri di civiltà», ove «la paura tende a concentrarsi sulla presenza del čužoj ossia “dell’Altro”, di colui che è estraneo al sistema e non si iscrive all’interno di una data cultura, e per questo tende a essere trasformato in izgoi, ossia il reietto»[13].
Il tema della libertà di religione e quello della discriminazione per motivi di religione, nonché i riconnessi temi del simbolismo religioso e del proselitismo, muovono da un complesso di comuni princìpi ma si sviluppano poi su due diverse linee di disciplina, distinte per lo spazio pubblico (tribunali, aule universitarie, etc.) e per le aree private (in primis, i luoghi di lavoro), e vanno ad impattare diritti e interessi diversi nell’uno e nell’altro caso (salute e sicurezza pubblica nel primo, libertà d’impresa nel secondo, solo per citarne alcuni), dovendo con essi trovare adeguato bilanciamento.
Nel contesto giuslavoristico – che è poi quello su cui maggiormente incide la direttiva 2000/78/CE – è stato rilevato che «le religioni manifestano la loro forza propulsiva, poiché soprattutto nei luoghi di lavoro la soddisfazione delle istanze religiose può determinare effetti positivi sui livelli di produttività aziendale. Da questo punto di vista, sistemi di economia del lavoro nei quali viene riconosciuto il maggior grado di libertà religiosa, e quindi di comportamenti conformi alle culture religiose, si dimostrano più efficienti e consentono migliori performance di crescita, sia in termini di sviluppo occupazionale che di produttività»[14].
La migliore integrazione sul posto di lavoro è senza dubbio una delle sfide più importanti che l’Occidente laico si trova oggi ad affrontare. Le peculiarità che conseguono all’adesione a una specifica fede religiosa, sub specie di comportamenti che detta fede impone o vieta ai propri adepti (si pensi al divieto di consumare determinati cibi o bevande[15], alla necessità di spazi per l’esercizio di atti di culto, alla possibilità o meno di indossare determinati indumenti e, in termini trasversali, all’osservanza delle festività religiose e al giorno di riposo settimanale destinato alle pratiche religiose, etc.), possono influenzare le scelte del singolo[16], condizionarne l’accesso a determinate attività lavorative o le modalità di espletamento delle prestazioni di lavoro[17].
La tutela della libertà di religione passa, dunque, anche attraverso lo svolgimento di mansioni per quanto possibile compatibili con le prescrizioni della religione di appartenenza di ciascun fedele. Il diritto del lavoro del nuovo millennio, quello della flessibilità e della soft law, da un lato ha visto nascere nuove figure professionali, come il disability and diversity manager, dall’altro ha trovato proprio nella tecnica antidiscriminatoria uno strumento non solo «particolarmente funzionale ad una lettura del mercato del lavoro in termini di concorrenza tra insider e outsider (ossia tra lavoratori che sono dentro i settori del lavoro stabile e regolare, e lavoratori che non riescono ad accedervi), che aspira ad assurgere a paradigma esplicativo egemone delle dinamiche della domanda e dell’offerta di lavoro»[18], ma anche un elemento di propulsione necessario a stimolare una costante e costruttiva dialettica tra il sistema delle libertà economiche, quello dei diritti umani e quello delle religioni istituzionalizzate, in un contesto – quello lavorativo – ove la fede di ciascuno si confronta di continuo con le problematiche riconnesse all’integrazione.
- Le fonti del diritto antidiscriminatorio. CEDU, diritto euro-unitario e normativa “interna”. Il rapporto tra le fonti
Il complesso della normativa preposta alla tutela antidiscriminatoria nello spazio europeo si articola nel sistema di diritto enucleato dal Consiglio d’Europa ed in quello sviluppato dall’Unione Europea. Seppur contigue e per certi versi comunicanti e dialoganti, Consiglio d’Europa e Unione Europea sono però sono organizzazioni internazionali con struttura, competenze, valori, obiettivi e norme diversi; anche il complesso degli Stati aderenti al Consiglio d’Europa non è sovrapponibile a quello degli Stati membri dell’Unione Europea.
Il Consiglio d’Europa, fondato a Londra nel maggio del 1949 con il fine di realizzare un’unione più stretta tra i suoi membri (attualmente quarantasette), ritenuto che «uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali», il 4 novembre 1950 adottò la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che resta ad oggi il testo di riferimento per quanto qui in argomento. In particolare, l’art. 9 della Convenzione (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione) stabilisce che «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui».
Nell’ambito della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, e «per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli», è poi istituita la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 19 e ss.), la cui competenza «si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli» (art. 32). Dal novembre del 1998, con l’entrata in vigore del Protocollo XI, di modifica della Convenzione, tutti gli Stati membri, a seguito della ratifica, sono obbligati a sottoporsi alla giurisdizione della Corte europea[19].
L’Unione Europea, come evoluzione della Comunità Economica Europea istituita con il Trattato di Roma del 1957, ha una storia di organizzazione a carattere prevalentemente economico, che le ha consentito – nella prima fase di questa storia – di ben vivere pur in assenza di disposizioni specifiche sulla tutela dei diritti fondamentali. È stata, peraltro, la Corte di Giustizia, l’organo preposto alla tutela giurisdizionale nell’ambito dell’Unione, a valorizzare per prima in ambito comunitario i diritti fondamentali attraverso il richiamo ai princìpi ricavati dalle «tradizioni costituzionali comuni» degli Stati membri e a quanto previsto nella stessa Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo[20].
Solo in una seconda fase della vita dell’Unione, con il Trattato di Maastricht del 1992 (poi modificato dal Trattato di Lisbona del 2007) e con la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, proclamata una prima volta a Nizza il 7 novembre 2000 e una seconda volta a Strasburgo il 12 dicembre 2007, si arriverà a un assetto normativo sufficientemente organico. L’attuale formulazione dell’art. 6 del Trattato di Maastricht prevede quanto segue:
«1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.
- L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati.
- I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali».
In tema di libertà religiosa l’art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione) reca una formulazione molto simile al sopra citato art. 9 della Convenzione: «1.Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2.Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio»[21].
La norma, da leggere in combinato disposto con le successive portate dagli artt. 21, par. 1[22], e 22[23] della medesima Carta di Nizza, va poi integrata con il contenuto delle disposizioni di cui agli artt. 10[24], 17[25] e 19[26] del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. A valle della norma portata da quest’ultima disposizione, all’inizio del nuovo millennio l’Unione adotta poi le direttive 2000/43/CE (c.d. “direttiva razza”) e 2000/78/CE (c.d. “direttiva quadro”). Quest’ultima, in particolare, mira «a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento»[27].
Nell’ambito delle istituzioni dell’Unione Europea è compresa la Corte di Giustizia (art. 13 Trattato UE), chiamata a pronunciarsi «conformemente ai trattati: a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un’istituzione o da una persona fisica o giuridica;
- b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull’interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;
- c) negli altri casi previsti dai trattati” (art. 19 Trattato UE).
Rinviando ad altra parte del presente lavoro l’analisi dei diversi limiti cui soggiace la contrazione “legittima” dei diritti fondamentali nell’assetto normativo articolato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ed in quello articolato dal diritto dell’Unione Europea, si deve qui invece porre sin da subito l’accento sul diverso ambito di operatività dell’uno e dell’altro sistema: «le norme della Convenzione si rivolgono agli Stati membri.
Le previsioni li obbligano a rispettare, con i propri comportamenti e il proprio ordinamento interno, i diritti tutelati e consentono loro di apportare restrizioni alle facoltà garantite nei limiti e alle condizioni previste dalla Convenzione. Il rispetto dei limiti e delle condizioni previste da parte dello Stato è sottoposto, come si è visto, al giudizio della Corte. Le norme della Carta dei diritti, di contro, operano all’interno del diritto dell’Unione e, dunque, nelle materie di competenza di questa. Esse obbligano in prima battuta gli organi dell’Unione al rispetto dei diritti fondamentali, e obbligano gli Stati membri nei soli casi in cui si trovino a dare attuazione al diritto dell’Unione (art. 51 della Carta)»[28].
Quest’ultima considerazione non è di poco rilievo, se si tiene a mente che le istituzioni dell’Unione Europea non hanno competenza diretta in materia di religione[29], sicché il tema della libertà religiosa è sottoposto all’attenzione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea solo quando i giudici di Lussemburgo sono chiamati ad «esercitare la propria giurisdizione in questioni legate all’applicazione del diritto dell’UE, che tocchino anche il fenomeno religioso o l’attività delle organizzazioni religiose che operano nel territorio dell’Unione»[30].
Solo in tali casi vi è «una concreta possibilità per le pronunce della Corte UE di incidere sul diritto degli Stati membri, fino a condizionare, recentemente, con più coraggio, alcuni importanti profili della libertà religiosa». Il legislatore italiano ha recepito con sufficiente fedeltà la direttiva 2000/78/CE, attraverso il d. lgs. 9 luglio 2003 n. 216. Ne è scaturito un sistema a rete o multilevel, in cui la singola fattispecie deve essere vagliata, nella sua legittimità, sia con riferimento alle norme interne ed ai principi ispiratori delle stesse (a partire dalle Costituzione), sia con riferimento al diritto euro-unitario, che – per effetto dei meccanismi di adattamento – costituisce diritto dei singoli Stati membri, sia da ultimo con riferimento alle norme ed ai principi contenuti nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, cui l’Unione stessa ha aderito.
- La nozione di discriminazione. Il fattore religione e i legittimi requisiti occupazionali
Si è detto che la direttiva 2000/78/CE si propone di stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate – tra l’altro – sul fattore “religione o convinzioni personali” al fine di rendere effettivo il principio della parità di trattamento, da intendersi come «assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1». L’art. 2, par. 2, fornisce le definizioni di discriminazione diretta e indiretta.
Si ha discriminazione diretta «quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga». Essa si verifica quando, in relazione a un fattore di discriminazione, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga. Il giudizio coinvolge, dunque, situazioni passate[31], in atto e meramente ipotetiche. Ai fini del giudizio di discriminazione, fondamentale risulta nella discriminazione diretta la scelta del c.d. “comparatore”, ossia del soggetto considerato “in situazione analoga” rispetto a quello che lamenta la discriminazione. La comparazione implica l’individuazione di un soggetto che si trovi nelle medesime condizioni di quello potenzialmente discriminato, differenziandosi da quest’ultimo solo per l’assenza del fattore in questione (nel caso in esame, la religione).
Più complesso definire la discriminazione indiretta. A tal riguardo, l’art. 2, par. 2, alla lettera b) stabilisce che «sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che: i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; o che ii) nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all’articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi».
In tal caso, la discriminazione consegue a «una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri», ma tali da porre gli appartenenti a una data categoria in una «posizione di particolare svantaggio» rispetto ad altre persone, a meno che la diseguaglianza sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima perseguita con mezzi appropriati e necessari. Si è scritto – e l’affermazione appare condivisibile – che «il legislatore europeo accoglie una nozione di discriminazione indiretta piuttosto estesa, giacché essa prescinde sia dall’intenzione di nuocere ‒ essendo sufficiente una differenza di trattamento non assistita da una giustificazione obiettiva e ragionevole ‒ sia dall’elemento quantitativo, non rilevando l’entità e la materialità della ingiustificata differenziazione»[32].
L’art. 2, par. 3, della direttiva 2000/78/CE considera anche le molestie una forma di discriminazione, nel caso in cui il comportamento indesiderato, adottato per uno dei motivi di cui all’art. 1, abbia «lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo». La norma precisa che «in questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri». Il legislatore italiano, in sede di attuazione della direttiva in esame, ne ha fedelmente riprodotto il testo all’art. 2 del d. lgs. 9 luglio 2003 n. 216. Nell’assetto normativo tracciato dalle disposizioni riportate, il fattore religione è richiamato in maniera generica, nel senso che né il legislatore euro-unitario né il legislatore nazionale italiano fornisce una definizione di “religione”[33].
È tuttavia opinione condivisa in dottrina e giurisprudenza che il concetto di religione debba comprendere entrambi i fori e dunque sia le convinzioni personali in cui si sostanzia la fede di ciascuno (foro interno), sia gli atti di culto e i comportamenti direttamente riferibili all’osservanza di un precetto confessionale (foro esterno)[34]. In effetti, sia la CEDU che la Carta di Nizza attribuiscono alla nozione di religione un’accezione ampia, che include anche la libertà per le persone di manifestare la propria religione, sicché si deve ritenere che il legislatore dell’Unione abbia inteso mantenere lo stesso approccio nell’adottare la direttiva 2000/78/CE.
Ma cosa si intende per “manifestazione pubblica della fede religiosa”? Cosa è ricompreso nel c.d. forum externum e cosa no? Il tema del criterio con cui valutare se un dato comportamento possa o meno essere ricompreso nel concetto di manifestazione pubblica della fede religiosa (e, dunque, avere accesso alla tutela antidiscriminatoria) è tuttora oggetto di riflessione in dottrina: «l’adozione di una concezione ampia del fattore religione tale da comprendere anche le manifestazioni religiose non offre tuttavia alcuna indicazione su come stabilire cosa debba considerarsi manifestazione di sentimento religioso e cosa no. In altre parole se si debba in proposito adottare un criterio di valutazione oggettiva su quali pratiche siano comunemente considerate come espressione di precetti religiosi da parte di una determinata comunità religiosa o se si debba invece adottare un approccio di natura soggettiva che limita l’intervento della Corte alla presa d’atto delle motivazioni addotte a fondamento di un determinato comportamento dalla persona che lamenta di aver subito uno svantaggio collegato alla manifestazione delle proprie convinzioni religiose»[35].
La giurisprudenza della Corte di Giustizia, come si vedrà più avanti, sembra propendere per quest’ultimo tipo di approccio, in quanto qualifica l’utilizzo del velo come manifestazione religiosa sulla base del solo richiamo alle motivazioni esplicitate dalle ricorrenti, senza entrare nel merito del significato comunemente attribuito all’uso del velo nella religione islamica[36].
In effetti, scorrendo la giurisprudenza delle corti europee formatasi con riguardo al tema della libertà religiosa, si può notare che buona parte dei contenziosi ha ad oggetto proprio il tema del simbolismo: si va dalle questioni attinenti al velo islamico e, più in generale, all’abbigliamento (sia in spazi pubblici che sul posto di lavoro), all’esposizione del crocifisso nelle scuole (o, ancora una volta, sul posto di lavoro). È proprio in relazione a tali fattispecie che le corti europee si sono trovate a dover valutare sino a che punto sussiste una contrazione legittima al diritto di libertà religiosa e oltre quale soglia, invece, si possa parlare di discriminazione.
Nell’ambito di tale valutazione si deve, peraltro, tener conto della deroga di carattere generale stabilita dall’art. 4, par. 1, della direttiva 2000/78/CE (fedelmente recepito dal legislatore italiano), il quale consente agli Stati membri di ritenere che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei fattori di cui all’art. 1 non costituisca discriminazione in presenza di determinate condizioni: «fatto salvo l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato».
Si tratta dei c.d. “genuine occupational requirements”, in relazione ai quali molto si è scritto in dottrina in ragione delle criticità interpretative riconnesse al fatto che «il lessico utilizzato dal legislatore pare eccessivamente ampio nella portata»[37]. Sembra potersi ritenere, comunque, che la norma di cui alla disposizione in esame debba essere letta in combinato con il considerando n. 23 della direttiva medesima, secondo cui solo «in casi strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all’età o alle tendenze sessuali costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato»[38]. Il riferimento a «casi strettamente limitati» ivi contenuto consente di orientare l’interpretazione del requisito essenziale e determinante in senso evidentemente restrittivo, come tra l’altro confermato dalla prima giurisprudenza formatasi sull’argomento[39].
- La giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte EDU in materia di libertà religiosa e di discriminazione per motivi di religione
Al netto di quanto sinora esposto, la misura degli attuali approdi del diritto applicabile nello spazio europeo è dato dall’esame della giurisprudenza, che restituisce in concreto i tratti più veritieri del volto che oggi hanno assunto la libertà religiosa ed il divieto di discriminazione per motivi religiosi. Il “doppio binario” generato dai sistemi di diritto sviluppati dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo da un lato e dall’Unione Europea dall’altro rende utile analizzare separatamente la giurisprudenza delle due corti.
La Corte EDU ha competenza per tutte «le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli»[40] ed è giudice dei diritti e non dei principi, nel senso che «non impone agli Stati di essere o diventare laici o aconfessionali, ma di rispettare il diritto di libertà religiosa di tutti e, quindi, di comportarsi come “arbitri” imparziali nell’arena di tutte le fedi e di tutte le convinzioni, anche quelle degli atei, degli agnostici, degli scettici e degli indifferenti»[41]. Il suo sindacato, dunque, mira a censurare i comportamenti degli Stati che sacrifichino diritti contenuti nella Convenzione, oltre il limite invalicabile costituito dal margine di apprezzamento a ciascuno di essi riconosciuto[42]. La Corte EDU, nel valutare la norma interna ad uno degli Stati aderenti, ne verifica la compatibilità con la Convenzione. In tema di libertà religiosa, il margine di apprezzamento riservato – in termini piuttosto ampi – ai singoli Stati membri finisce nel momento in cui, per effetto della norma interna sub iudice, lo Stato stesso cessa di aver un approccio pluralista (art. 9, par. 2, Convenzione). Ciò significa che il diritto di libertà religiosa può essere limitato dal diritto interno[43], purché la restrizione sia giustificata da scopi legittimi (c.d. test di proporzionalità), come la salute pubblica o l’ordine pubblico interno, nella sua duplice accezione di ordine pubblico ideale[44] e ordine pubblico materiale[45].
Analizzando le pronunce della Corte EDU si deve tuttavia registrare che nella prima fase della vita della Corte sono praticamente assenti pronunce di condanna a carico degli Stati membri. Nei casi X c. Regno Unito[46], Karaduman c. Turchia[47], Phull c. Francia[48] e El Morsli c. Francia[49] la Corte EDU ha dichiarato irricevibili i ricorsi per manifesta infondatezza, mancando del tutto il giudizio di bilanciamento e il riconoscimento dell’esistenza di un’ingerenza nel diritto di libertà religiosa. Dalle prime aperture ad un effettivo bilanciamento tra diritto alla libertà religiosa e tutela dell’ordine pubblico interno (v. Dahlab c. Svizzera[50]), si sviluppa quindi un cambio di rotta nella giurisprudenza della Corte EDU, che inizia a mostrarsi decisamente più attenta nei confronti delle restrizioni del diritto in questione, soprattutto nei confronti di quelle legislazioni “anti velo”, che in alcuni Stati europei sono sorte all’indomani dell’11 settembre 2001.
Nei casi Arslan e altri c. Turchia[51] e S.A.S c. Francia[52] la Corte EDU circoscrive l’ambito di applicazione del principio della necessaria neutralità dello spazio pubblico (invocabile al fine di legittimare la misura restrittiva alla libertà religiosa) alle sole ipotesi in cui si tratti di spazio pubblico ‘istituzionale’ (scuola, università, tribunale, ospedali pubblici, ecc.), oppure quando si tratti di persone che ricoprono un ruolo ‘istituzionale’ (insegnanti, giudici, pubblici ufficiali, dipendenti pubblici ecc.). In particolare, con S.A.S c. Francia la Corte EDU restringe ancor più l’ambito di operatività del concetto di ordine pubblico materiale, chiarendo che lo stesso non supera il giudizio di compatibilità con l’art. 9 della Convenzione in assenza di elementi concreti di rischio per la pubblica sicurezza.
Nella stessa direzione le più recenti Hamidovic c. Bosnia Ervegovina[53] e Lachiri c. Belgio[54]. In entrambe le pronunce, la Corte EDU condanna lo Stato per la violazione del diritto di libertà religiosa, perché il contegno dei ricorrenti si era concretizzato in comportamenti non idonei in concreto a mettere in pericolo l’ordine pubblico materiale (sicurezza pubblica), nonostante lo stesso si fosse verificato in luogo pubblico “qualificato” (un’aula di Tribunale). Nella giurisprudenza della Corte EDU l’ambito di operatività dei c.d. scopi legittimi (che consentono agli Stati aderenti la limitazione del diritto di libertà religiosa) si è andato sempre più contraendo, dapprima con l’affermazione che i princìpi di laicità dello Stato e di neutralità dello spazio pubblico (ordine pubblico ideale) rappresentano “scopi legittimi” di contrazione del diritto di libertà religiosa solo nel caso di spazio pubblico qualificato (ad esempio, un tribunale) o di persona con un ruolo pubblico; quindi, con l’affermazione l’ordine pubblico materiale legittima la restrizione della libertà religione solo in presenza di concreti elementi su cui fondare la messa in pericolo della sicurezza pubblica.
Autonoma menzione merita, poi, il caso Eweida e altri c. Regno Unito, conclusosi con sentenza del 15 gennaio 2013, nel quale la Corte EDU è stata chiamata a pronunciarsi in fattispecie riguardante l’utilizzo di simboli religiosi sul luogo di lavoro[55]. La Corte EDU ritiene in tal caso illegittima ed irragionevole la limitazione della libertà religiosa imposta alla signora Eweida ed irrilevante l’assenza di un obbligo per la religione cattolica di indossare tale simbolo religioso, adeguatamente valorizzando in sede di bilanciamento il diritto alla libertà di religione rispetto all’interesse del datore di lavoro di definire una propria immagine aziendale: «On one side of the scales was Ms Eweida’s desire to manifest her religious belief. As previously noted, this is a fundamental right: because a healthy democratic society needs to tolerate and sustain pluralism and diversity; but also because of the value to an individual who has made religion a central tenet of his or her life to be able to communicate that belief to others. On the other side of the scales was the employer’s wish to project a certain corporate image»[56].
Se, dunque, si deve registrare una progressiva valorizzazione del diritto di libertà religiosa (soprattutto con riferimento alla sua esplicazione nell’utilizzo di un particolare abbigliamento o di simboli religioni) nella giurisprudenza della Corte EDU, la stessa cosa non si può dire con riferimento al percorso evolutivo della Corte di Giustizia europea, la cui giurisprudenza si è rivelata, per il vero, ben poco feconda, anche in ragione dei limiti al sindacato in materia, già evidenziati in precedenza. Si deve peraltro sin d’ora anticipare che i contenziosi riguardanti i princìpi di parità di trattamento e di non discriminazione sul posto di lavoro per motivi di religione hanno, nell’ultimo decennio, avuto il pregio di portare all’attenzione della Corte di Giustizia le questioni attinenti la libertà religiosa, stimolandone il sindacato, ma ne hanno altresì costituito il limite, in quanto in questa prima esperienza la Corte di Lussemburgo si è ben guardata dal valorizzare il principio portato dall’art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione, appiattendo le proprie riflessioni sul più sterile bilanciamento tra il principio di libertà d’impresa (anch’esso contenuto nella Carta di Nizza)[57] e i criteri antidiscriminatori portati dalla direttiva 2000/78/CE.
Il tema si impone all’attenzione della Corte di Lussemburgo in due casi che presentano tratti comuni, quelli delle signore Achbita[58] (receptionist presso la società belga G4S) e Bougnaoui[59] (ingegnere progettista presso la società francese Micropole SA). In entrambi i casi le ricorrenti, di religione musulmana, subiscono il licenziamento in conseguenza della loro scelta di indossare il velo sul posto di lavoro. Nel caso della signora Achbita la ricorrente viene licenziata per la violazione della norma – dapprima non scritta, poi formalizzata in un regolamento aziendale – che impone ai dipendenti della G4S il divieto di «indossare sul luogo di lavoro segni visibili delle loro convinzioni politiche, filosofiche o religiose e/o manifestare qualsiasi rituale che ne derivi» e lamenta una discriminazione diretta, ai sensi dell’art. 2, par. 2, lett. a). La signora Bougnaoui, invece, viene licenziata in conseguenza delle doglianze di un cliente dell’azienda sua datrice di lavoro, che avrebbe preteso di non interloquire con personale che indossa il velo islamico; con il ricorso la Corte EDU è chiamata a verificare se la volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di un cliente che i servizi di tale datore di lavoro non siano più assicurati da una dipendente che indossa un velo islamico possa essere considerato come un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 4, par. 1, della direttiva 2000/78/CE.
Con la sentenza EU:C:2017:203, resa nel caso Achbita, la Corte di Giustizia, conclude che l’esistenza di una politica generale di neutralità che vieta a tutti i dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni esteriori di convinzioni politiche, filosofiche e religiose non costituisce una discriminazione diretta in base alla religione, in quanto il divieto di indossare segni visibili delle proprie convinzioni, posto dal regolamento aziendale in contestazione, ha ad oggetto qualsiasi manifestazione di tali convinzioni, “senza distinzione alcuna” tra opinioni filosofiche, politiche o religiose. Il regolamento aziendale non incide, dunque, direttamente sulla lavoratrice che assume di essere stata discriminata.
Benché priva di motivazioni di ampio respiro sul tema della libertà religiosa, la sentenza in menzione ha comunque il pregio di non limitare il proprio esame alla discriminazione diretta (unica sottopostale dall’Hof van Cassatie belga, giudice a quo), producendosi anche in una disamina del tema della discriminazione indiretta; per far ciò, la Corte di Lussemburgo si avvale di quella costante giurisprudenza, secondo cui «la circostanza che il giudice del rinvio abbia formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento soltanto a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possano essere utili alla decisione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto riferimento o meno nella formulazione delle sue questioni».
Per la Corte di Giustizia nel caso in questione da un lato non è escluso che «il giudice del rinvio possa arrivare alla conclusione che la norma interna di cui al procedimento principale istituisce una disparità di trattamento indirettamente fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, qualora venga dimostrato, il che spetta a tale giudice verificare, che l’obbligo apparentemente neutro in essa contenuto comporti, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia». D’altro canto, sempre ad avviso dei giudici di Lussemburgo, non potrebbe neppure escludersi che «siffatta disparità di trattamento non costituirebbe tuttavia una discriminazione indiretta, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva, qualora fosse oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento fossero appropriati e necessari».
La Corte definisce, quindi, gli elementi costituitivi della fattispecie che consente la disparità di trattamento in esame. Anzitutto la “finalità legittima”, in relazione alla quale ritiene che «la volontà di mostrare, nei rapporti con i clienti sia pubblici che privati, una politica di neutralità politica, filosofica o religiosa, deve essere considerata legittima», perseguendo la via dell’art. 16 della Carta di Nizza, che espressamente riconosce la libertà d’impresa[60]. Quindi, il “carattere appropriato” della norma in contestazione, con riguardo la quale ritiene che «il fatto di vietare ai lavoratori di indossare in modo visibile segni di convinzioni politiche, filosofiche o religiose è idoneo ad assicurare la corretta applicazione di una politica di neutralità, a condizione che tale politica sia realmente perseguita in modo coerente e sistematico».
Da ultimo, il “carattere necessario” del divieto imposto ai lavoratori, rispetto al quale così argomenta: «occorre verificare se il divieto di indossare in modo visibile qualsiasi segno o indumento che possa essere associato ad un credo religioso oppure ad una convinzione politica o filosofica interessi unicamente i dipendenti della G4S che hanno rapporti con i clienti. In caso affermativo, detto divieto deve essere considerato strettamente necessario per il conseguimento della finalità perseguita» (la valutazione è rimessa, come detto, al giudice a quo). Con la sentenza EU:C:2017:204, resa nel caso Bougnaoui, la Corte di Giustizia dapprima rinvia a quanto esposto in EU:C:2017:203 sulla discriminazione indiretta, quindi esclude ogni rilevanza all’interesse del datore di lavoro di tenere in considerazione i desiderata dei propri clienti e, per quel che concerne la discriminazione diretta, conclude che non ricorre l’ipotesi del requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa di cui all’art. 4, par. 1, della direttiva 2000/78/CE. Quest’ultima nozione «rinvia a un requisito oggettivamente dettato dalla natura o dal contesto in cui l’attività lavorativa in questione viene espletata. Essa, per contro, non può includere considerazioni soggettive, quali la volontà del datore di lavoro di tener conto dei desideri particolari del cliente». In questo caso l’imprinting dell’interesse dell’imprenditore sulla disciplina del rapporto di lavoro viene dunque contenuto nei limiti della rilevanza oggettiva del requisito essenziale e determinante, con conseguente esclusione di ogni rilevanza per la componente soggettiva.
A di là di queste due pronunce e di due ulteriori sentenze rese in tema di organizzazioni di tendenza (la cui trattazione si rinvia al seguente paragrafo), sul tema c’è ben poco nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. Nell’ultima pronuncia resa, la Corte di Giustizia si è trovata a dover esaminare l’art. 7 par. 3 dell’Arbeitsruhegesetz (c.d. ARG, ossia la legge austriaca in materia di periodi di riposo, BGBl. 144/1983), il quale stabilisce che il Venerdì santo è un giorno festivo retribuito, con un periodo di riposo di 24 ore, solo per i membri delle Chiese evangeliche di confessione augustana e di confessione elvetica, della Chiesa vetero-cattolica e della Chiesa evangelica metodista. Se, tuttavia, un membro di una di tali Chiese lavora in tale giorno, egli ha diritto a una retribuzione supplementare per detto giorno festivo (una indennità per giorno festivo).
Il ricorrente, signor Achatzi, dipendente di una agenzia di investigazioni private, non è membro di alcuna delle Chiese in questione e ritiene di essere stato discriminato per effetto di detta norma. Sicché evoca in giudizio il suo datore di lavoro, la Cresco, per chiedere il pagamento della somma di € 109,09 oltre interessi (importo pari a quello previsto per la suddetta indennità per giorno festivo). Il giudizio giunge innanzi l’Oberster Gerichtshof (la Corte suprema austriaca), che decide di sospenderlo e sottoporre alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 21 della [Carta], in combinato disposto con gli articoli 1 e 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva [2000/78], debba essere interpretato nel senso che, in una controversia tra lavoratore e datore di lavoro in relazione a un rapporto di lavoro privato, esso osta a una normativa nazionale secondo la quale soltanto per gli appartenenti alle Chiese evangeliche di confessione augustana e di confessione elvetica, della Chiesa vetero-cattolica e della Chiesa evangelica metodista anche il Venerdì santo è un giorno festivo con un periodo di riposo ininterrotto di almeno 24 ore e, in caso di impiego del lavoratore nonostante il riposo festivo, oltre al diritto alla retribuzione per il tempo di lavoro non prestato a causa del giorno festivo, viene riconosciuto anche un diritto alla retribuzione per il lavoro prestato, mentre ciò non avviene per altri lavoratori, non appartenenti a tali chiese. 2) Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 21 della [Carta], in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva [2000/78], debba essere interpretato nel senso che detta direttiva non osta alla normativa nazionale descritta nella prima questione, la quale riconosce diritti soltanto a un gruppo relativamente ristretto, se rapportato alla popolazione totale e all’appartenenza della maggioranza alla Chiesa romano-cattolica, di appartenenti a determinate (altre) chiese, poiché si tratta di una misura che, in una società democratica, è necessaria per la tutela dei diritti e delle libertà altrui, in particolare del diritto alla libertà religiosa. 3) Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 21 della [Carta], in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2000/78], debba essere interpretato nel senso che la normativa nazionale esposta nella prima questione costituisce una misura positiva e specifica in favore degli appartenenti alle chiese indicate nella prima questione, allo scopo di assicurare la loro completa parità nella vita professionale, per prevenire o compensare, per tali appartenenti, svantaggi in ragione della religione, se in tal modo viene loro riconosciuto il medesimo diritto di esercitare la religione durante l’orario di lavoro in una festività solenne per tale religione, quale quello che in base a una diversa normativa nazionale sussiste in capo alla maggioranza dei lavoratori per il fatto che i giorni festivi della religione, nella quale la maggioranza dei lavoratori si riconosce, sono giorni di riposo in generale».
In tal caso la Corte di Giustizia ritiene che la normativa sottoposta al suo esame istituisca una differenza di trattamento fondata direttamente sulla religione dei lavoratori, perché il criterio di differenziazione cui essa ricorre deriva direttamente dall’appartenenza dei lavoratori a una determinata religione. Focalizza poi la sua attenzione sul fatto che la concessione di un giorno festivo (il Venerdì santo) a un lavoratore appartenente ad una delle Chiese indicate nell’ARG non è subordinata alla condizione dell’adempimento, da parte del lavoratore, di un obbligo religioso determinato nel corso di tale giornata, ma unicamente all’appartenenza formale di detto lavoratore ad una di tali Chiese. Tale lavoratore resta pertanto libero di disporre a proprio piacimento, ad esempio a fini di riposo o di svago, del periodo relativo a tale giorno festivo.
La Corte, peraltro, esclude che tale discriminazione diretta possa essere giustificata sulla base dell’articolo 2, paragrafo 5[61], della direttiva 2000/78/CE o dell’articolo 7, paragrafo 1[62], della medesima direttiva. Essa pertanto conclude che «gli articoli 1 e 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale in virtù della quale, da un lato, il Venerdì santo è un giorno festivo solo per i lavoratori appartenenti a talune chiese cristiane e, dall’altro, solo tali lavoratori hanno diritto, se chiamati a lavorare in tale giorno festivo, a un’indennità per giorno festivo costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione, e le misure previste da tale normativa nazionale non possono essere considerate né misure necessarie alla preservazione dei diritti e delle libertà altrui, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, di detta direttiva, né misure specifiche destinate a compensare svantaggi correlati alla religione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva».
Ancora una volta la motivazione con cui la Corte di Giustizia sorregge tali conclusioni è ben poca cosa rispetto alle opportunità offerte dal caso in esame. E soprattutto il richiamo all’assenza di uno specifico adempimento a contenuto religioso in capo ai lavoratori interessati dalla disposizione sul Venerdì santo da un lato non considera che anche il semplice riposo e l’astensione dal lavoro possono – per gli adepti di alcune confessioni – costituire adempimento ad un precetto religioso, dall’altro «svuota di significato la motivazione religiosa della mera astensione dal lavoro e mostra di valutare in eguale modo un’astensione sorretta da una ricorrenza religiosa e un’astensione sorretta dal desiderio di svago o di riposo. Questo ragionamento, indipendentemente dagli esiti più o meno corretti ai quali giunge in relazione all’applicazione della direttiva 2000/78, trascura che il diritto di libertà religiosa è dotato di uno specifico riconoscimento nello spazio europeo. L’art. 10 della Carta dei diritti ci dice che la libertà di esercitare la propria fede religiosa è un diritto fondamentale per tutti e, quindi, la conclusione di relegarlo a mero adempimento di un “obbligo religioso” avrebbe necessitato quantomeno di un approfondimento sui contenuti del diritto e di un successivo bilanciamento degli interessi in gioco»[63].
- Le differenze di trattamento nel caso delle attività professionali delle Chiese e organizzazioni di tendenza
L’art. 4, par. 2, della direttive 2000/78/CE prevede che «Gli Stati membri possono mantenere nella legislazione nazionale in vigore alla data d’adozione della presente direttiva o prevedere in una futura legislazione che riprenda prassi nazionali vigenti alla data d’adozione della presente direttiva, disposizioni in virtù delle quali, nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali non costituisca discriminazione laddove, per la natura di tali attività, o per il contesto in cui vengono espletate, la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione. Tale differenza di trattamento si applica tenuto conto delle disposizioni e dei principi costituzionali degli Stati membri, nonché dei principi generali del diritto comunitario, e non può giustificare una discriminazione basata su altri motivi. A condizione che le sue disposizioni siano d’altra parte rispettate, la presente direttiva non pregiudica pertanto il diritto delle chiese o delle altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, e che agiscono in conformità delle disposizioni costituzionali e legislative nazionali, di esigere dalle persone che sono alle loro dipendenze un atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell’etica dell’organizzazione».
Con la disposizione in menzione il legislatore comunitario ha inteso dare rilevanza alla dichiarazione n. 11 annessa all’atto finale del Trattato di Amsterdam (“Dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali”) a mente della quale «l’Unione Europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri. L’Unione Europea rispetta ugualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali».
Viene così stabilita un’eccezione al divieto di discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, il cui ambito di operatività a tutt’oggi non risulta ben chiaro, se la si raffronta alla generale eccezione prevista dall’art. 4, par. 1, della medesima direttiva 2000/78/CE (v. § 3 in tema di legittimi requisiti occupazionali).
Per non concludere che il par. 2 dell’art. 4 fosse una mera specificazione del precedente par. 1, in un primo momento la dottrina aveva ipotizzato che la deroga al principio della parità di trattamento accordata dall’art. 4 par. 2 alle Chiese e alle organizzazioni di tendenza fosse più ampia rispetto alla quella generale prevista dall’art. 4 par.1 in quanto non sarebbe stato necessario rispettare il principio di proporzionalità cui invece era vincolata l’eccezione di cui all’art. 4 par. 1[64]. Tale interpretazione è stata tuttavia smentita dalla prima giurisprudenza formatasi sull’argomento, secondo cui «il requisito di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 deve essere conforme al principio di proporzionalità. Infatti, se è vero che tale disposizione non prevede espressamente, a differenza dell’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva, che tale requisito debba essere “proporzionato”, essa dispone tuttavia che qualsiasi differenza di trattamento deve essere effettuata nel rispetto, in particolare, dei “principi generali del diritto comunitario”. Dal momento che il principio di proporzionalità rientra tra i principi generali del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 2014, Siragusa, C-206/13, EU:C:2014:126, punto 34 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 9 luglio 2015, K e A, C- 153/14, EU:C:2015:453, punto 51)»[65].
Nel caso di attività professionali di Chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali è dunque concessa una differenza di trattamento quando, per la natura dell’attività svolta o per il contesto in cui la stessa viene espletata, la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione. Il contesto nel quale opera la norma in esame ruota integralmente attorno al polo della libertà di religione: da un lato la libertà di religione esplicata in termini collettivi, di gruppo, che rivendica il diritto di stabilire le condizioni di accesso e di permanenza nella struttura di tendenza; dall’altro la libertà di religione esplicata nella sua forma individuale, del singolo, che rivendica il diritto a non essere discriminato per la sua appartenenza o non appartenenza ad una determinata fede religiosa. Il tutto è, poi, ancor più complicato dal fatto che la religione e le convinzioni personali sono fattori che – a differenza di tutti gli altri fattori contemplati dalla direttiva 2000/78/CE – non attengono a caratteristiche personali immutabili, ma al sentire più intimo di ciascuna persona, come tale mutevole.
Il tema della discriminazione per motivi di religione nelle organizzazioni di tendenza è giunto di recente all’attenzione della Corte di Giustizia europea, che lo ha esaminato in due diverse fattispecie, l’una relativa ad una procedura di assunzione e l’altra concernente la verifica circa la legittimità di un licenziamento determinato dal venir meno del requisito della buona fede e lealtà nei confronti dell’etica dell’organizzazione. Nella prima delle due fattispecie[66] in menzione l’Evangelisches Werk pubblicava un’offerta di lavoro a tempo determinato per un progetto relativo alla stesura di una relazione parallela avente ad oggetto la convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. Detta offerta di lavoro richiedeva, tra i requisiti che i candidati avrebbero dovuto soddisfare «l’appartenenza a una Chiesa evangelica oppure a una Chiesa rientrante nell’Associazione delle Chiese cristiane in Germania, nonché l’identificazione con la missione assistenziale-caritatevole della Diaconia».
La signora Vera Egenberger, pur priva del menzionato requisito, decideva di partecipare alla selezione e, conclusa la stessa con esito per lei negativo, evocava la Evangelisches Werk innanzi l’Arbeitsgericht Berlin (il Tribunale del lavoro di Berlino), sostenendo che la rilevanza attribuita alla religione nella procedura di assunzione, rinvenibile nell’offerta di lavoro in questione, non era compatibile con il divieto di discriminazione sancito dall’AGG, l’Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (legge generale sulla parità di trattamento) del 14 agosto 2006, con cui era stata recepita in Germania la direttiva 2000/78/CE. Chiedeva, pertanto, che la resistente fosse condannata al risarcimento del danno, quantificato in € 9.788,65.
Resisteva nel giudizio l’Evangelisches Werk deducendo che, nel caso di specie, una differenza di trattamento basata sulla religione era giustificata ai sensi dell’art. 9 par. 1 dell’AGG[67]. Il diritto di imporre l’appartenenza a una Chiesa cristiana sarebbe rientrato, secondo l’Evangelisches Werk, nel diritto all’autodeterminazione della Chiesa, tutelato dall’art. 140 del Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania), in combinato disposto con l’art. 137 par. 3 della Weimarer Reichsverfassung (Costituzione di Weimar). Siffatto diritto sarebbe conforme al diritto dell’Unione a motivo, in particolare, delle disposizioni dell’art. 17 TFUE. Inoltre, l’appartenenza religiosa costituirebbe, data la natura dell’attività considerata nell’offerta di lavoro, un requisito giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto delle regole della coscienza ecclesiale dell’Evangelisches Werk.
Dopo un primo grado di giudizio parzialmente favorevole alla ricorrente, la controversia giunge innanzi al Bundesarbeitsgericht (la Corte federale del lavoro tedesca), che nel sollevare la questione pregiudiziale avanti la Corte di Giustizia europea concentra la propria attenzione sulla circostanza che «non si può dedurre né dalla formulazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 né dai considerando di tale direttiva che un datore di lavoro quale l’Evangelisches Werk può determinare esso stesso, in modo definitivo, che la religione costituisca, indipendentemente dalla natura dell’attività in questione, un requisito giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica di tale datore di lavoro, e che i giudici nazionali possano esercitare, al riguardo, solo un semplice controllo di plausibilità. Al contrario, il riferimento, in tale disposizione, al fatto che la religione debba costituire un “requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione” potrebbe deporre a favore di una competenza e di un obbligo di controllo dei giudici nazionali che vadano oltre un semplice controllo di plausibilità».
E, in effetti, la Corte di Lussemburgo, tralasciando ancora una volta di connotare e delimitare l’ambito di estensione del diritto alla libertà religiosa esercitata in forma collettiva ed in forma individuale, svolge il proprio approfondimento solo in relazione alla specifica questione sottopostale, giungendo alla conclusione che «qualora una Chiesa o un’altra organizzazione la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali faccia valere, a sostegno di un atto o di una decisione quale il rigetto di una candidatura a un posto di lavoro al suo interno, che, per la natura delle attività di cui trattasi o per il contesto in cui tali attività devono essere espletate, la religione costituisce un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica di tale Chiesa od organizzazione, una siffatta affermazione deve, se del caso, poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo al fine di assicurarsi che, nel caso di specie, siano soddisfatti i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78». Più nello specifico, secondo la Corte di Giustizia europea, una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali «è subordinata all’esistenza oggettivamente verificabile di un nesso diretto tra il requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa imposto dal datore di lavoro e l’attività in questione. Un tale nesso può derivare vuoi dalla natura di tale attività, ad esempio qualora essa comporti di partecipare alla determinazione dell’etica della Chiesa o dell’organizzazione in questione, o di collaborare alla sua missione di proclamazione, vuoi dalle condizioni in cui tale attività deve essere espletata, come la necessità di garantire una rappresentanza credibile della Chiesa o dell’organizzazione all’esterno della stessa».
La Corte ribadisce, poi, che tale requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa deve essere, come richiesto dall’articolo 4 par. 2 della direttiva 2000/78, “essenziale, legittimo e giustificato”, tenuto conto dell’etica della Chiesa o dell’organizzazione, fornendo una puntuale definizione della terna ora riportata[68]. Un percorso argomentativo sostanzialmente analogo è svolto dalla Corte di Giustizia europea nel secondo caso concernente un’organizzazione di cui all’art. 4 par. 2 della direttiva 2000/78/CE[69]. Il caso, che ha ad oggetto ancora una volta la normativa tedesca, è quello di un medico cattolico, dipendente (con la qualifica di primario del reparto di medicina interna) di una società privata che gestisce ospedali e che come oggetto sociale si propone la realizzazione dei compiti della Caritas.
Dopo aver avuto notizia del divorzio del medico dalla prima moglie e di un secondo matrimonio contratto dal medesimo, la società datrice di lavoro decide di licenziarlo, in considerazione del fatto che «contraendo un matrimonio nullo per il diritto canonico sarebbe in tal modo gravemente venuto meno agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro». Il medico impugna il licenziamento sostenendo che lo stesso sarebbe contrario al principio di parità di trattamento, poiché per i primari di confessione protestante o atei dipendenti della medesima struttura un secondo matrimonio non avrebbe prodotto alcuna conseguenza giuridica sul loro rapporto di lavoro.
Il Bundesarbeitsgericht (la Corte federale del lavoro) rinvia la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia chiedendo «se le chiese, o altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, possano determinare loro stesse, in maniera definitiva, cosa costituisce un atteggiamento di lealtà e di correttezza “nei confronti dell’etica dell’organizzazione”, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2000/78, e se esse possano altresì, su tale questione, prevedere in maniera autonoma – come è consentito dal diritto costituzionale tedesco – una graduazione degli obblighi di lealtà per le stesse funzioni direttive unicamente tenendo conto della confessione dei dipendenti».
Nella disamina della fattispecie la Corte di Giustizia muove dalla considerazione che l’adesione alla concezione cattolica del matrimonio religioso, sacro e indissolubile, non appare necessaria per l’affermazione dell’etica dell’organizzazione resistente, tenuto conto del fatto che le attività professionali sono svolte dal ricorrente in ambito ospedaliero. Essa non risulta quindi essere una condizione essenziale dell’attività professionale, a norma dell’art. 4 par. 2 co. 1 della direttiva 2000/78/CE, circostanza che compete tuttavia al giudice del rinvio verificare. Ne derivano le seguenti conclusioni «da un lato, una chiesa o un’altra organizzazione la cui etica sia fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, e che gestisce una struttura ospedaliera costituita in forma di società di capitali di diritto privato, non può decidere di sottoporre i suoi dipendenti operanti a livello direttivo a obblighi di atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti di tale etica diversi in funzione della confessione o agnosticismo di tali dipendenti, senza che tale decisione possa, se del caso, essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo al fine di assicurare che siano soddisfatti i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva; e ‒ dall’altro ‒ una differenza di trattamento, in termini di obblighi di atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti di detta etica, tra dipendenti in posizioni direttive, in funzione della loro confessione o agnosticismo, è conforme alla suddetta direttiva solo se, tenuto conto della natura delle attività professionali interessate o del contesto in cui sono esercitate, la religione o le convinzioni personali costituiscono un requisito professionale essenziale, legittimo e giustificato rispetto all’etica della chiesa o dell’organizzazione in questione e conforme al principio di proporzionalità, il che spetta al giudice nazionale verificare».
Nel contesto nazionale italiano la norma di cui all’art. 4, par. 2, della direttiva 2000/78/CE è stata trasposta nell’art. 3, comma 5, del d. lgs. 9 luglio 2003 n. 216: «non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell’articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell’àmbito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività». Si deve segnalare in proposito che la disposizione in questione ha suscitato perplessità in dottrina, a causa dello scostamento rispetto a quanto previsto dal legislatore comunitario in ordine ai soggetti ammessi a beneficiare della deroga di cui all’art. 3, comma 5, in menzione, che sono gli enti religiosi e le altre organizzazioni pubbliche e private. Il legislatore italiano ha infatti omesso di recepire l’inciso «la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali», contenuto invece nella direttiva 2000/78/CE, con il rischio di dilatare la categoria dei soggetti fruitori di tale beneficio, «rendendo astrattamente possibile che possano goderne anche quelle organizzazioni che svolgono attività che non hanno natura ideologica, ma in relazione alle quali «la religione e le convinzioni personali assumono comunque un forte grado di significatività»[70].
- Conclusioni
Il quadro che si è descritto raffigura un contesto normativo e giurisprudenziale a “geometria variabile”, nel quale il diritto alla libertà religiosa (in tutte le sue facoltà ed accezioni) fatica ad affermarsi con pienezza. Se da un lato si raccolgono maggiori aperture nella giurisprudenza della Corte EDU, dall’altro le logiche di natura economica che dominano l’assetto istituzionale dell’Unione Europea costituiscono un freno per i diritti fondamentali che con tali logiche entrano in contrasto. La rassegna dei casi presentata in questo lavoro evidenzia nelle pronunce della Corte di Giustizia europea un equilibrismo giuridico figlio del tentativo di procedere su una linea, che appare troppo sottile per consentirle percorsi di lunga durata. Contenere la portata delle proprie decisioni nei ristretti ambiti offerti dalle nozioni contenute nella direttiva 2000/78/CE appare un artifizio assai difficoltoso per reggere agli scossoni che arrivano dalle stesse istanze antidiscriminatorie e che reclamano una risposta connotata da adeguate riflessioni di sistema. È, in questo senso, auspicabile che i giudici di Lussemburgo guardino all’assetto normativo euro-unitario in chiave organica più che di tecnica giuridica, di princìpi più che di meccanismi.
Solo così si potrà arrivare a valorizzare la nozione di libertà religiosa contenuta nell’art. 10 della Carta di Nizza e nell’art. 9 della CEDU anche attraverso la chiave di accesso offerta dal paradigma antidiscriminatorio di cui alla direttiva 2000/78/CE. Il mondo del lavoro, come il relativo mercato, è in continua evoluzione e l’Occidente democratico e pluralista si deve far trovare pronto alle sfide che impongono i fenomeni migratori, ormai generazionali. L’integrazione, anzitutto; anche sul posto di lavoro, anche attraverso la gestione equilibrata delle necessità che ai lavoratori derivano dalla loro appartenenza religiosa. Deve farlo affrontando con coraggio tutte le questioni, senza timore di mettere in discussione lo stesso codice valoriale che ha sinora ispirato l’azione dell’Unione Europea. Se penso alle sfide del prossimo trentennio, il motore “economico” che ha dato impulso all’Europa potrebbe non essere sufficiente a dare ai cittadini le risposte che attendono in termini di integrazione. La partita si gioca sul tavolo dei diritti umani e delle libertà ad essi riconnesse, e la comunità europea, nata da un’esigenza di pace, reggerà solamente se comprenderà che «la pace fiorisce quando tali diritti vengono osservati integralmente»[71].
* Contributo sottoposto a valutazione.
[1] P. Davis, Preliminary Remarks, in S. Sciarra (a cura di), Labour Law in Courts: National Judges and the European Court of Justice, Hart Publisching, Oxford-Portland, 2001, p. 133. Il tema è ripreso anche da M. Barbera, Introduzione Il Nuovo diritto antidiscriminatorio: innovazione e continuità, in M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, Milano, 2007, p. xxv.
[2] A. Borghi, Sulla libertà di manifestare le proprie opinioni religiose nel luogo di lavoro: brevi note in merito ai casi Achbita e Bougnaoui, in Stato, Chiese e Pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2019, n. 32, p. 25.
[3] A. Borghi, op. cit., p. 4.
[4] L. Saporito – F. Sorvillo – L. Decimo, Lavoro, discriminazioni religiose e politiche d’integrazione, in Stato, Chiese e Pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2017, n. 18, p. 2.
[5] Si legga in tal senso la Dichiarazione sulla Libertà Religiosa Dignitatis Humanae del 7 dicembre 1965: «Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa». Su rapporto tra la Dichiarazione Dignitas Humanae di Paolo VI e l’affermazione contenuta nell’enciclica Libertas di Leone XIII, secondo cui la libertà di culto «nuoce alla libertà vera dei governi e dei popoli», si rimanda a M. Introvigne, La dottrina sociale di Leone XIII, Fede & Cultura, iBooks, 2010, pp. 25-26: «Nel discorso del 22 dicembre 2005 alla Curia Romana, indispensabile per tutta la questione dell’interpretazione dei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II – a proposito della quale va sempre evitata una “ermeneutica della discontinuità e della rottura” (Benedetto XVI 2005) rispetto al Magistero precedente –, Benedetto XVI ammette una “apparente discontinuità” in tema di libertà religiosa, ma spiega che questa discontinuità, se e dove c’è, non si riferisce ai principi ma alla loro applicazione alle forme storiche concrete, che mutano nel tempo mentre i principi non possono mutare. Infatti “i principi esprimono l’aspetto duraturo, rimanendo nel sottofondo e motivando la decisione dal di dentro. Non sono invece ugualmente permanenti le forme concrete, che dipendono dalla situazione storica e possono quindi essere sottoposte a mutamenti. Così le decisioni di fondo possono restare valide, mentre le forme della loro applicazione a contesti nuovi possono cambiare. Così, ad esempio, se la libertà di religione viene considerata come espressione dell’incapacità dell’uomo di trovare la verità e di conseguenza diventa canonizzazione del relativismo, allora essa da necessità sociale e storica è elevata in modo improprio a livello metafisico ed è così privata del suo vero senso, con la conseguenza di non poter essere accettata da colui che crede che l’uomo è capace di conoscere la verità di Dio e, in base alla dignità interiore della verità, è legato a tale conoscenza. Una cosa completamente diversa è invece il considerare la libertà di religione come una necessità derivante dalla convivenza umana, anzi come una conseguenza intrinseca della verità che non può essere imposta dall’esterno, ma deve essere fatta propria dall’uomo solo mediante il processo del convincimento” (ibid.)».
[6] F. D’Agostino, Diritto e religione, Roma, 2013, p. 73 ss., che sottolinea «la necessità che tra il paradigma dei DDUU e quello delle RRII (Religioni Istituzionalizzate, ndr) si diano nuove possibilità di dialogo, capaci di produrre una profonda e sincera sinergia. Condizione preliminare non può evidentemente che essere quella della disponibilità ad un reciproco riconoscimento e ad un apprendimento reciproco (secondo il modello emerso nel dialogo tra Jurgen Habermas e Joseph Ratzinger del 19 gennaio 2004 all’Accademia cattolica bavarese)».
[7] L. Saporito – F. Sorvillo – L. Decimo, op. cit., p. 4.
[8] Secondo quanto riportato nel Rapporto 2018 sulla libertà religiosa nel mondo realizzato da Aiuto alla Chiesa che Soffre – Onlus, in Siria benché formalmente l’articolo 33 della Costituzione preveda che «i cittadini devono essere uguali nei diritti e nei doveri senza discriminazioni in base al sesso, all’origine, alla lingua, alla religione o al credo» e l’articolo 42 affermi che «la libertà di credo deve essere protetta ai sensi della legge», di fatto «il governo limita il proselitismo e le conversioni e vieta la conversione dei musulmani ad altre religioni, ritenuta contraria alla shari’a. Mentre le conversioni dall’Islam al Cristianesimo non sono consentite, il governo riconosce quelle dei cristiani all’Islam». Cfr. ACS-Aiuto alla Chiesa che Soffre, in https://bit.ly/2TNc7Dw.
[9] G. Puppinck, Il caso Lautsi contro Italia, in Stato, Chiese e Pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2012, p. 7.
[10] G. Puppinck, op. cit., p. 16.
[11] Intervento di Sergio Busetto, Ambasciatore d’Italia, al seminario organizzato da l’ECLJ, CNR e Ambasciata d’Italia al Consiglio d’Europa del 30 aprile 2010.
[12] Si legga, in proposito, la citata sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 18 marzo 2011 – ricorso n. 30814/06 – Lautsi e altri c. Italia.
[13] L. Saporito – F. Sorvillo – L. Decimo, op. cit., p. 2.
[14] L. Saporito- F. Sorvillo- L. Decimo, op. cit., p. 4.
[15] Tipico il caso dei fedeli musulmani, cui è inibito l’utilizzo di bevande alcoliche e carne suina.
[16] Cfr., in proposito, E. Sigalow – M. Shain – M.R. Bergey, Religion and Decisions about Marriage, Residence, Occupation, and Children, in Journal for the Scientific Study of Religion, 2012, 51, pp. 304-323.
[17] Il tema dell’incidenza del fattore religioso sulle scelte di carattere lavorativo è ben sviluppato in L. Saporito – F. Sorvillo – L. Decimo, op. cit., pp. 5-10: «la religione islamica induce le donne musulmane a prediligere lavori per i quali sia particolarmente limitato il contatto con uomini estranei alla famiglia. Pertanto, nel settore della ristorazione è diffusa la prassi delle donne musulmane di lavorare all’interno delle cucine e non in sala a contatto diretto con il pubblico. Passando ad altro settore lavorativo, sempre secondo i precetti della religione islamica è vietato il lavoro all’interno delle banche occidentali le quali prevedono l’applicazione di tassi d’interesse attivi o passivi. Da ciò deriva la specifica esclusione nell’impiego bancario poiché la maggior parte degli strumenti finanziari e istituti giuridici europei sono in contrasto con il divieto di ribā. Ciò, secondo la dottrina musulmana rende i proventi derivanti dalle loro attività completamente haram. Volgendo lo sguardo ad altre fedi religiose l’orizzonte rimane invariato. Il forte rifiuto della violenza e l’esortazione a una vita pacifista induce i fedeli buddhisti a non prediligere l’accesso a carriere lavorative per le quali sono richiesti comportamenti e/o azioni violente. Di conseguenza, sono escluse nelle scelte individuali lavorative tutti gli impieghi legati alle carriere militari (terrestri e aeronavali), nelle forze dell’ordine o anche in qualsiasi istituto di vigilanza privata». In argomento cfr. anche A. D Oto, Precetti religiosi e mondo del lavoro, Roma, 2007, p. 110 ss.; S. Coglievina, Festività religiose e riposi settimanali nelle società multiculturali, in Riv. it. dir. del lav., 2008, 3, p. 375. A. Occhino, Orari flessibili e libertà, in Riv. it. dir. del lav., 2012, 1, p.169 ss.
[18] M. Barbera, Introduzione Il Nuovo diritto antidiscriminatorio: innovazione e continuità, in M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, Milano, 2007, pp. xxiv-xxv.
[19] Per un approfondimento in tema di Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si rimanda a F. J. Borrego Borrego, Il tribunale europeo dei diritti dell’uomo e l’interpretazione “creativa” della convenzione EDU, in L-JUS, Rivista telematica (www.l-jus.it), 2019, 1, pp. 7-14.
[20] Cfr., sul tema, M. Cartabia, L’ora dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in I Diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, a cura di M. Cartabia, Bologna, 2007, p. 13 ss.
[21] In tema di obiezione di coscienza si rimanda a G. Puppinck, L’obiezione di coscienza nella legislazione e nella giurisprudenza europee, in L-JUS, Rivista telematica (www.l-jus.it), 2018, 1, pp. 25-36. Per il quadro nazionale italiano si rimanda invece a G. Rocchi, Obiezione di coscienza: quadro nazionale e prospettive, in L-JUS, Rivista telematica (www.l-jus.it), 2018, 1, pp. 37-52, nonché a M. Ronco, Il diritto fondamentale all’obiezione della coscienza contro la legge radicalmente ingiusta, in L-JUS, Rivista telematica (www.l-jus.it), 2018, 1, pp. 73-80.
[22] Art. 21, par. 1, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea: «È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale».
[23] Art. 22 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea: «L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica».
[24] Art. 10 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: «Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale».
[25] Art. 17 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: «1. L’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale. 2. L’Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali. 3. Riconoscendone l’identità e il contributo specifico, l’Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni».
[26] Art. 19 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: «1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell’ambito delle competenze da essi conferite all’Unione, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. 2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell’Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1».
[27] Così l’art. 1 direttiva 2000/78/CE.
[28] N. Marchei, La libertà religiosa nella giurisprudenza delle Corti europee, in Stato, Chiese e Pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2019, 33, p. 53.
[29] Cfr., in proposito, l’art. 5 TUE («la delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione. L’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità») e l’art. 17 TFUE, che sancisce espressamente l’obbligo di rispettare e non pregiudicare lo status di cui le chiese, le associazioni o comunità religiose e le organizzazioni filosofiche e non confessionali godono negli Stati membri «in virtù del diritto nazionale».
[30] D. Durisotto, I recenti interventi della Corte EDU e della Corte di Giustizia UE in tema di simboli religiosi, un percorso parallelo. Rassegna della giurisprudenza, in Federalismi, Rivista telematica (www.federalismi.it), 2019, 1, p. 53.
[31] Per completezza di esposizione e per una adeguata valutazione di ogni singola fattispecie è utile considerare anche la posizione espressa dalla Corte Costituzionale italiana nella sentenza n. 276/2005: «Il “fluire del tempo”, per giurisprudenza costante della Corte, è stato riconosciuto elemento significativo ai fini del giudizio di eguaglianza. Infatti “gli eventi sui quali incide il fluire del tempo sono caratterizzati da peculiarità, che li diversificano da situazioni analoghe, oggetto di comparazione” (sentenza n. 6/1988), con la conseguenza che non contrasta con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, giacché “il succedersi nel tempo di fatti ed atti può di per sé rendere legittima l’applicazione di una determinata disciplina rispetto ad altra” e “l’elemento temporale può essere legittimo criterio di discrimine”», in Corte Costituzionale – Servizio Studi, I diritti fondamentali nell’ordinamento giuridico comunitario e negli ordinamenti nazionali, Quaderno predisposto in occasione dell’incontro quadrilaterale tra Corte costituzionale italiana, Tribunale costituzionale spagnolo, Corte costituzionale portoghese e Consiglio costituzionale francese, Siviglia, 27 ottobre 2017, pp. 12-13, reperibile in https://bit.ly/3gycUlq.
[32] L. Saporito – F. Sorvillo- L. Decimo, op. cit., p. 12.
[33] In altro contesto, l’ordinamento comunitario ne fa cenno nella disciplina relativa al riconoscimento della qualità di rifugiato o di persona bisognosa di protezione internazionale nei confronti di cittadini di Paesi terzi o apolidi. Nel diritto nazionale italiano la nozione di religione e quella di fede religiosa compaiono in diverse disposizioni di legge, come ad esempio gli artt. 8 e 15 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), l’art. 4 della legge 15 luglio 1966 n. 604 in tema di licenziamento, la legge 31 dicembre 1996 n. 675 in tema di privacy e il d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 in tema di immigrazione, solo per citarne alcune.
[34] Si legga, in proposito, la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea Grande Sez., (Sent., 22 gennaio 2019, n. 193/17): «58. Orbene, è pacifico che la libertà di religione fa parte dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione, e la nozione di “religione” deve essere intesa a tal proposito nel senso che essa comprende sia il forum internum, ossia il fatto di avere convinzioni, sia il forum externum, ossia la manifestazione pubblica della fede religiosa (v., in tal senso, sentenze del 14 marzo 2017, G4S Secure Solutions, C-157/15, EU:C:2017:203, punto 28, nonché del 14 marzo 2017, Bougnaoui e ADDH, C-188/15, EU:C:2017:204, punto 30)».
[35] V. Protopapa, I casi Achbita e Bougnaoui. Il velo islamico tra divieto di discriminazione, libertà religiosa ed esigenze dell’impresa, in Argomenti di diritto del lavoro, 2017, 4-5, p. 1069.
[36] Si leggano, in proposito, Corte di Giustizia dell’Unione Europea Grande Sez., sentenza 14 marzo 2017, n. 157/15 e Corte di Giustizia dell’Unione Europea Grande Sez., sentenza 14 marzo 2017, n. 188/15.
[37] Si legga, in proposito, A. Borghi, op. cit., pp. 16-17, che sul tema richiama anche N. Fiorita, Le direttive comunitarie in tema di lotta alla discriminazione, la loro tempestiva attuazione e l’eterogenesi dei fini, in www.olir.it (dicembre 2004), F. Onida, Il problema delle organizzazioni di tendenza nella direttiva 2000/78/CE attuativa dell’art. 13 del Trattato sull’Unione europea, in Dir. eccl., 2001, I, p. 905 ss., P. Chieco, Le nuove direttive comunitarie sul divieto di discriminazione, in Riv. it. dir. lav., n. 1/2002, p. 81, V. Pacillo, Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa nel rapporto di lavoro subordinato, Milano, 2003, p. 170, M.V. Ballestrero, Eguaglianza e nuove differenze nel diritto del lavoro. Una riflessione sui lavori flessibili, in Lavoro e dir., n. 3-4/2004, p. 514.
[38] Si legga, in proposito, M. Aimo, Le discriminazioni basate sulla religione e sulle convinzioni personali, in M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, Milano, 2007, p. 63.
[39] Si veda, in proposito, Corte di Giustizia dell’Unione Europea Grande Sez., Sent., 14 marzo 2017, n. 188/15: «a norma del considerando 23 della direttiva 2000/78, è solo in casi strettamente limitati che una caratteristica collegata, in particolare, alla religione può costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa».
[40] Art. 32 Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo.
[41] N. Marchei, op. cit., p. 50, che sul tema richiama anche Corte EDU, sentenza Manoussakis c. Grecia del 26 settembre 1996.
[42] Secondo F. J. Borrego Borrego, op. cit., p. 12 «nella giurisprudenza di Strasburgo è frequente l’applicazione del cosiddetto “margine di valutazione” degli Stati, ovvero rispettare l’interpretazione realizzata per via interna, con attenzione alla prossimità con il caso e con le differenti identità culturali e tradizionali».
[43] Cfr., in proposito, l’art. 9, par. 2, della Convenzione, ove si fa riferimento a «misure necessarie, in una società democratica».
[44] Concetto legato al rispetto di principi fondanti l’assetto costituzionale dello Stato, come il principio di neutralità dello spazio pubblico in alcuni paesi europei (Francia e Turchia, per citare alcuni esempi).
[45] Da intendersi come sicurezza pubblica o come ordinato svolgimento di alcune attività (un’udienza, una lezione universitaria, etc.).
[46] Corte EDU, sentenza X c. Regno Unito del 12 luglio 1978, caso nel quale alcuni motociclisti appartenenti alla religione sikh lamentavano la violazione del proprio diritto di indossare il turbante a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di indossare il casco.
[47] Corte EDU, sentenza Karaduman c. Turchia del 3 maggio 1993, caso nel quale a una studentessa musulmana era stato negato il rilascio del certificato di laurea a seguito del suo rifiuto di produrre una fotografia senza indossare il velo.
[48] Corte EDU, sentenza Phull c. Francia dell’11 gennaio 2005, caso nel quale un uomo pretendeva di superare i controlli aeroportuali con il turbante.
[49] Corte EDU, sentenza Morsli c. Francia del 4 marzo 2008, caso nel quale una donna musulmana pretendeva di superare i controlli all’ingresso di un consolato con indosso il velo islamico.
[50] Corte EDU, sentenza Dahlab v. Svizzera del 15 febbraio 2011.
[51] Corte EDU, sentenza Arslan e altri c. Turchia dell’11 febbraio 2010, caso riguardante alcuni fedeli musulmani che camminavano nelle vie di Ankara, di ritorno da un rito religioso, abbigliati con tuniche e altri capi di vestiario dal chiaro significato religioso.
[52] Corte EDU, Grande Camera, sentenza S.A.S c. Francia del 1luglio 2014, caso riguardante una donna musulmana che avrebbe voluto indossare il velo integrale nelle pubbliche vie e che sosteneva essere stato violato il suo diritto di libertà religiosa.
[53] Corte EDU, sentenza Hamidovic c. Bosnia Erzegovina del 5 dicembre 2017, caso riguardante un testimone in un processo penale che, nonostante il divieto di utilizzo di simboli religiosi, rifiutava di togliersi il copricapo attestante la sua appartenenza religiosa.
[54] Corte EDU, sentenza Lachiri c. Belgio del 18 dicembre 2018, caso riguardante una donna musulmana che rifiutava di togliere il velo all’interno del tribunale di Bruxelles ove si trovava per assistere a un’udienza.
[55] La vicenda riguarda la scelta della signora Nadia Eweida, hostess della British Airways, di mostrare la propria collana con la croce, in violazione del dress code imposto dalla propria datrice di lavoro, al fine di dare al pubblico un’immagine neutrale della compagnia. Il codice di vestiario del protocollo aziendale vietava ai dipendenti di indossare simboli religiosi, a eccezione di quelli prescritti da specifici obblighi di natura religiosa (l’hijab delle musulmane, i turbanti e i braccialetti d’argento dei sikh, etc.). La deroga non avrebbe invece riguardato, ad avviso della compagnia, il caso della signora Eweida, dal momento che per la fede cristiana non sussiste obbligo di indossare la croce.
[56] Corte EDU, sentenza Eweida c. Regno Unito del 15 gennaio 2013.
[57] Cfr. art. 16 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
[58] Corte Giustizia Unione Europea Grande Sez., sentenza 14 marzo 2017, n. 157/15.
[59] Corte Giustizia Unione Europea Grande Sez., sentenza 14 marzo 2017, n. 188/15.
[60] Osserva A. Borghi, op. cit., pp. 11-13, che «nel terreno in cui si muove la Corte la neutralità assurge a principio chiave, che trova riconoscimento nella più ampia sfera della libertà d’impresa di cui all’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».
[61] Norma che lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui.
[62] Norma in ragione della quale allo scopo di assicurare completa parità nella vita professionale, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 di detta direttiva.
[63] N. Marchei, op.cit., pp. 77-78.
[64] Si legga, in proposito, M. Aimo, Le discriminazioni basate sulla religione e sulle convinzioni personali, in M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, Milano, 2007, pp. 67: «a tali organizzazioni ideologicamente caratterizzate la direttiva consente di differenziare i trattamenti dei lavoratori sulla base della religione o delle convinzioni personali dei medesimi, a condizione che, l’una o l’altra caratteristica costituiscano un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa: poiché, però, non è più richiesto che il requisito sia determinante, né – soprattutto – proporzionato, la deroga al principio di parità di trattamento loro concessa risulta più estesa rispetto all’eccezione generale».
[65] Così Corte Giustizia Unione Europea Grande Sez., Sent., 17 aprile 2018, n. 414/16; si legga anche Corte Giustizia Unione Europea Grande Sez., Sent., sentenza 11 settembre 2018, n. 68/17: «A tale riguardo, il requisito di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/78 deve essere conforme al principio di proporzionalità, il che significa che i giudici nazionali devono verificare se detto requisito sia appropriato e non ecceda quanto è necessario per conseguire l’obiettivo perseguito (sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, С-414/16, EU:C:2018:257, punto 68)».
[66] Corte di Giustizia dell’Unione Europea Grande Sez., Sent., 17 aprile 2018, n. 414/16.
[67] Norma con la quale era stata trasposto in Germania l’art. 4.2 della direttiva 2000/78/CE: «1. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 8 [della presente legge], una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali nel rapporto d’impiego con comunità religiose, istituzioni ad esse correlate, a prescindere dalla forma giuridica, o associazioni che coltivano in comune una religione o convinzioni personali, è altresì lecita quando una determinata religione o convinzione personale costituisce, tenuto conto delle regole della coscienza ecclesiale della rispettiva comunità religiosa o associazione sotto il profilo del suo diritto all’autodeterminazione o a seconda della natura della sua attività, un requisito giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 2. Il divieto di disparità di trattamento basate sulla religione o sulle convinzioni personali non pregiudica il diritto delle comunità religiose di cui al paragrafo 1, delle istituzioni ad esse correlate, a prescindere dalla forma giuridica, o delle associazioni che coltivano in comune una religione o convinzioni personali, di chiedere ai loro dipendenti un atteggiamento di buona fede e di lealtà ai sensi delle regole della propria coscienza ecclesiale».
[68] Il termine “essenziale” significa che “per il legislatore dell’Unione, l’appartenenza alla religione o l’adesione alle convinzioni personali su cui si fonda l’etica della Chiesa o dell’organizzazione in questione deve apparire necessaria, a causa dell’importanza dell’attività professionale di cui trattasi, per l’affermazione di tale etica o l’esercizio da parte di tale Chiesa o di tale organizzazione del proprio diritto all’autonomia”; con il termine “legittimo” il legislatore dell’Unione “ha inteso garantire che il requisito relativo all’appartenenza alla religione o all’adesione alle convinzioni personali su cui si fonda l’etica della Chiesa o dell’organizzazione in questione non venga utilizzato per un fine estraneo a tale etica o all’esercizio da parte di tale Chiesa o di tale organizzazione del proprio diritto all’autonomia”; il termine “giustificato” implica «non solo che il controllo del rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 possa essere effettuato da un giudice nazionale, ma anche che la Chiesa o l’organizzazione che ha stabilito tale requisito ha l’obbligo di dimostrare, alla luce delle circostanze di fatto del caso di specie, che il presunto rischio di lesione per la sua etica o il suo diritto all’autonomia è probabile e serio, di modo che l’introduzione di un siffatto requisito risulta essere effettivamente necessaria».
[69] Corte Giustizia Unione Europea Grande Sez., Sent., sentenza 11 settembre 2018, n. 68/17.
[70] M. Aimo, Le discriminazioni basate sulla religione e sulle convinzioni personali, in M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, Milano, 2007, p. 74, che cita A. Viscomi, Osservazioni critiche su lavoro e «tendenza» nelle fonti internazionali e comunitarie, in LD, 2003, p. 586.
[71] Messaggio del Santo Padre Giovanni Paolo II per la celebrazione della XXXII giornata mondiale della pace del 1° gennaio 1999, Nel rispetto dei diritti umani il segreto della pace vera, Vaticano, 8 dicembre 1998.