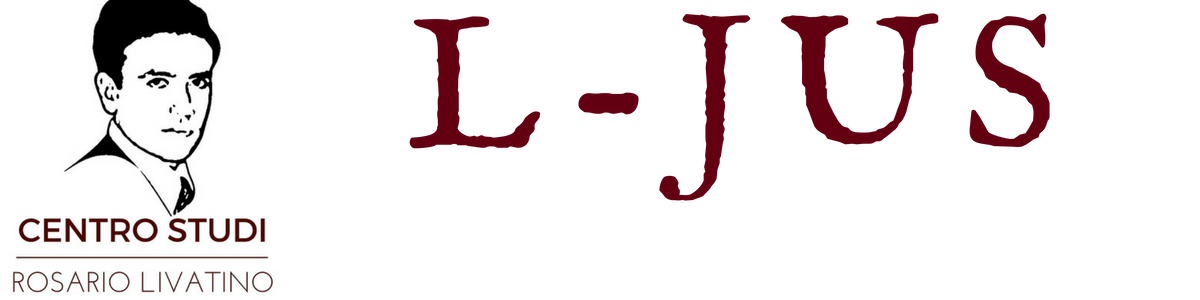Si riporta il testo della relazione di Alfredo Mantovano*, depositata in seguito all’audizione informale in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati del 16 luglio 2021.
Indice
- Gli elementi positivi
- Le novità che tali non sono
- Le novità pericolose. 3.1. I criteri di priorità per i Procuratori della Repubblica. 3.2. Le deroghe alla immutabilità del giudice. 3.3. L’improcedibilità in appello (e in Cassazione).
- La fuga dalla sanzione, senza garanzie di effettività
- Quello che manca
- L’inutile ‘ufficio del processo’
- Per concludere
Sig. Presidente, On. Deputati,
l’intervento del Governo enfaticamente presentato come ‘riforma Cartabia’, è in realtà emendantivo rispetto al d.d.l. AC 2435, c.d. ‘riforma Bonafede’, e quindi è più correttamente definibile ‘Bonafede-Cartabia’. Contiene elementi senza dubbio positivi, altri ripetitivi di disposizioni già vigenti ma non compiutamente applicate, altri che sollecitano perplessità, mentre continuano a mancare, o a essere carenti, le modifiche normative e organizzative che in tanti da tempo reclamano come necessarie e indilazionabili. Mantiene il tratto di disegno di legge delega, e per l’esercizio di quest’ultima prevede un termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
- Gli elementi positivi
I profili che meritano apprezzamento nella ‘riforma Cartabia’ sono quelli contenuti:
- all’art. 2, con l’estensione della delega per il processo penale telematico. La condizione per il suo corretto funzionamento è che sia sostenuta da un finanziamento adeguato: sono ben noti i problemi che incontra la DGSIA, l’apposita direzione del Ministero della Giustizia, risolvibili con investimenti che superino blocchi e rallentamenti, soprattutto per il maggior carico di adempimenti che le nuove norme prospettano. La circostanza che, se pure in termini generali, l’art. 16 bis preveda il ‘piano per la transizione digitale della amministrazione della giustizia’, anche ‘al fine di garantire (…) l’adeguata dotazione tecnologica dei servizi tecnici e informatici del ministero’ sembra assicurare che il sostegno non mancherà. Potrebbe essere utile già nella delega precisare che la digitalizzazione dei processi deve includere il giudizio di fronte ai giudici di pace – ambito minore quanto all’importanza dei giudizi, ma rilevante per numero e per interesse sociale -, e la completa digitalizzazione delle cancellerie e degli UNEP. L’esperienza del lockdown è stata emblematica in proposito: in molti casi, i giudici collegati da remoto erano in condizione di svolgere le attività decisionali, mentre non avevano i supporti di segretaria per il caricamento o lo scaricamento degli atti dai fascicoli telematici da parte del personale in smart working;
- agli art. 2 bis e 2 ter, che puntano a razionalizzare le notificazioni e il sistema del processo ‘in assenza’, a fronte della sovrapposizione negli ultimi anni di norme e di orientamenti giurisprudenziali, pur se va fatta attenzione a non assegnare per intero al difensore un compito che spetta all’ufficio giudiziario che dà impulso al processo;
- all’art. 7, quanto alla nuova e più stringente disciplina della elezione di domicilio ai fini delle impugnazioni;
- all’11, quanto alla garanzia costituita dall’opposizione alla perquisizione, allorché quest’ultima non sia seguita da sequestro, in coerenza con la Convenzione EDU, e in particolare con quanto sancito dalla Corte di Strasburgo, con sentenza del 27 settembre 2018 (Brazzi Italia).
- Le novità che tali non sono
La ratio, più volte espressa, della riforma è puntare all’abbattimento dei tempi del processo penale, come richiesto dal Recovery plan. Il filo conduttore del blocco di emendamenti riassumibile in tale voce è però l’introduzione di norme, soprattutto procedurali, nelle quali si confida per superare difficoltà finora – e da decenni – incontrate dal ministero e dai capi degli uffici giudiziari, piuttosto che l’impostazione di una azione di governo per dare applicazione a disposizioni già esistenti, come sarebbe stato preferibile.
Emblematico di questa sovrapposizione è l’art. 9 della riforma, che contiene la delega ad adottare decreti legislativi per “a) razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie; b) rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato; c) prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l’effettiva riscossione e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento”.
Questa delega per un verso è generica, per altro verso ribadisce quanto già previsto. Non mancano infatti specifiche disposizioni per dare esecuzione alle sanzioni pecuniarie: andrebbero identificate per ragioni per le quali non le si applica; una delle più ricorrenti è l’insufficienza del personale a ciò dedicato. Introdurre norme che nuove non sono – questo spiega perché la delega si tenga così ‘larga’ – senza una seria riorganizzazione del settore interessato non fa prevedere passi in avanti.
Altrettanto ripetitivo di disposizioni già esistenti è l’art. 3, con la disciplina del termine di durata delle indagini preliminari. La riforma prevede che:
- per le contravvenzioni il termine è di 6 mesi, prorogabile una sola volta di 6 mesi. Attualmente per le contravvenzioni il termine di durata è 6 mesi, prorogabili fino ad un totale di 18 mesi: quindi resta invariato il termine ordinario, e viene abbreviato quello massimo, che passa da 18 a 12 mesi;
- per i delitti indicati nell’articolo 407 co. 2 lettera a) cod. proc. pen. il termine di durata ordinaria passa dagli attuali 12 ai 18 mesi. Il termine di durata massima resta tuttavia invariato: 24 mesi nella normativa vigente e 24 mesi in base alla riforma, che consente una sola proroga di 6 mesi; per i casi di cui all’articolo 407 co. 2 lett. b) e c) il termine ordinario passa da 6 mesi a 18 mesi; resta invariato il termine massimo di 24 mesi (nella normativa vigente consentite proroghe fino a 24 mesi, nella riforma una sola proroga di 6 mesi);
- per tutti gli altri reati il termine è di 12 mesi, prorogabili fino al massimo 18 mesi; attualmente il termine è di 6 mesi prorogabili fino ad un massimo di 18 mesi (tranne alcuni specifici delitti): quindi il termine resta invariato.
In sintesi, le novità sono veramente minime, e quindi prive di incidenza.
La medesima ripetitività connota la disposizione di cui all’art. 7 co. 1 lett. h bis): «l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell’atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato». Qual è la differenza rispetto al vigente art. 581 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 23/06/2017, che – a proposito dell’impugnazione, e quindi in particolare dell’atto di appello – parla di «enunciazione specifica, a pena di inammissibilità (…) dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta»?
- Le novità pericolose
Gli art. 3 (per la parte riguardante i termini delle indagini) e 9 tutto sommato non aggiungono e non tolgono nulla. Ci sono invece disposizioni che, nonostante le migliori intenzioni, appaiono problematiche, e rischiano di allontanare dai principi fondamentali del processo penale.
3.1. I criteri di priorità per i Procuratori della Repubblica
L’art. 3 co. 1 lett. h) delega il Governo a «prevedere che gli uffici del pubblico ministero (…) nell’ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell’utilizzo efficiente delle risorse disponibili».
La ‘riforma Bonafede-Cartabia’ ratifica così il potere ‘normativo’ dei Capi delle Procure, preferendo delegare a questi ultimi di stabilire quali reati non saranno perseguiti. Nel diritto romano l’editto pretorio era l’atto con cui un magistrato munito di imperium dichiarava pubblicamente i criteri cui era ispirata la sua attività di governo: un potere normativo riconosciuto e non usurpato, e assai poco compatibile col principio della separazione dei poteri che caratterizzerà le democrazie dell’epoca moderna.
Non sarebbe corretto affermare che i Capi delle Procure abbiano usurpato poteri loro non spettanti nello stabilire i cosiddetti ‘criteri di priorità’ quanto ai progetti organizzativi dei propri uffici. Già il CSM aveva provveduto a dar loro copertura normativa, sia pure di grado secondario, inquadrando tali criteri nel contesto di un sempre più ‘necessitato’ esercizio ‘ragionevole’ dell’azione penale. L’art. 3 co. 1 lett. h) porta però a compimento l’iter, ratificando con norma primaria un potere sostanzialmente legislativo, pur se con la copertura della delega del Parlamento ai Procuratori della Repubblica.
I criteri di priorità non sono un’invenzione dei Capi delle Procure. Il codice di procedura penale li prevede, all’art. 132 bis delle disposizioni di attuazione, ma con una finalità peculiare, tutta processuale. Valgono a regolare la formazione dei ruoli di udienza, vale a dire l’ordine di trattazione dei processi. Usando una metafora calcistica, tali criteri servono per elaborare il calendario degli incontri, dando la precedenza a quelli più importanti. Nell’applicazione fattane per la fase delle indagini preliminari, la funzione è però radicalmente diversa: le priorità decidono quali incontri verranno disputati e quali no. Uscendo dalla metafora, si passa da un piano processuale a uno sostanziale, poiché tali criteri funzionano nei fatti come una deroga al principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale.
La questione relativa alla determinazione dei criteri di priorità non può non essere anche e soprattutto riguardata nel suo lato per così dire oscuro, rappresentato dai procedimenti che, per l’effetto dell’“editto” dei Procuratori, vengono ad essere declassati come non prioritari; è la fetta dei procedimenti non prioritari che rappresenta la cifra della deroga al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale.
I rilievi sono due. Il primo è una constatazione: i criteri di priorità – e soprattutto quelli di non priorità ‒ finiscono col disegnare una giustizia penale a geografia variabile, per la quale il confine fra un circondario e un altro può significare guadagnare l’impunità per taluni reati; con quel che ne segue in termini di allocazione delle risorse da parte delle organizzazioni criminali, da sempre interessate allo ‘shopping giudiziario’. Il secondo è un interrogativo: chi ha investito i Capi delle Procure – e più in generale, i vertici degli uffici giudiziari ‒ del compito di stabilire quale domanda di giustizia è meritevole di risposta, e quale no? È davvero un bene per il corpo sociale – e per la stessa magistratura – legittimare amnistie su base localistica? Il compito di decidere se una condotta non è più reato spetta al legislatore, perché solo quest’ultimo risponde delle scelte compiute dinanzi ai governati.
Si potrebbe obiettare che la ‘riforma Bonafede-Cartabia’ fornisce una risposta, allorché prevede che l’individuazione delle priorità ‘trasparenti e predeterminate’ avvenga dagli uffici del pubblico ministero nell’ambito di ‘criteri generali’ indicati dal Parlamento, ma questo fa sorgere due ulteriori perplessità. La prima riguarda il metodo: se il legislatore intende assumersi le responsabilità che la Costituzione gli assegna e che il popolo si attende, non sarebbe stato meglio e più conforme al principio dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale un radicale intervento di sfoltimento dell’ingestibile catalogo degli illeciti penali che affliggono gli uffici giudiziari, frutto del radicato (mal)costume di delegare al diritto penale l’etica pubblica, previo adeguato potenziamento degli uffici di prefettura e della giurisdizione civile, cui sarebbe riversato il carico delle nuove sanzioni amministrative?
La seconda perplessità attiene al merito. Che cosa si intende per ‘criteri generali’? Se ci si intende limitare a ciò che non può non essere perseguito penalmente, il rischio concreto è di riproporre, in altra versione, quanto già stabilito dall’art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen. sopra richiamato. Se poi la limitazione alle indicazioni generali vuole far salvi gli indispensabili adeguamenti alle morfologie criminali di ciascun territorio di competenza dei singoli Procuratori della Repubblica, si è al cospetto di una delega sostanzialmente in bianco, ancor più pericolosa per l’assetto istituzionale e per il principio della separazione dei poteri.
Un’ultima considerazione riguarda l’inserimento dei criteri di priorità nel complessivo disegno riformatore, per le ricadute sulle persone offese. L’accantonamento dei procedimenti non prioritari, effetto collaterale dei criteri di priorità, diventerà l’anticamera della richiesta di archiviazione perché, non essendo stata svolta alcuna attività di indagine, non vi saranno le condizioni per l’esercizio dell’azione penale, possibile solo ove vi sia una ‘ragionevole previsione di condanna’, come pure previsto dalla riforma. Anche l’eventuale opposizione della persona offesa avrà poche probabilità di successo; se pure quest’ultima incontrasse un giudice che imponga al P.M. di esercitare l’azione penale, è evidente che quella domanda di giustizia andrebbe in coda ad altre che, viceversa, beneficiano di una corsia preferenziale, con danni gravi non soltanto alle vittime ma alla credibilità della giustizia.
3.2. Le deroghe alla immutabilità del giudice
È noto che gli art. 525 co. 2 e 526 co. 1 cod. proc. pen., prevedono la partecipazione alla deliberazione della sentenza dei medesimi giudicanti che hanno preso parte al dibattimento e il divieto di utilizzazione, ai fini della deliberazione, di prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento; l’art. 511 cod. proc. pen., allorché disciplina la lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e utilizzabili per la decisione, consente la lettura dei verbali di dichiarazioni solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo. Dall’insieme di tali disposizioni deriva l’obbligo per il giudice del dibattimento di ripetere l’assunzione della prova dichiarativa ogni qual volta muti la composizione del collegio giudicante, se le parti non prestano consenso alla lettura delle dichiarazioni rese dai testimoni innanzi al precedente organo giudicante.
Fra le ragioni di allungamento dei tempi di definizione dei giudizi, oltre che di disagio per i testimoni, vi è il mutamento del giudice monocratico o, in tutto o in parte, dei componenti del collegio giudicante, che costringe alla rinnovazione della prova dichiarativa. Con la sentenza n. 132/2019 la Corte costituzionale aveva sottolineato che “la dilatazione in un ampio arco temporale dei dibattimenti crea inevitabilmente il rischio che il giudice che ha iniziato il processo si trovi nell’impossibilità di condurlo a termine, o comunque che il collegio giudicante muti la propria composizione, per le ragioni più varie”.
Questo avviene nonostante il codice di rito preveda per il dibattimento le forme imposte dalla pubblicità (art. 471), dal contraddittorio (art. 466, 486, 493, 498, 516, 546), dall’immediatezza (art. 498, 525), dalla concentrazione (art. 477 e 544) e dall’oralità (art. 499, 500, 514, 526): e quindi nonostante che l’insieme di tali norme escluda intervalli di tempo tra l’assunzione delle prove in udienza, la discussione finale e la deliberazione della sentenza. A tal fine l’art. 477 co. 1 cod. proc. pen. precisa che quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che venga proseguito nel giorno seguente non festivo; il co. 2 dell’art. 477 consente la sospensione soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che non oltrepassi i dieci giorni. È stata però la stessa Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 132/2019, dopo aver precisato che dall’art. 477 cod. proc. pen. deriva che il principio di immediatezza della prova è strettamente correlato al principio di oralità, ha aggiunto che «l’esperienza maturata in trent’anni di vita del vigente codice di procedura penale restituisce, peraltro, una realtà assai lontana dal modello ideale immaginato dal legislatore. I dibattimenti che si concludono nell’arco di un’unica udienza sono l’eccezione; mentre la regola è rappresentata da dibattimenti che si dipanano attraverso più udienze, spesso intervallate da rinvii di mesi o di anni».
Una adeguata azione di governo potrebbe affrontare l’anomalia attraverso una interlocuzione fra ministero, CSM e capi dei distretti giudiziari, finalizzati a garantire, come è avvenuto nei primi anni di applicazione del codice di procedura penale del 1988, quando comunque i carichi giudiziari non erano di poco conto, misure organizzative perché la fissazione delle udienze dibattimentali segua scadenze ravvicinate, non di semestre in semestre, o peggio: fra le misure organizzative ben potrebbe rientrare un ricorso più diffuso all’istituto esistente dell’applicazione all’ufficio di provenienza del magistrato che abbia ottenuto, su domanda, il trasferimento ad altra sede, o ad altro incarico, al fine di esaurire la trattazione dei giudizi avviati e ancora pendenti (sempre che non si intenda introdurre la previsione che ogni tramutamento diventi operativo solo quando il magistrato richiedente abbia completato quei giudizi).
La strada percorsa dagli emendamenti del Governo è altra, poiché l’art. 5 co. 1 lett. e) stabilisce che «nell’ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio»:
- «la riassunzione della prova dichiarativa già assunta” avvenga solo “su richiesta di parte». Dunque la regola sarà quella che il giudice in diversa composizione valuti una prova dichiarativa assunta innanzi ad altri, e la deroga che il rinnovo della prova avvenga solo a richiesta di parte;
- «quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione», «la riassunzione della prova» sia disposta dal diverso giudice «solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze».
In questo secondo caso la deroga ai principi cardine del processo penale non dipende nemmeno dal consenso prestato dalla parte interessata, bensì soltanto dalla valutazione del giudice. Superfluo ricordare che l’art. 111 Cost. al co. 2 impone lo svolgimento del processo in contraddittorio «davanti a giudice»: ‘davanti’ esclude ‘per video’. La valutazione del testimone, e in generale di ogni dichiarante, la sua attendibilità, la coerenza di quel che riferisce, esigono l’attenzione non solo alle parole che pronuncia, bensì pure a come le pronuncia, a quel che manifesta coi gesti, alle pause. Impongono di fermarlo e di chiedere precisazioni quando una espressione adoperata non è intellegibile, o quando una ricostruzione non appare chiara, o quando il discorso non è coerente.
Peraltro la disciplina introdotta dall’art. 5 co. 1 lett. e) rende incoerente quanto – nel medesimo comma, alla lett. a) – la riforma stabilisce, confermando una disposizione contenuta nell’originario d.d.l. Bonafede: «quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza (…) il giudice comunichi alle parti il calendario delle udienze per l’istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione». Che bisogno vi sarebbe, una volta definito il calendario delle udienze, a quindi avuta certezza dell’identità del giudicante per l’intero suo svolgimento, della previsione di deroghe alla immutabilità del medesimo giudicante, se non vi fosse la convinzione che il processo durerà ben oltre i tempi prevedibili di permanenza nell’ufficio di uno o più componenti del collegio?
Dal lato del giudice, il ‘video’ sostitutivo del ‘davanti’ incrina ulteriormente quel residuo di decoro che egli ha, o dovrebbe avere, quando amministra giustizia. Ci sarà pure una ragione se da secoli l’aula d’udienza vede collocato il giudicante, singolo o collegiale, al centro, un gradino più in alto aspetto agli altri soggetti processuali, sotto una lunga veste nera: non perché sia superiore agli altri e meriti più rispetto in quanto persona, ma perché svolge la sacrale funzione di jus dicere nel caso concreto, quella che incide sulla carne e sulla vita dell’accusato, quella che non per caso fa definire “rito” – mutuando un termine religioso – l’iter previsto per giungere alla pronuncia. Porre davanti allo scranno in legno non una persona ma lo schermo video, privarsi del contatto umano con il dichiarante ha un costo ancora più grave della – pur grave – decisione errata che consegue a una difesa non messa nelle condizioni di bene esercitarsi, e a una istruttoria dibattimentale monca.
3.3. L’improcedibilità in appello (e in Cassazione)
Quel che prevede il nuovo art. 344 bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 14 bis degli emendamenti del Governo costituisce uno dei passaggi più preoccupanti della ‘riforma Bonafede-Cartabia’.
La posta in gioco è la disciplina della prescrizione. Costituisce una obiettiva sconfitta per lo Stato arrivare a sentenza definitiva a molti anni di distanza dalla consumazione di reati che possono aver provocato danni ingenti alle persone offese, il cui accertamento ha richiesto fatica ed energie a causa di indagini complicate e di tre gradi di giudizio, e vedere tutto azzerato a causa dello scorrere del tempo. Sull’altro piatto della bilancia vi è l’esigenza di ogni accusato di concludere in tempi accettabili la propria posizione processuale, soprattutto se innocente.
È noto che la disciplina della prescrizione è stata notevolmente modificata con la legge n. 3 del 9/01/2019, c.d. “spazza-corrotti”, entrata in vigore il 1° gennaio 2020, che ha sancito, fra l’altro, la sospensione del termine di prescrizione “dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna”.
Le riserve su una così sconvolgente riforma, peraltro intervenuta appena due anni dopo l’equilibrata modulazione del regime dell’istituto realizzata dalla legge n. 103/2017 (ministro della Giustizia Orlando), sono state sollevate sulla scorta di considerazioni obiettive:
- il 70% dei procedimenti penali che si definiscono in Italia con la prescrizione sono ancora nella fase delle indagini preliminari. Poiché la legge n. 3/2019 non incide in tale fase, essa si mostra inutile in più dei 2/3 dei casi di prescrizione e rischia di non far cogliere il dato allarmante costituito dalla discrezionalità di fatto dell’azione penale, che conduce una parte significativa delle Procure della Repubblica – come si è sottolineato al § 3.1. – a scegliere quali reati perseguire e quali no. La “spazza-corrotti” si concentra solo su quel che accade dopo la pronuncia di primo grado, che è fenomeno diverso e quantitativamente meno rilevante;
- nel restante 30% dei casi, i termini di prescrizione maturano con maggiore frequenza fra la decisione di primo grado e quella di appello, mentre in percentuale irrilevante – poco più dell’1% – in Cassazione. Secondo i dati (riferiti dal periodo 1/07/2018-30/06/2019) riportati dalla Relazione sull’amministrazione della Giustizia in Italia del Primo Presidente della Cassazione, la durata media dei processi in appello in Italia è di 2 anni, 3 mesi e 20 giorni, e in questo grado si prescrive il 25% dei processi;
- la prescrizione ordinaria per la fascia di delitti meno gravi è di 6 anni, con incrementi significativi quando sono contestate aggravanti a effetto speciale o la recidiva qualificata, e salvo l’aumento a fronte di atti interruttivi del decorso del termine. Non vale la comparazione con altri ordinamenti perché il confronto va operato per termini omogenei, e in Europa esistono discipline processual-penalistiche fortemente diversificate, per es. quanto alla obbligatorietà dell’azione penale, o quanto a termini di prescrizione molto più contenuti di quelli italiani. Se valessero i confronti andrebbe ricordato che, a differenza di quanto accade in altre Nazioni, in Italia in caso di assoluzione lo Stato non rifonde le spese processuali sopportate dall’incolpato;
- qualsiasi richiesta difensiva che punti al mero scorrere del tempo ai fini della maturazione della prescrizione ha incontrato fino al 2020 gli opportuni rimedi della sospensione del decorso del relativo termine;
- risponde a esigenze di giustizia che l’ordinamento delimiti il tempo entro il quale il potere dello Stato si dispieghi nei confronti dell’accusato, parametrando alla gravità dei reati la misura temporale adeguata per giungere alla sanzione. Senza questo correttivo, l’accusato in attesa del giudizio vive in uno stato di precarietà perpetua, grave in sé in quanto lo rende indefinitamente “disponibile” al potere dello Stato. Ancora più grave se – come accade in virtù della legge n. 3/2019 – la sentenza di primo grado sia di assoluzione, e quindi la presunzione di non colpevolezza sia ancora più accentuata.
Tutto ciò avrebbe imposto di cancellare, o di fortemente ridimensionare, il regime della legge n. 3/2019, prima ancora che sia pienamente operativo, in attesa di valutare la ricaduta della ‘riforma Orlando’ del 2017. Invece gli emendamenti ‘Cartabia’ per un verso non incidono in modo diretto sulla ‘prescrizione Bonafede’, per altro verso la aggira con disposizioni processuali. Il nuovo art. 344 bis cod. proc. pen. stabilisce infatti, al co. 1, che “La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale”; in cassazione il termine è di un anno, con possibilità di proroga al co. 4 rispettivamente di un anno e di sei mesi “nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a)”, e per i delitti contro la pubblica amministrazione, se il giudizio è complesso o vi sono molto imputati.
Non ci si sofferma sulla commistione fra un istituto di diritto sostanziale, come la prescrizione, e un istituto di natura procedurale, come quello che viene introdotto, in netto contrasto con la tradizione giuridica italiana: sarebbe interessante farlo, non soltanto sul piano dogmatico ‒ l’azione penale è già stata esercitata in primo grado, e quel che accade in seguito rientra nell’articolazione di facoltà processuali diverse dall’esercizio dell’azione penale, quale per es. l’impugnazione ‒, ma anche perché per sospendere l’operatività del termine del processo in appello il co. 5 del nuovo art. 344 bis cod. proc. pen. fa riferimento all’art. 159 cod. pen., cioè alle cause di sospensione della prescrizione, quindi la confusione fra i due istituti c’è tutta, nonostante le profonde differenze sui tempi di operatività.
I primi effetti di questa nuova disciplina saranno che: a) tutti proporranno appello, anche in giudizi nei quali la condanna si è mantenuta al minimo coi benefici, poiché in non pochi distretti si confiderà sul decorso del termine biennale; b) poiché il nuovo regime di improcedibilità del processo vale per i fatti successivi al 1/01/2020, le corti presumibilmente tratteranno con priorità questi processi, nello sforzo di mantenersi nel biennio, e abbandoneranno, se non tutti, larga parte degli altri giudizi al loro destino.
Questo vuol dire che si realizzeranno nei fatti due tipologie di amnistie, ovviamente senza passare dall’iter parlamentare rafforzato di cui all’art. 79 Cost:
- la prima, più generalizzata, riguarderà larga parte dei processi per fatti antecedenti il 1/01/2020;
- la seconda, differente distretto per distretto, riguarderà quelle Corti di appello che oggi impiegano anche 5- 6 anni dal momento in cui perviene il fascicolo dal primo grado al momento della sentenza; tali sono i tempi di almeno un paio di Corti territoriali italiane, per le quali la somma dei procedimenti pendenti si avvicina alla somma dei procedimenti pendenti in tutti gli altri distretti italiani.
Senza tacere delle difficoltà interpretative: un reato come la bancarotta fraudolenta, per fare un esempio, non rientra fra le ipotesi di proroga di cui al co. 4 dell’art. 344 bis cod. proc. pen., e dunque diventa non più procedibile, pur in presenza di condanna in Tribunale, dopo due anni dalla trasmissione del fascicolo in appello. Se nel secondo grado di giudizio si rende necessario disporre una perizia, non disposta o non soddisfacente in primo grado, può essere necessario anche un anno per il suo espletamento. Il co. 5 della nuova disposizione prevede la sospensione del decorso del termine di improcedibilità per consentire la rinnovazione istruttoria dibattimentale, ma stabilisce pure che il periodo di sospensione fra una udienza e quella successiva non debba superare i 60 giorni: che cosa accade se lo svolgimento della perizia esige un tempo più esteso? Non viene precisato.
Sarebbe stata molto più produttiva una verifica concreta delle ragioni per le quali vi è questa così marcata diversità di tempi di trattazione distretto per distretto: carenza di personale? Disorganizzazione? Che cosa? Invece si fissa questa tagliola eguale per tutti, immaginando che sia sufficiente la fissazione del biennio per far rientrare in due anni quel che finora non si è esaurito in cinque, senza operare nulla in termini di allargamento degli organici (cf. § 5) o di adozione di misure organizzative.
Il dato riguardante l’1% di prescrizioni rilevate in Cassazione, e i tempi molto contenuti di definizione dei giudizi davanti al Giudice di legittimità, non sono frutto del caso: derivano, fra l’altro, dall’istituzione – che data già qualche anno – di una sezione penale filtro, la Settima sezione, che decide in udienza non partecipata i ricorsi dai motivi con evidenza inammissibili, così contribuendo alla rapida conclusione di oltre il 40% delle pendenze. Che cosa vieta l’istituzione di analoga sezione filtro per lo meno per le Corti di appello di maggiore consistenza? Perché giungere a un tale stravolgimento sistemico, senza tentare la strada della estensione di misure organizzative già positivamente sperimentate?
È certo, per concludere sul punto, il mix prescrizione-improcebilità è un compromesso politico, non una soluzione giuridica ragionevole fondato sul necessario bilanciamento fra le varie esigenze in gioco: a fronte della palese confusione tra i piani sostanziale e processuale, sarebbe meglio il ritorno alla ‘riforma Orlando’, o paradossalmente lasciare inalterato il quadro attuale, in attesa di condizioni politiche migliori.
- La fuga dalla sanzione, senza garanzie di effettività
Una parte significativa degli emendamenti ‘Cartabia’ punta alla decarcerizzazione attraverso misure che vanno dalla estensione della operatività della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.) all’incremento dei limiti sanzionatori per fruire delle pene sostitutive delle pene detentive, fra le quali il lavoro di pubblica utilità, al raccordo con i riti alternativi, al fine di sollecitarne l’attivazione. Così l’art. 9 bis contiene la previsione che «il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità (…)».
Nella stessa ottica, la riforma stabilisce un più ampio utilizzo della ‘messa in prova’: si tratta di un istituto, introdotto dalla legge 28/04/2014 n. 67, la cui applicazione può oggi essere chiesta dall’imputato di reati puniti con pena edittale non superiore nel massimo a quattro anni, e comporta, attraverso l’affidamento al servizio sociale e il coinvolgimento nel volontariato, la prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il processo viene sospeso e, in caso di esito positivo della prova, il reato si estingue. L’art. 9 bis stabilisce l’estensione dell’«ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (…) ad ulteriori specifici reati, puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni».
Premesso che è fuor di dubbio che il sovraffollamento rappresenti il male endemico ‒se pure non l’unico ‒ del sistema penitenziario italiano, va però aggiunto che, in rapporto alla popolazione residente in Italia, la popolazione carceraria è fra le più basse al mondo, in termini assoluti e percentuali. Per ridurre il sovraffollamento non esiste un solo rimedio e – ancora una volta – una sapiente azione di Governo è in grado di incidere in misura più efficace rispetto a interventi normativi:
- rendendo una buona volta pienamente operativi i trasferimenti dei detenuti cittadini di Stati extraeuropei, in primis l’Albania, ed europei, come la Romania. È un lavoro che richiede molto impegno (quel che è mancato finora in modo continuativo), ma che alla lunga permette di alleggerire gli istituti di pena italiani di quasi un terzo degli ospiti, quali sono i detenuti di nazionalità straniera ivi presenti;
- potenziando l’edilizia penitenziaria, avendo finalmente a disposizione dal Recovery le risorse per provvedervi;
- facendo funzionare le strutture penitenziarie completate, ma non rese operative a causa della scarsità di personale. Come in tutte le amministrazioni pubbliche, molti agenti della Polizia penitenziaria sono meridionali e vi è resistenza nell’allontanamento dai luoghi d’origine. Congrui incentivi economici, come quelli previsti per i magistrati nelle zone disagiate, faciliterebbero il loro impiego nelle strutture del Nord.
Linea guida degli emendamenti ‘Cartabia’ pare essere invece il progressivo arretramento dall’applicazione della sanzione detentiva, pur in presenza di pene edittali ‒nel caso della ‘messa in prova’ ‒ e di pene in concreto determinate ‒ nel caso del patteggiamento ‒ tutt’altro che irrilevanti, quando invece andrebbero impiegate risorse economiche e umane per l’esecuzione penale inframuraria, allo scopo di mettere a disposizione degli operatori penitenziari e dei detenuti spazi adeguati per superare realmente il sovraffollamento.
Le raccomandazioni soft law diramate nell’ultimo decennio per le carceri italiane dal DAP-Dipartimento amministrazione penitenziaria, affinché la sorveglianza dei detenuti fosse svolta in maniera flessibile e dinamica, lasciando agli stessi ampi spazi di libertà rispetto al confinamento cellulare, non ha dato buona prova: l’indagine ‘dataroom’ pubblicata il 12 luglio scorso sul Corriere della sera a firma di Milena Gabanelli e Virgilia Piccolillo attesta quanto il condivisibile intento di favorire la socialità intracarceraria sia diventato fattore di scontro e di violenza, quando la socialità non è sottoposta al pieno controllo dell’autorità competente per la corretta esecuzione della pena.
Dopo che nel 2015 una circolare del Capo del DAP aveva previsto per i detenuti, con esclusione dei soggetti al regime del 41 bis, due tipologie di custodia – chiusa, con la possibilità di trascorrere 8 ore fuori dalle celle, e aperta, fino a 14 ore – vi è stata una impennata di violenza all’interno delle carceri, passando, dal 2014 al 2020, da 387 aggressioni fisiche al personale di Polizia penitenziaria a 837, da 319 atti di violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale, a 3.577, da 1.598 colluttazioni a 3.501, per non parlare del sensibile incremento degli atti di autolesionismo, dei suicidi e dei tentati suicidi.
Non va poi dimenticato che in una Repubblica espressamente “fondata sul lavoro” (art. 1 Cost.), il momento lavorativo dovrebbe considerarsi una dimensione fondamentale per la realizzazione dei valori della Repubblica e, con essi, contribuire alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.). Lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei condannati, e in particolare dei detenuti, in modo tale da garantire i loro diritti quali lavoratori, e contemporaneamente le esigenze di sicurezza pubblica, richiede nell’immediato investimenti e organizzazione.
Come documentato dall’indagine ‘dataroom’ prima menzionata, «nelle nostre carceri sono poco più di 2.000 i detenuti che hanno una occupazione regolare, mentre circa 15 mila lavorano come (…) addetti alla lavanderia o cucina per poche ore al giorno e a giorni alterni. Tutti gli altri vengono lasciati a far niente». Ed è lo Stato che deve mettere a disposizione dei condannati i mezzi idonei per il lavoro, per la formazione professionale, per lo studio e per le varie forme di apprendimento dei mestieri, con applicazione però regolata secondo programmi operativi approvati e controllati dall’autorità esecutiva. L’autogestione della libertà senza la copertura degli spazi ove questa si esercita, con mezzi idonei affinché i detenuti impegnino positivamente la loro libertà, significa abbandonarli a una sopravvivenza chiusa al miglioramento.
Analogamente, per l’esecuzione penale extramuraria v’è l’esigenza di creare strutture organizzative statali – non di volontariato – che rendano effettiva l’esecuzione penale tramite il lavoro del condannato per fini di pubblica utilità. Ciò va fatto senza alcun retro-pensiero riveniente dall’utopia anti-penale, che si riscontra in non pochi ambienti di volontariato, secondo cui la pena, in quanto tale, sarebbe un ferro vecchio da sotterrare per sempre. L’esperienza insegna che purtroppo le cose non stanno così. L’emergenza criminale è drammaticamente presente nella società contemporanea, in qualsiasi Stato al mondo, anche, e forse soprattutto nell’Occidente immerso in una crisi di civiltà che gli ha fatto smarrire le più essenziali distinzioni tra il bene e il male.
Gli interventi di mera decarcerizzazione, senza un forte potenziamento di strutture e personale all’interno delle carceri, e senza una radicale riforma delle modalità di esecuzione extrapenale, rischiano di fomentare l’utopia anti-penale, di ridurre il perimetro della sicurezza sociale, ma non di apportare benefici in termini di reale rieducazione del condannato.
- Quello che manca
A proposito delle carenze della ‘riforma Bonafede-Cartabia’ non si fa riferimento alle urgenti riforme strutturali, dalla separazione delle carriere fra P.M. e giudicanti, alla estrapolazione del giudizio disciplinare dei magistrati dal C.S.M., dall’accesso alla funzione ai criteri per nominare i capi degli uffici, pur se tali interventi, poiché attengono all’ordinamento della giustizia nel suo complesso, avrebbero effetti positivi anche sull’amministrazione della giustizia penale (sul punto cfr. il volume curato dal Centro Studi Livatino, In vece del popolo italiano, Edizioni Cantagalli, https://www.edizionicantagalli.com/shop/in-vece-del-popolo-italiano/).
Limitando la riflessione a quel che è orientato al funzionamento del processo penale, e quindi restando nel solco degli emendamenti proposti dal Governo, è inevitabile correlare l’intervento riformatore pervenuto in Parlamento qualche giorno fa con le previsioni contenute sul punto nel PNRR-Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Punto di partenza è che l’organico della magistratura italiana è gravemente sottostimato rispetto alle esigenze della popolazione. Lo dimostrano i dati comparati: la Commissione per l’efficienza della giustizia presso il Consiglio d’Europa – Cepej, nel rapporto European judicial systems. Efficiency and quality of justice, n. 26, 2018, p. 106, rileva (con dati riferiti all’anno 2016) che in Italia sono presenti circa 10,6 giudici ogni 100.000 abitanti, cioè meno della metà della media europea (21,5) e grandemente inferiore rispetto alla mediana (17,8), comprensiva dei Paesi non membri UE (ad es. i Paesi dell’ex URSS da una parte, e dall’altra parte i Paesi di common law, ove il ruolo sociale del giudice è ben diverso, come dimostrato dal salario che a essi viene riconosciuto, triplo rispetto alla media, ivi, pag. 123).
Ciò si traduce in un sovraccarico di lavoro per ciascun magistrato: lo stesso rapporto, a pag. 140, evidenzia ad esempio che a ciascun P.M. in Italia sono affidati una media di ben 1.737 casi l’anno, a fronte di una media europea di 578. Il sovraccarico di lavoro determina il rallentamento nella decisione, e talora l’abbandono di fatto dei casi che non si riesce a seguire; il rapporto, a pag. 299, dimostra che a giudizio in Italia giungono pressoché esclusivamente i gravi reati, mentre le infrazioni minori, ma non per questo socialmente meno rilevanti, non giungono quasi mai a processo, con buona pace dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale.
In tale contesto, una riforma tesa a conferire maggiore efficienza alla giustizia penale senza in parallelo rafforzare gli organici magistratuali è fisiologicamente destinata all’insuccesso. La stessa depenalizzazione, pur necessaria per certe fattispecie, rischia di trasferire parte del carico dalla giustizia penale a uffici amministrativi inadeguati per risorse umane e strutturali, a cominciare dalle prefetture, e alla giustizia civile, competente per le impugnazioni delle ordinanze-ingiunzioni che irrogano le sanzioni amministrative, afflitta da problemi strutturali non meno gravi di quella penale. É come se, per risolvere il gran traffico di un nodo autostradale, anziché mettere in cantiere l’introduzione di una nuova corsia, si aumenti il limite di velocità, si diminuisca il tempo di permanenza nelle piazzole di sosta e si vieti ad alcuni veicoli l’accesso all’autostrada riversandoli nella viabilità ordinaria.
Le stesse carenze strutturali riguardano il personale ausiliario, essenzialmente cancellieri e ufficiali giudiziari. Il medesimo rapporto, alla pag. 163, evidenzia come in Italia sono presenti appena 35 ausiliari ogni centomila abitanti, ossia ancora una volta circa la metà rispetto alla media europea (68,7) e comunque molti meno rispetto alla mediana europea (55,2). A fronte di ciò, il PNRR a pag. 60 ha riconosciuto che “un incremento del numero dei magistrati e degli operatori del settore giustizia costituisce un fattore indispensabile, ancorché non sufficiente, per il conseguimento degli obiettivi”, ma a tal fine non contiene alcuna misura aggiuntiva rispetto a quelle ordinarie, già previste a regime a prescindere dal Piano, idonee a garantire nella sostanza l’annuale ricambio generazionale rispetto ai pensionamenti.
Il Piano ha confermato che ciò non è sufficiente «per portare il numero di magistrati in Italia in linea con la media dei paesi europei», ma non ha affrontato la questione. Esso lascia non ha dato conto che i numeri di incremento di magistrati che esso prospetta (600 unità) corrispondono all’ordinario innesto di nuovi magistrati che avviene in due annualità (circa 300 per anno), e che – come lo stesso Piano ricorda – il concorso bandito nel 2019 non si è tenuto causa Covid: dov’è il di più?
Considerazioni analoghe valgono per i cancellieri, il cui concorso previsto dal 2018 in avanti fa seguito alle esigenze di un ricambio generazionale ormai rimandato da anni e del tutto fisiologico. Il PNRR si è pertanto manifestato non adeguato rispetto alla prima esigenza che avrebbe dovuto essere soddisfatta per risolvere il problema del “fattore tempo” nei processi italiani, e la ‘riforma Cartabia’ non aggiunge alcunché.
- L’inutile ‘ufficio del processo’
Certamente non costituisce un aiuto il c.d. “ufficio per il processo”, che secondo il Piano (pp. 62-64) assorbirà larga parte dei 2,3 miliardi di euro destinati al settore giustizia, ossia «un team di personale qualificato di supporto, per agevolarlo nelle attività preparatorie del giudizio», quali «ricerca, studio, monitoraggio, gestione del ruolo, preparazione di bozze di provvedimenti». Chi abbia pratica di aule giudiziarie ha ben chiaro che ciò che serve ai giudici non è tanto un ufficio di studiosi o tirocinanti cui far svolgere ricerche giurisprudenziali, o cui affidare un primo esame dei fascicoli: è potersi concentrare personalmente su tali attività con serietà e serenità, in modo tale da emettere decisioni destinate a essere confermate negli eventuali successivi gradi di giudizio (un criterio di resistenza purtroppo attualmente estraneo ai criteri di valutazione dei magistrati).
L’“ufficio del processo” sarebbe ipotizzabile per una giustizia in ottima salute ‒ e comunque con differente configurazione ‒, non per un sistema che non ha bisogno di fronzoli, bensì di sentenze certe emesse in tempi ragionevoli. Il giudice ordinario deve trattare molte questioni e confrontare costantemente i fatti con il diritto; non deve concentrarsi su poche questioni della massima importanza giuridica, spesso scisse rispetto alla ricostruzione fattuale o processuale, come avviene per i giudici costituzionali o delle corti sovranazionali, per i quali l’ufficio processuale concettualmente nasce e si manifesta come strumento appropriato.
Dietro alla scelta di non aumentare il numero dei magistrati, ma di potenziare l’ufficio per il processo, sta una surrettizia ma profonda “revisione” del ruolo del giudice che non può essere condivisa. Il giudice comune non dovrebbe trasformarsi nel supervisore dell’attività di giovani collaboratori, cui delegare tronconi della propria attività ‒ a un componente dello staff l’istruttoria, a un altro la ricerca giuridica, a un altro ancora la scrittura della bozza del provvedimento ‒ per poi compiere la sintesi finale. Nell’attività del giudice la riconduzione in capo a una stessa persona di tutte le fasi dell’attività decisoria ‒ esame del fatto, applicazione del diritto al fatto, motivazione dei provvedimenti ‒ è fondamentale per la giustizia sostanziale delle decisioni, e costituisce la base del proficuo confronto con i colleghi nei casi in cui l’ordinamento richieda la decisione collegiale.
Ciò appare evidente per la giustizia penale: compartimentalizzare le varie attività per affidarle a diverse persone, e riservare al giudice un ruolo di sintesi equivale a scollegare le fasi del sillogismo giudiziario, a comprometterne logicità e attendibilità, a complicare la percezione complessiva della causa su cui dovrebbe basarsi la pronuncia di giustizia, e in definitiva a mettere in discussione le radici del basilare principio che ispira l’attività giudiziaria, riassunto da secoli dal brocardo “narra mihi factum dabo tibi ius”.
Di ciò lo stesso Piano sembra in qualche misura rendersi conto allorché concepisce gli “uffici per il processo” come misura straordinaria per far fronte allo smaltimento dell’arretrato, senza garanzia di stabilizzazione dei medesimi (che sarà assicurata soltanto “se possibile”, p. 63, e probabilmente non supererà il biennio di vita). Ma la crisi della giustizia in Italia è strutturale e non legata a circostanze contingenti, per cui il Piano avrebbe dovuto essere la sede per approntare misure altrettanto strutturali, ciò che invece anche sotto questo – pur inadeguato – profilo non è avvenuto. Senza dire della improcrastinabile necessità di aumentare il numero dei giudici togati anche con la soluzione dell’assorbimento graduale dei magistrati onorari, tenendo conto che nel settore, oltre ai giudicanti, opera anche un congruo numero di vice procuratori onorari.
- Per concludere
Per quanto accurate ‒ quelle degli emendamenti in discorso non lo sono ‒, le riforme dei riti non risolvono i problemi della giustizia penale se mancano giudici, uomini e infrastrutture per attuarli in modo efficiente.
La sostanza della ‘riforma Bonafede-Cartabia’ è che l’insieme delle disposizioni, le non poche che sopravvivono all’originario d.d.l. e le altre, modificate:
- non avviano a soluzione i problemi strutturali della giustizia penale in Italia, quali la carenza degli organici dei magistrati, degli ausiliari, e del personale penitenziario, e il sovraffollamento carcerario, con strutture obsolete;
- accentuano il ruolo ‘politico’ dei Procuratori della Repubblica, attraverso criteri di priorità che provocheranno la diseguale amministrazione della giustizia sul territorio nazionale;
- indeboliscono le garanzie di un giudizio concentrato e diretto, con la deroga alla immutabilità del giudice;
- confondono istituti sostanziali, come la prescrizione, con istituti processuali, come l’improcedibilità in appello e in cassazione, con prevedibile diniego di giustizia nei distretti più gravati;
- confidano nell’esecuzione penale esterna, senza dotarla di strumenti per renderla funzionale, così incrementando l’incertezza della pena, e nelle sanzioni pecuniarie, senza prevedere come recuperarle dal condannato.
Auspichiamo la più attenta riflessione del Parlamento sui profili problematici fin qui riassunti, per scongiurare che, con le risorse del PNRR destinate alla giustizia, la ‘riforma Bonafede-Cartabia’ non soltanto sia una importante occasione perduta, con la destinazione dei fondi del Recovery dove non servono, ma diventi addirittura strumento per aggravare ulteriormente le condizioni dell’amministrazione della giustizia in Italia.
* Consigliere alla Corte di Cassazione