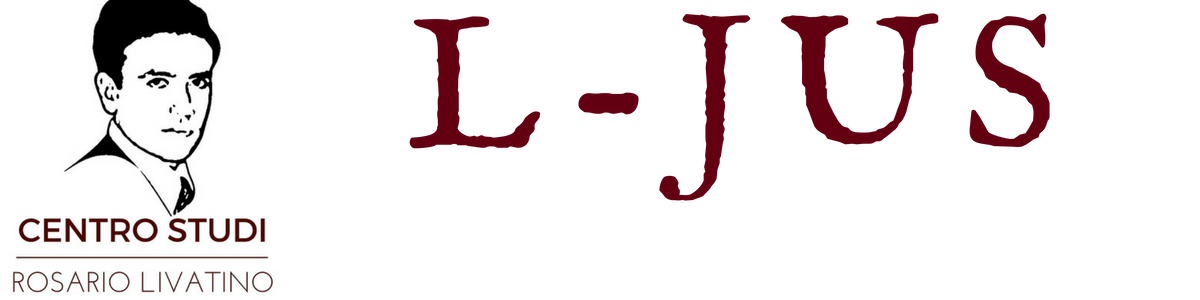Tomaso Emilio Epidendio
Sostituto Procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione
L’ORDINANZA N. 207 DEL 2018
TRA AIUTO AL SUICIDIO E TRASFORMAZIONE DEL RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE *
Sommario: 1. Premessa: ordinanza n. 207 del 2018 e tramonto della formulazione legislativa del diritto e dei diritti – 2. Sistema della legalità e sistema della giurisdizione – 3. Pangiurisdizionalizzazione e riscatto.
1.Premessa: ordinanza n. 207 del 2018 e tramonto della formulazione legislativa del diritto e dei diritti
Due constatazioni sono essenziali, a mio avviso, per affrontare un tema così delicato come quello su cui sono oggi chiamato a intervenire.
La prima è che in tutti i provvedimenti che sono stati adottati nella tragica vicenda “Cappato- DJ Fabo” – e in tutti gli interventi sul caso giuridico che si sono registrati anche in dottrina – esiste un non-detto, un sotto-testo, che coinvolge l’autobiografia degli autori dei provvedimenti e dei protagonisti a vario titolo della vicenda giudiziaria, il modo e la misura in cui essi stessi sono stati toccati da vicende in maggiore o minore misura analoghe, il modo e la misura in cui essi hanno reagito, il sottofondo emotivo che tali vicende hanno lasciato nella loro vita, e in ultima analisi le loro credenze ultime sulla vita e sulla morte, di natura religiosa, morale, etica, filosofica e ideologica.
Tutto questo non-detto “extragiuridico”, che condiziona in modo determinante le valutazioni e le soluzioni “giuridiche” che si sono date, è stato sottratto non solo al dibattito, ma anche alla estrinsecazione formale delle motivazioni giuridiche che si sono adottate, con la conseguenza che ci troviamo di fronte non tanto alle “motivazioni” ex ante che hanno condotto a individuare la soluzione giuridica, ma a “giustificazioni” ex post adottate per sorreggere una conclusione determinata da altro, con l’inevitabile conseguenza che ci troviamo di fronte, in qualche misura di fronte, a un esercizio di retorica giudiziaria, rispetto alla quale i diversi interlocutori aderiscono o meno alle argomentazioni, non tanto per la valenza delle medesime, ma sulla base della condivisione o meno di intime e profonde credenze e convinzioni ultime che rimangono inespresse, peraltro travestendo quelle che sono proprie opinioni assiologiche, politiche in senso alto, da considerazioni tecnico-giuridiche, di cui si pretende imporre la decisività in base a una pretesa neutralità scientifica e la rivendicazione di un approccio “laico” al problema che esse non hanno e non possono avere.
Quello che voglio dire è che il primo problema che pone una ordinanza come la n. 207 del 2018 è quello della traducibilità di argomentazioni filosofico-religiose in argomentazioni giuridiche, problema al centro di un noto dibattito tra le posizioni espresse da Habermas e da Taylor[1]: il problema assolutamente preliminare è, dunque, quello della stessa possibilità di un “approccio laico” alla questione dell’aiuto al suicidio condotto esclusivamente su base tecnico-giuridica.
Su questo primo problema esplicito sin da subito, proprio per evitare di incorrere in quello stesso vizio che mi propongo di correggere in altri, che credo alla impossibilità di un approccio esclusivamente laico al problema, alla irriducibilità della questione al solo piano scientifico-giuridico, alla intraducibilità nel mero linguaggio giuridico delle proprie intime convinzioni ultime sulla vita e sulla morte (e all’inopportunità di tale traduzione, proprio per evitare di travestire e accreditare di “neutralità scientifica” quelle che sono precise prese di posizione politica), credo a un surplus argomentativo che si può sviluppare – solo e adeguatamente – nei vari e differenti piani, religioso, filosofico, morale ed etico, credo alla possibilità di accogliere nel dibattito “politico” in senso alto gli argomenti afferenti a questi piani, che le “norme giuridiche” sul problema dell’aiuto al suicidio non possano trovare la loro creazione ed elaborazione solo sul piano della giurisdizione, e che gli argomenti determinanti per immaginare soluzioni a questo problema non possano svilupparsi adeguatamente solo sul piano della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, neppure se di un organo giurisdizionale sui generis come la Corte costituzionale, almeno fintanto che l’organo (che presenta indubbie componenti politiche) si esprima in “modi e forme giurisdizionali” e fintanto che non sia istituzionalmente prevista una forma di “responsabilità politica” di quest’organo quando compia scelte esclusivamente politiche (responsabilità politica che ritengo inopportuna in quanto garante supremo e per necessità a-maggioritario e che, per questo, ritengo dovrebbe condurre la Corte costituzionale ad essere particolarmente oculata e prudente nelle sue incursioni sul terreno politico, proprio per evitare che altri reclamino questa responsabilità e finiscano poi per prevederla e attribuirgliela). Né la tanto sbandierata crisi della politica, della sua rappresentatività e della sua efficacia qualitativa nell’affrontare i problemi e proporne soluzioni, può costituire un alibi per invasioni di campo da parte di altri poteri: al contrario essa deve invece costituire un’occasione di riscatto, deve essere letta come un segno che si è giunti infine al momento di un necessario capovolgimento, di rinnovamento della politica per uscire da una sua crisi ormai non più sostenibile, quanto meno perché storicamente, quando (come con la “scuola del diritto libero”) si è tentata la via giudiziaria al superamento di analoghe crisi, gli esiti degli ottimi propositi di superamento dell’insufficienza della legislazione e della politica a risolvere i problemi sociali e fornire una risposta adeguata al caso, sono stati catastrofici.
Il primo mito da abbattere per affrontare adeguatamente il tema è, pertanto, quello della stessa possibilità di un approccio “laico” e (scientificamente) “neutro” al problema: mi pare che concepire la morte come la “fine di tutto” per l’individuo o concepirla come “passaggio-trasformazione” porti a soluzioni diverse del problema e che gli argomenti per decidere dell’una o dell’altra concezione siano difficilmente spendibili sul piano della motivazione di un “provvedimento giurisdizionale”, tanto più di un’ordinanza di rinvio dell’udienza di discussione, qual è appunto l’ordinanza n. 207 del 2018.
La seconda semplice constatazione da cui partire, infatti, è quella del grande divorzio tra la forma e la sostanza che celebra il provvedimento della Corte costituzionale tema dell’incontro: l’oggetto della discussione – e di tante discussioni che vi sono state e che vi saranno – è rappresentato da una “banale” ordinanza di rinvio dell’udienza, questo il dispositivo del provvedimento, una ordinanza che, seppure della Corte costituzionale, costituisce pur sempre un semplice provvedimento di rinvio di una udienza di discussione.
Eppure, tutto può dirsi tranne che l’imponente attenzione prestata a un provvedimento di tal fatta sia ingiustificata, perché l’apparato argomentativo di questa “ordinanza di rinvio” pone in questione: i rapporti tra Corte costituzionale e Parlamento; i rapporti tra Corte costituzionale e giurisdizione comune; lo stesso modo di concepire e tutelare i diritti fondamentali, non più “diritti delle Carte (costituzionali)”, ma “diritti delle Sentenze (costituzionali)”.
Pone in questione i rapporti tra Corte costituzionale e Parlamento, perché completa l’opera di decostruzione della teorica delle “rime obbligate”, che sino ad ora in qualche modo aveva governato l’ammissibilità degli interventi manipolativi della Corte sui testi legislativi, e la sostituisce con quello che potremmo definire il sistema delle “promesse di incostituzionalità”, addirittura nella forme dell’intervento manipolativo, i cui segnali si avvertivano sin dalla sentenza sulla cd. “revisione europea” delle sentenze penali passate in giudicato, e che erano divenuti conclamati con la ormai famosa ordinanza Taricco (n. 24 del 2017), ancora una volta un’ordinanza, in quell’occasione ordinanza di rinvio pregiudiziale interpretativo davanti alla Corte di Giustizia dell’UE; un sistema delle promesse di incostituzionalità che viene annunciato all’insegna del dialogo con il Parlamento, ma che ha tutta la fisionomia di un ultimatum, come nel caso Taricco, e in questo caso addirittura con l’indicazione di un termine finale di adempimento. La Corte costituzionale dimostra, del resto, di essere ben consapevole di ciò: dopo aver esplicitato infatti l’ampio spettro di diversi interventi che potrebbero ricondurre a costituzionalità la disciplina, agendo persino su diverse disposizioni-oggetto, e avere addirittura profilato l’ineludibilità di un tale intervento[2], finisce per riconoscere esplicitamente che, in passato, in simili casi, si sarebbe dichiarata l’inammissibilità della questione con l’apposizione di un monito al legislatore. Non ci si nasconde neppure che “in assenza di una specifica disciplina della materia, più in particolare, qualsiasi soggetto – anche non esercente una professione sanitaria – potrebbe lecitamente offrire, a casa propria o a domicilio, per spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio a pazienti che lo desiderino, senza alcun controllo ex ante sull’effettiva sussistenza, ad esempio, della loro capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta da essi espressa e dell’irreversibilità della patologia da cui sono affetti, concludendo che “di tali possibili conseguenze della propria decisione questa Corte non può non farsi carico, anche allorché sia chiamata, come nel presente caso, a vagliare la incompatibilità con la Costituzione esclusivamente di una disposizione di carattere penale”. La Corte è dunque ben consapevole di superare la tradizionale teoria delle “rime obbligate” e di entrare in un campo che essa stessa ha tradizionalmente riservato al Parlamento (id est alla politica), ma si dice che l’effetto sarebbe quello di “lasciare in vita – e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un periodo di tempo non preventivabile – la normativa non conforme a Costituzione” e che, si deve fare attenzione al passaggio in quanto la Corte è altrettanto consapevole che ciò varrebbe in ogni caso di inammissibilità per assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate “un simile effetto non può considerarsi consentito nel caso in esame, per le sue peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei valori da esso coinvolti”. Non sempre quindi sono superabili le “rime obbligate” ma in tutti i casi con “peculiari caratteristiche” e che coinvolgano “valori rilevanti” (secondo un giudizio di “rilevanza” tra valori necessariamente costituzionali che non viene altrimenti chiarita. Quindi, in primo luogo, si dà per scontato che una pronuncia di “inammissibilità”, che quindi prelude un compiuto esame del merito, già contenga una valutazione di incostituzionalità (cd. accertata ma non dichiarata) e che, tale inammissibilità sia superabile in situazioni, talmente genericamente definite, da rendere la medesima Corte arbitro assoluto della loro individuazione.
Pone in questione i rapporti tra Corte costituzionale e giurisdizione comune, perché il nuovo sistema delle “promesse di incostituzionalità” pone un problema di gestione del tempo intermedio, in cui la pressione dei casi da decidere e l’impossibilità di un “non liquet” per il giudice comune, pone il problema di cosa fare in attesa che la promessa si realizzi o che intervenga la legge: la via individuata è quella della “catena” di questioni di legittimità costituzionale (altre volte risolta praticamente dal giudice comune attraverso il mero rinvio delle udienze in attesa della decisione della Corte), sulla base delle indicazioni (provvisorie?) dell’ordinanza, i cui effetti anticipatori di incostituzionalità si fanno perciò evidenti: quale giudice infatti si sentirà in cuor suo di applicare una legge su cui pende una simile spada di Damocle di una incostituzionalità accertata ma non dichiarata? La situazione è ben diversa da quella che si vorrebbe accreditare di un fisiologico vaglio di non manifesta infondatezza della legge in pendenza di questioni di legittimità costituzionale già sollevate. In quest’ultimo caso ci si trova in situazioni di perfetta simmetria tra decisioni assunte da giudici comuni che, sulla base della persuasività razionale dei contenuti dei rispettivi provvedimenti, possono decidere se sollevare o meno a propria volta incidente di costituzionalità o comunque attendere la decisione della Corte. Nel caso dell’ordinanza n. 207 del 2018, si verifica invece una palese asimmetria tra la delicata valutazione che deve assumere il giudice comune e una decisione della Corte che anticipa nei contenuti una dichiarazione di incostituzionalità, senza assumerne però la forma e i correlativi effetti, così da costituire una sorta di provvedimento pretorio o extra ordinem la cui portata si definisce più in termini di forza ed “equilibri istituzionali”, che in termini di definizione legislativa e costituzionale della sua “forza”. Così finisce per determinarsi una sorta di periodo di “sospensione della legge” prima di una sua dichiarazione di incostituzionalità, che pericolosamente tanto assomiglia a quello “stato di eccezione”, teorizzato su opposte sponde teoriche da Schmitt e da Benjamin come fondamento della “sovranità”, in cui il diritto rimane sospeso e viene lasciato spazio all’incertezza del diritto, in tal modo certificata.
Infine, pone in questione lo stesso modo di concepire e tutelare i diritti fondamentali, non più “diritti delle Carte (costituzionali)”, ma “diritti delle Sentenze (costituzionali)”;
Non più “diritti delle Carte”, fondamentali perché in esse proclamati o riconosciuti come tali in via preventiva e astratta, seppure da concretizzare poi per via giudiziale attraverso il loro “bilanciamento” (per vero incontrollabile e imprevedibile ex ante e quindi privo di una valenza euristica, per la quale possa effettivamente riconoscersi la stessa possibilità di una “certezza dei diritti” da opporre alla “certezza del diritto”), ma “diritti delle sentenze”[3], che si costituiscono e vengono ricostruiti sulla sola base giudiziaria della soluzione “giusta” che si ritiene debba essere data al “caso giuridico”, con tutti i rischi correlati a:
– una concezione emotiva e irrazionale della “giustizia” (come tale sfuggente all’argomentazione razionale), che pericolosamente ricorda molto da vicino i fantasmi della cd. scuola del diritto libero le cui buone intenzioni, di assicurare un diritto adeguato al caso al di là delle strettoie della legge, si sa poi dove siano andate a naufragare tragicamente, essendo state la base dei grandi totalitarismi del “secolo breve”. Questa difficoltà di argomentazione razionale traspare a mio avviso nel passaggio, fondamentale ma privo di un sostegno motivazionale, in cui pur distinguendo i “trattamenti volti ad eliminare le sofferenze” e i “trattamenti volti a determinare la morte”, li consideri entrambi “terapie”, conclusione certo difficoltosa già dal punto di vista terminologico, ma che comunque implica una visione assiologica particolare (se la terapia è cura di una situazione patologica, allora qui la situazione patologica non può che essere la vita stessa) alla cui difficoltà di argomentazione “giuridica” (qui gli argomenti sono prettamente di natura morale, etica, religiosa) fa da contrappeso la totale lacuna motivazionale sul punto;
– il passaggio, per potere definire ambito e portata dei “diritti”, da una “interpretazione della legge”, con il suo specifico bagaglio argomentativo consolidatosi nel nostro ordinamento da secoli di pratica giuridica, a una “interpretazione delle sentenze”, appartenente a tradizioni giuridiche diverse dalla nostra, dove vi è una strutturazione dei repertori non per “massime”, ma per “storia” dei “casi” e delle “decisioni”, e dove la prevedibilità e la stessa possibilità di una teoria dell’interpretazione delle sentenze presuppone una qualche forma di “vincolo al precedente” propria di sistemi a prevalente diritto giurisprudenziale e che, nei sistemi a prevalente diritto legislativo scritto pone più di qualche problema di ridefinizione del principio di sottoposizione del giudice alla (sola) legge.
Ebbene tutto questo è contenuto nella motivazione di una “banale” ordinanza che sorregge un dispositivo di fissazione di una data di rinvio dell’udienza.
Questo è a mio avviso il primo dato significativo, il primo dato da cui bisogna partire, il primo dato illuminante della radicale e profonda trasformazione in corso, un primo importante segnale di una rivoluzione radicale, che è segnata da questo drammatico divorzio della forma (ordinanza di rinvio dell’udienza di discussione) dalla sostanza (una sorta di anticipazione di una futura dichiarazione manipolativa di illegittimità costituzionale, non espressamente prevista dalla Carta costituzionale o da altre leggi di rilievo costituzionale).
Elegante il tentativo dell’ordinanza di ricondurre questo provvedimento ai suoi tradizionali “poteri di gestione del processo costituzionale: ossia di disporre il rinvio del giudizio in corso, fissando una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale”: è vero che il tempo della decisione ha sempre costituito uno strumento (larvato e invero incontrollato e incontrollabile) di gestione politica dell’intervento della Corte, evidenziato ormai anche in fonti manualistiche (ad es. G. Zagrebelsky-V. Marcenò), strumento che la Corte ha spesso usato, prima ancora che con il “rinvio” (presidenziale o collegiale) dell’udienza pubblica di discussione o della camera di consiglio, con la (dilazione della) “fissazione presidenziale” della data delle medesime.
Tuttavia, qui c’è una novità importante, perché alla già pericolosa e invero non regolamentata gestione politica dei tempi della decisione, si accompagna il sistema nuovo della promessa di incostituzionalità manipolative: questo è il miscuglio esplosivo che, a mio avviso, costituisce una vera e propria rivoluzione negli assetti di potere, come tradizionalmente ricostruiti, che non solo arriva a dettare l’agenda alla politica, ma a predeterminarne i contenuti.
Non si tratta di una questione secondaria, da cultori della giustizia costituzionale, ma si tratta a mio avviso di una questione fondante che si pone alla base di quella che può a buon diritto considerarsi una rivoluzione di paradigmi: proprio perché parla attraverso una ordinanza di rinvio la Corte costituzionale può dire e non dire, instaurare nuovi rapporti con il Parlamento e con i giudici, senza imporre i vincoli formali che solo da una sentenza potrebbero derivare, ma di fatto conseguendo i medesimi effetti sostanziali, in termini di condizionamento dell’operato degli altri organi istituzionali, andando ben oltre una moral suasion, e nello stesso lasciandosi aperta la strada per successive correzioni attraverso un metodo di decisione progressiva per tentativi ed errori. Un meccanismo che non esito a definire geniale, pur paventandone e rilevandone con grande preoccupazione gli effetti di tenuta sul sistema.
Per arrivare alla trasformazione sostanziale del ruolo dell’istituzione nell’ordinamento costituzionale, si passa attraverso la trasformazione formale del ruolo del provvedimento nell’ordinamento giuridico, mettendo a sua volta in crisi lo stesso ruolo del principio di legalità, e lo si fa su un “tema eticamente sensibile”, un tema per sua natura di “alta politica”, che implica prese di posizioni sulle “questioni ultime”, che coinvolge le più intime e profonde convinzioni non solo politico-sociali, ma anche morali e religiose, in definitiva il proprio rapporto con la vita e con la morte, .
Questi sono, a mio avviso, i veri temi sotterranei di discussione evocati dal provvedimento in discussione e di questo occorrerebbe a mio avviso parlare: a) la crisi del sistema della legalità, ovvero della formulazione legislativa del diritto che in un sistema a democrazia parlamentare trascina con sé la crisi della politica rappresentativa (la cd. “debolezza della politica”) e quello che ciò porta con sé: da un lato attivismo giudiziario – e in genere spostamento del potere decisorio verso strutture non elettivamente responsabili (sovranazionali, economico-finanziarie, organizzazioni non governative) – dall’altro populismo, come risposta estrema della politica alla difficoltà della rappresentatività e utilizzo del “popolo” come “significante vuoto” (Laclau); b) la pangiurisdizionalizzazione, ovvero l’attrazione nell’ambito del giudiziario di tutti i problemi sociali, personali, etici, morali e religiosi nella convinzione che tutti i problemi trovino la loro soluzione nel “processo con un giudice” – attraverso l’azionabilità giudiziaria dei diritti – e che tale soluzione abbia i connotati di neutralità della scienza, la scienza giuridica appunto, così da occultarne la natura di scelta assiologica, vale a dire politica.
Esporrò brevemente questi due temi nel corso del mio intervento.
- Sistema della legalità e sistema della giurisdizione
L’ordinanza n. 207 del 2018 rappresenta forse un punto cruciale in quello che si potrebbe definire il passaggio dal “sistema della legalità”, cioè dal sistema della formulazione legislativa del diritto, a quello del sistema della giurisdizione, vale a dire della formulazione giudiziaria del diritto: un processo da molti anni in corso, ma che adesso sembra arrivato a un punto di non ritorno, o almeno a un punto in cui non può più essere misconosciuto.
Diceva Piero Calamandrei in un breve ma illuminante scritto del 1944, Libertà e legalità, che per esercitare la funzione giuridica della società, che è quella di garantire l’ordine tra i consociati, esistono teoricamente e storicamente due sistemi, quello della formulazione giudiziaria del diritto e quello della formulazione legislativa: nel sistema della formulazione giudiziaria del diritto la funzione giuridica entra in esercizio nel momento in cui si presenta un conflitto di interessi tra i consociati, nessun diritto preesiste alla controversia e il diritto nasce soltanto in forma di sentenza giudiziaria, funzione giuridica e funzione giurisdizionale si identificano e il giudizio non si può dire un giudizio giuridico (secundum ius), ma è piuttosto un “giudizio politico che trasforma direttamente il fatto in diritto”, in base a criteri di opportunità contingente, volti a raggiungere di volta in volta l’equilibrio dei vari interessi in contrasto.
Nel sistema della legalità invece la funzione giuridica si sdoppia nella formulazione legislativa del diritto e nella formulazione del giudizio che, quando appartengono ad organi distinti costituisce il moderno Stato di diritto in cui quel “perpetuo complesso di forze in travaglio che costituiscono la vita politica di un popolo sbocca e fa leva sugli organi legislativi e non su quelli giudiziari”. Ben note erano già allora le obiezioni teoriche al sistema della legalità (non una novità dei giorni nostri dunque o un prodotto esclusivo del cd. “scandalo dell’ermeneutica” per il giurista moderno): la certezza del diritto legislativo è solo un’apparenza e il diritto è creato non dal legislatore, ma dal giudice che, nel raffrontare la legge astratta col caso concreto, formula in realtà sempre e soltanto la “giustizia del caso concreto”.
Ebbene – dice Calamandrei, in un momento in cui era ben vicina l’esperienza drammatica dei grandi totalitarismi del XX secolo – queste obiezioni non prive di una qualche fondatezza filosofica, tuttavia non tolgono valore al fatto che, dal punto di vista politico, solo il sistema della legalità può garantire la “libertà politica”, ne è condizione necessaria ancorché non sufficiente, perché non vi è dubbio che un diritto che non preesista al caso è solo arbitrio volontaristico, sia esso, aggiungo io, espressione della volontà di un singolo (sovrano o dittatore che egli sia) o di una “élite” come quella spesso evocata della “comunità dei giudici”, sorta di società illuminata e priva di confini che assicurerebbe magicamente una convergenza di opinioni, espressa anche attraverso la citazione di giurisprudenza comparata, basata su una concezione che sembra essere più aristocratica (una sorta di “società dei migliori”) che democratica, dove alla vaghezza dei fondamenti di legittimazione, fanno da pericoloso contrappeso il mancato approfondimento dei metodi di reclutamento o nomina dei componenti di tale pretesa comunità, nonché dei modi e termini in cui se ne possa far valere la responsabilità, forma di responsabilità che entra del resto in inevitabile rotta di collisione con l’esigenza di indipendenza da assicurare a organi di garanzia, a dimostrazione di una difficoltà intrinseca di un tale sistema. Del resto, afferma sempre Calamandrei che – se non vi è dubbio che il giudice ha sempre, anche quando la legge è chiara, precisa e preesistente al fatto, un certo ambito di apprezzamento per stabilire i rapporti tra le legge e il fatto – è certo altresì che questo ambito è delimitato dai termini posti dalla legge e che «è proprio questa delimitazione posta dalla legge al giudice che costituisce la maggior garanzia di certezza del diritto e della libertà». Di questo ci dovremmo ricordare in tempi in cui, anche grandi maestri, parlano di “diritto muto” o di “oltre il diritto”, in cui lo stesso valore della formulazione scritta del diritto è messo in dubbio, e dove è sempre più difficile distinguere il “diritto” dalla “sociologia del diritto”.
L’ordinanza n. 207 del 2018, infatti, non si inscrive nel sistema del bilanciamento tra diversi diritti previsti da norme costituzionali in cui il caso “illumina” per così dire il bilanciamento medesimo, in quel circolo virtuoso che va dal fatto alla norma e dalla norma al fatto, così ben lumeggiato ormai da tempo da numerosi autori e maestri. La Corte costituzionale qui non effettua alcun bilanciamento, ma individua un nuovo diritto sulla base del caso giuridico, ciò che costituisce un vero e proprio esercizio di quello che sopra, con l’aiuto di Calamandrei, abbiano definito formulazione (esclusivamente) giurisprudenziale del diritto.
La disposizione incriminatrice dell’aiuto al suicidio viene sin da subito individuata come quella selezionata dai fatti, e tale disposizione viene ritenuta (paradossalmente) legittima:[4] rispetto alla formulazione legislativa del diritto questo e soltanto questo fa la Corte costituzionale. Fino a qui siamo ancora a pieno titolo nel sistema della formulazione legislativa del diritto: i diritti sono preesistenti al caso, che serve solo a determinare l’esito dell’operazione che, specie nel caso della Corte costituzionale, non è quella della “sussunzione”, ma quella del “bilanciamento” e questo bilanciamento porta a ritenere legittima la norma espressa dalla disposizione legislativa.
Da questo punto in poi si innesta l’innovazione metodologica, preannunciata da una serie di avverbi significativi di valore avversativo[5], e questa innovazione è assai più radicale di quello che può apparire a prima vista, in quanto, pur nell’apparenza dei riferimenti alla libertà di autodeterminazione, al principio di uguaglianza rispetto alle condizioni soggettive del portatore,[6] il diritto nasce direttamente dal “caso giuridico”,[7] non preesiste allo stesso, tanto che la violazione viene ritenuta solo in riferimento al caso e modellata sul caso (sembra quasi che la Corte costituzionale operi come la Corte di Strasburgo, che non giudica sulle leggi, ma giudica e accerta violazioni, anche, in base ad applicazioni legislative nel caso concreto). Non si tratta soltanto di una ricostruzione della fattispecie costitutiva del “nuovo” diritto “fondamentale”, perciò di rango costituzionale ex art. 2 Cost., non in base a disposizioni costituzionali, ma essenzialmente in base al caso; non si tratta soltanto di questo, in quanto è la stessa violazione costituzionale che viene ricostruita in base al caso e non alla legge (sia essa ordinaria o costituzionale).
Il punto è sottile, forse ambiguo o da chiarire, ma a mio avviso determinante per comprendere la portata della rivoluzione in atto.
Alcuni hanno osservato e lamentata la manipolazione della questione di costituzionalità che la Corte costituzionale ha effettuato nella specie, rispetto a quella prospettata dal rimettente: vero, la circostanza è di palese evidenza, ma v’è di più e di ben altro; questa operazione manipolativa era in qualche modo necessaria e necessitata dalla nuova impostazione, da quella formulazione giurisprudenziale di nuovi diritti costituzionali verso la quale la Corte sembra avviarsi, svincolandosi sempre più dalla Carta e dai tradizionali equilibri istituzionali con il legislatore e con il giudice comune.
- Pangiurisdizionalizzazione e riscatto
L’ordinanza n. 207 del 2018 rappresenta, quindi, uno degli approdi più estremi di quel processo di “pangiurisdizionalizzazione” dei problemi sociali e, in realtà, anche dei problemi etici, filosofici e religiosi che vi sono sottesi. Paradossalmente essa ne rappresenta, tuttavia, in modo quasi paradigmatico tutti i limiti, sia in ordine alle possibilità di intervenire attraverso provvedimenti giurisdizionali anziché legislativi, sia in ordine alle limitazioni argomentative e, dunque, di fondazione razionale delle soluzioni prospettate.
Nell’ordinanza, infatti, si rinviene un passo significativo nel quale si riconosce che la decisione di lasciarsi morire potrebbe già essere presa dal malato sulla base della legislazione vigente.[8] Infatti, con il consenso del paziente il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, per fronteggiare sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari scelta che innesca un processo di indebolimento delle funzioni organiche il cui esito è la morte.
Il problema, per la Corte costituzionale, è che questo processo non è “necessariamente rapido” e, allora, pur avendo riconosciuto qualche pagina prima che l’ordinamento costituzionale non prevede un “diritto a morire”, occorre comunque prevedere che il medico possa «mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte trattamenti diretti, non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte» (e si badi bene, non solo le sue sofferenze, ma anche quelle delle persone che gli sono vicine, come si esplicita in altri passi).
Questo brusco passaggio dal “diritto alla cura”, comprensivo della “cura del dolore” ovvero della “cura delle sofferenze”, al “diritto di ottenere trattamenti diretti a determinare la morte” – seppure, si faccia attenzione ancora una volta, solo in presenza di una fattispecie ritagliata esattamente sul caso concreto i cui elementi costitutivi vengono snocciolati con grande precisione e, conseguente vincolo per il futuro legislatore eventuale – è accompagnato da una significativa assenza di argomentazioni, perché tutto quello che precede e tutto quello che è stato argomentato ha riguardo al diritto a “terapie” e, come già ho osservato in precedenza, a meno che non si consideri una patologia la vita stessa, non si vede come trattamenti diretti a determinare la morte possano considerarsi “terapia” o “cura”, perché si badi bene, il processo di cura del dolore e della sofferenza è cura che già provoca indirettamente la morte ed è già previsto, come osserva la stessa Corte costituzionale, dalla legislazione vigente: solo che si vuole andare oltre, si vuole assicurare trattamenti che determino la morte che altrimenti non sarebbe rapida, si vuole assicurare, contro le premesse che la medesima Corte ha posto, non tanto un “diritto a morire”, ma un vero e proprio “diritto a morire rapidamente”, un “diritto alla morte rapida”.
Si tratta di quella che, per utilizzare una efficace espressione usata da Zweig per il titolo di un suo noto romanzo,[9] rappresenta una vera e propria “impazienza del cuore”, quella compassione per la sofferenza altrui che spinge al paradosso di una eliminazione rapida della creatura per cui si prova compassione, per evitare che essa soffra, ma soprattutto che noi si soffra vedendola in quelle condizioni, perché per le sofferenze della creatura c’è già la terapia del dolore.
Come detto, si tratta di un brusco passaggio effettuato senza che le premesse consentano di inferire la conclusione (o addirittura contro le premesse che già riconoscono la presenza di una cura del dolore che determina la morte).
Il “diritto alla morte rapida”, del resto, si collega inevitabilmente a una visione che esclude la concezione della morte come processo, come trasformazione, ma che la vede come fine di tutto, un modello della “buona morte” (eutanasia) che, in quella prospettiva, non può che avere il significato di una fine rapida e indolore, che si pone come radicalmente alternativa all’ideale di una “morte buona”, caratterizzata dalla consapevolezza del valore dell’esistenza che si sta abbandonando e che implica una ars moriendi.
Collegare questa concezione al principio di autodeterminazione del soggetto è una missione impossibile perché, come è stato osservato,[10] “la morte è il nulla impensabile del soggetto”, ed è radicalmente mistero irriducibile all’empiria di una scienza, posto che biologicamente conosciamo il vivo e constatiamo il cadavere, sappiamo il prima e il poi, ma della morte non sappiamo nulla.
D’altro canto, a seconda della concezione che abbiamo – e che dipende ed è condizionata non tanto da conoscenza teoretica, ma da sofferenze ed esperienza della vita di ciascuno di noi, cioè da “conoscenza esperienziale” – cambia il senso della fine in relazione alla quale bisognerebbe porsi la domanda sul “senso che ha una soggettività che si progetta, dovendo subire la sua fine prima che possa dirsi compiuto il suo fine”: ma il diritto alla morte rapida pone proprio al centro tale quesito, se il soggetto sia giunto al compimento del suo fine, se di tale compimento non sia parte anche il processo che lo porta alla morte; perché di processo si tratta e di un processo non per “stadi”, raggiunto uno dei quali si passa all’altro, ma di un processo per “fasi” con un possibile ripresentarsi della stesse: come non pensare agli studi della Khubler-Ross nella sua assistenza ai malati terminali, ricchi proprio per questo (perché non teoria fredda, ma alimentata da esperienza di con-sofferenza) sulle fasi di avvicinamento alla morte, attraverso la “negazione”, la “rabbia”, la “negoziazione”, la “depressione” e l’”accettazione”.
Il provvedimento della Corte costituzionale non dà e non potrebbe dare risposta a tale quesito, perché la risposta non dipende da argomenti giuridici, ma religiosi, filosofici, morali, etici, argomenti su cui un giurista non ha alcuna legittimazione privilegiata e, invero, legittimazione alcuna per imporre ad altri la propria personale visione.
Il vuoto argomentativo dell’ordinanza sul punto centrale della questione è, quindi, un vuoto necessitato e coessenziale alla natura di provvedimento reso con le forme e i metodi della giurisdizione.
Questo è il primo limite del pangiurisdizionalismo all’opera nell’ordinanza n. 207 del 2018, nel quale è altresì evidente e, in qualche modo confessoria, la costruzione del “caso” ex ante che segue significativamente una autodenuncia e che pone, ad esempio, dal punto di vista procedurale, tutti i limiti di un giudizio costituzionale non costruito per tali emergenze, posto che ne restano fuori ad esempio associazioni rappresentative di posizioni opposte, laddove giudice rimettente e parti in causa sono in realtà allineate su medesime posizioni e dove, pertanto, alla già rilevata impossibilità di argomentare adeguatamente, fa da pericoloso contrappeso processuale l’assenza di un contraddittorio delle idee.
Tuttavia, si pone con altrettanta chiarezza anche l’altro limite, connesso alle possibilità di intervento che pone una decisione resa con le forme della giurisdizione, perché come si è già visto è la ragione per la quale la Corte ha comunque “promesso” ma non “dichiarata” l’incostituzionalità, ed è quindi la stessa Corte costituzionale ad evidenziare la necessità che sia il legislatore a intervenire, per apprestare tutte quelle procedure necessarie a evitare abusi nella prestazione di aiuto ai pazienti e ai familiari dei pazienti, per l’apprestamento di quelle che Ferraris chiama le “garanzie secondarie” per dare effettività alla tutela dei diritti garantiti in via primaria e che passano attraverso l’istituzione e l’organizzazione di risorse, umane e materiali, per le quali solo il legislatore e l’amministrazione sono in grado di intervenire.
Proprio questi limiti della pangiurisidizionalizzazione dovrebbero portare a riconsiderare i modi per affrontare il problema, perché il caso “risolto” dall’ordinanza non è una vittoria per nessuno ma una sconfitta per tutti: per la giurisdizione messa di fronte a tutta l’impotenza dei propri limiti, per le istituzioni in generale, la cui tenuta di sistema viene messa a dura prova da sconfinamenti e perdita progressiva di certezze sui limiti dei rispettivi poteri, per i pazienti e i loro familiari che, in assenza di una ars moriendi, sono comunque lasciati soli in quello che Cecily Saunders, fondatrice delle esperienze degli hospice, chiama il “buco nero del dolore”, del “dolore assoluto”, fisico che non lascia più neppure pensare, e morale, della paura di finire per sempre.
Ecco proprio questa sembra la via, una via invero già iniziata, ma che deve essere rafforzata, quella degli hospice e della concezione che è loro sottesa, accompagnamento e aiuto a chi muore e a chi è legato a chi muore, non fredda esecuzione di una morte rapida.
Chissà che in mezzo alla confusione delle istituzioni e delle idee, tutto questo non possa rappresentare occasione di riscatto per la politica, per riscoprire la propria funzione alta, chissà che tutto questo non possa essere occasione perché tutti noi si impari a scegliere chi possa fare politica alta, chissà che tutto questo non sia occasione perché ciascuno, persona, giudice, politico, riscopra quanto sia essenziale riscoprire il valore del rispetto dei propri limiti, chissà che dall’abisso non si possa riemergere.
* Relazione presentata al workshop “L’ordinanza n. 207 del 2018 tra aiuto al suicidio e trasformazione del ruolo della Corte costituzionale”, che si è tenuto il 22 febbraio 2019 all’Università Europea di Roma, in collaborazione con il Centro Studi Livatino.
[1] Per un primo orientamento sul tema oggetto di estesa bibliografia cfr. il numero monografico (n. 1 del 2013) della Rivista MicroMega. Utile. Pure A. Besussi, Disputandum est. La passione per la verità nel discorso pubblico, Torino, 2012.
[2] In particolare ai §§ 10 e 11 della motivazione si osserva che i vari profili sono variamente declinabili sulla base di scelte discrezionali: come, ad esempio, le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto, la disciplina del relativo “processo medicalizzato”, l’eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura, aggiungendo che «una disciplina delle condizioni di attuazione della decisione di taluni pazienti di liberarsi delle proprie sofferenze non solo attraverso una sedazione profonda continua e correlativo rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale, ma anche a traverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte, potrebbe essere introdotta, anziché mediante una mera modifica della disposizione penale di cui all’art. 580 cod. pen., in questa sede censurata, inserendo la disciplina stessa nel contesto della legge n. 219 del 2017 e del suo spirito, in modo da inscrivere anche questa opzione nel quadro della “relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico”, opportunamente valorizzata dall’art. 1 della legge medesima» e precisando ulteriormente che sarebbe necessaria «una disciplina ad hoc per le vicende pregresse (come quella oggetto del giudizio a quo), che di tale non punibilità non potrebbero altrimenti beneficiare: anche qui con una varietà di soluzioni possibili». Si prosegue poi affermando altresì che «dovrebbe essere valutata, infine, l’esigenza di adottare opportune cautele affinché – anche nell’applicazione pratica della futura disciplina – l’opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza – in accordo con l’impegno assunto dallo Stato con la citata legge n. 38 del 2010 – sì da porlo in condizione di vivere con intensità e in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza. Il coinvolgimento in un percorso di cure palliative dovrebbe costituire, infatti, un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente».
[3] Sul punto v. più ampiamente infra al § 2.
[4] La norma oggetto infatti persegue uno “scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere”, scopo la cui legittimità vale “anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita”. Inoltre, come osserva la stessa Corte essa non può ritenersi in contrasto, sempre e comunque, con l’art. 8 della CEDU, quale interpretato da numerose sentenze della Corte di Strasburgo che vengono citate.
[5] Infatti la Corte afferma «[o]ccorre, tuttavia, considerare specificamente situazioni come quella oggetto del giudizio a quo: situazioni inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali».
[6] Secondo la Corte, infatti, «il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive (art. 3 Cost.: parametro, quest’ultimo, peraltro non evocato dal giudice a quo in rapporto alla questione principale, ma comunque sia rilevante quale fondamento della tutela della dignità umana)».
[7] Recita la sentenza «[i]l riferimento è, più in particolare, alle ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli». Si tratta, infatti, di ipotesi nelle quali l’assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l’unica via d’uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all’art. 32, secondo comma, Cost. Parametro, questo, non evocato nel dispositivo nell’ordinanza di rimessione, ma più volte richiamato in motivazione. Paradigmatica, al riguardo, la vicenda oggetto del giudizio principale, relativa a persona che, a seguito di grave incidente stradale, era rimasta priva della vista e tetraplegica, non più autonoma nella respirazione (necessitando dell’ausilio, pur periodico, di un respiratore inserito in un foro della trachea), nell’alimentazione (essendo nutrita in via intraparietale) e nell’evacuazione: conservando, però, intatte le capacità intellettive e la sensibilità al dolore. Alle sofferenze psicologiche indotte dalla drammatica condizione di cecità e di totale immobilità si accompagnavano così quelle fisiche, particolarmente acute, prodotte dagli spasmi e dalle contrazioni da cui il soggetto era quotidianamente percorso. Condizione, questa, risultata refrattaria a ogni tentativo di cura, anche sperimentale ed effettuata persino fuori dai confini nazionali.
[8] Il riferimento è alla legge 22 dicembre 2017, n. 219 integrativa della legge 15 marzo 2010, n. 38.
[9] Romanzo nel quale si narra di come il sottotenente Hofmiller mosso a compassione finisca per fidanzarsi con la paralitica Edith, figlia di un ricco aristocratico ungherese, per poi pentirsene e portarla al suicidio.
[10] A. Pessina, Il soggetto e la morte, in Riv. int. di teologia e cultura, 233, 2012.